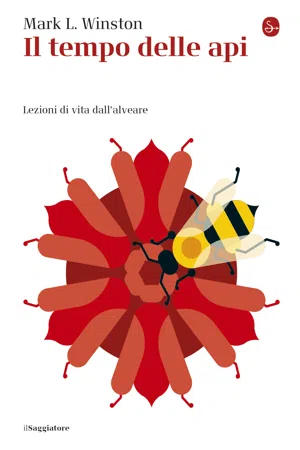![]()
Prologo
Camminando nell’apiario
Camminare in un apiario è una sfida per la conoscenza, un’esperienza emotivamente ricca, sensuale, appagante.
Il tempo scorre lentamente. La concentrazione aumenta, la consapevolezza cresce, tutti i sensi vengono catturati.
Entrando in un apiario seguo ritmi e un rituali precisi. Infilo i pantaloni negli stivali, indosso il velo protettivo, aziono l’affumicatore per tranquillizzare gli insetti. Tutte azioni di routine impregnate però di un significato più profondo, perché segnano la transizione da tutto ciò che stavo facendo prima di entrare nella modalità ape.
Mentre sollevo l’affumicatore sono completamente immerso nel presente, ma anche connesso al ricordo di amici, di compagni apicoltori e di lunghe, innumerevoli giornate trascorse in altri apiari. Momenti di noia o di grande fatica fisica e guizzi occasionali di saggezza. Attimi in cui diventavo consapevole della complessità del nostro mondo naturale, di solito insondabile, mi tolgono ancora il fiato.
Ricordo la mia prima rivelazione mozzafiato, una visita preparata a lungo che finì per rivelarsi qualcosa di completamente diverso da quanto mi aspettavo. Avevo incominciato a seguire i corsi per la specializzazione all’Università del Kansas, scegliendo il dipartimento di Entomologia perché si diceva che gli studenti svolgessero le loro ricerche ai tropici e io volevo diventate un biologo esperto di regioni tropicali. Il mio relatore aveva appena ricevuto un finanziamento per studiare le api africane nell’America meridionale. Sentendo parlare di «America meridionale» pensai che le api mi andavano bene, così nel luglio del 1976 mi ritrovai nella Guyana Francese, in procinto di entrare in un nido di api assassine.
Ero arrivato soltanto il giorno precedente, dopo un viaggio lungo e faticoso che dal Kansas, passando per Miami e poi per la Martinica mi aveva portato infine a Caienna nella Guyana Francese, e mi sentivo ancora un po’ disorientato. Fino ad allora la mia unica esperienza con le api era stata una serie di visite brevi agli apiari locali dell’università e non avevo proprio idea di che cosa mi aspettasse. Entrai in questo apiario sudamericano con addosso uno strato di vestiti sotto una tuta da apicoltore, la testa protetta dalla maschera con il velo, le mani infilate nei guanti, sperando di essere perfettamente protetto da quello che pensavo sarebbe stato un assalto di api furiose.
Spostai il coperchio della prima arnia. Le api erano sorprendentemente calme, tranquille, intente al loro lavoro. Non ci fu alcun assalto. Il mio timore svanì e incominciai a porre attenzione ai movimenti nell’arnia. Prima mi tolsi i guanti e poi la maschera. Tirai fuori i telai uno dopo l’altro per ispezionare i favi.
Fu uno di quei momenti nella vita in cui tutto cambia.
Stare in mezzo alle api è un’esperienza totalizzante. Prima senti il suono, il brusio grave prodotto da decine di migliaia di operaie che si spostano dentro le arnie e fuori, tutte impegnate a volare intorno all’apiario per trovare i propri punti di riferimento e dirigersi con sicurezza, letteralmente in fila una dopo l’altra, verso i fiori rigogliosi. Poi i sensi vengono bombardati dagli odori e dall’aspetto delle superfici, il profumo dolce della cera d’api e del miele, le resine appiccicose raccolte dalle operaie e usate per tappare i buchi e costruire la base dei favi. Infine ci sono le api stesse, che ti camminano sulle mani, sulle braccia quando sollevi e rimetti a posto i favi nell’arnia, la lieve sensazione tattile prodotta dagli uncini delle loro zampe che si aggrappano e poi mollano la presa, la brezza leggera che producono muovendo le ali prima di spiccare il volo.
A una prima occhiata l’arnia appare un luogo di grande fermento e complessità. Alcune api hanno il capo infilato nelle celle del favo e nutrono le larve. Altre usano le ali come ventagli per far evaporare l’acqua contenuta nel miele. Altre ancora si esibiscono in danze scodinzolanti per indicare alle compagne di arnia dove cercare nettare e polline nel territorio circostante. Molte sono immobili, forse perché riposano o attendono l’assegnazione di un nuovo compito da svolgere.
L’attività di gran lunga più comune è l’interazione: due api si toccano freneticamente antenne, zampe e ligule, salgono una sull’altra e fanno lo stesso con ogni altra ape che incontrano. Qualche volta si può scorgere la regina: si muove lentamente e con fare maestoso sul favo, circondata dalle operaie in attesa, e più o meno una volta al minuto inserisce l’addome in una cella per deporvi un uovo. Alla base di tutte le loro percezioni fisiche ci sono collaborazione e ordine, comunicazione e ricerca di uno scopo condiviso: ogni ape lascia che la sua individualità resti in secondo piano per il bene della colonia.
Ho trascorso una parte considerevole della mia vita negli apiari del Canada e degli Stati Uniti, della Nuova Zelanda e dell’Australia, dell’America meridionale e dell’Europa. In qualche caso erano in mezzo a foreste, circondati dalla vegetazione tropicale e dal richiamo di uccelli e scimmie. Altre volte erano sui prati alpini delle regioni settentrionali, dove le colonie venivano spostate per qualche settimana, un breve periodo in cui le api potevano bottinare approfittando delle spighe di fiori violetti del camenerio, da cui viene tratto il miele più trasparente di tutti.
Molti apiari si trovavano nei pressi di campi di colza dai fiori giallo acceso, nelle praterie canadesi dove le api bottinano a mezzanotte grazie al sole del solstizio d’estate. Altri apiari, infine, erano nascosti dietro a steccati e nei giardini sul retro delle case di città, piccole oasi per sfuggire alla cacofonia della vita urbana là fuori.
Non importa se è in una foresta equatoriale o in città, vicino a una superstrada o a ruscelli, campi, boschi suggestivi o, ancora, in un prato urbano abbandonato e pieno di erbacce. Ogni volta, entrare in un apiario coinvolge completamente tutti i miei sensi e cattura la mia attenzione.
In questi luoghi ho tratto dalle api lezioni importanti, utili per esempio per capire meglio qual è il nostro posto nella natura, per relazionarmi con la gente e gli eventi con maggiore attenzione e sincerità, per interagire più profondamente con la comunità aprendo il cuore e la mente a una consapevolezza più grande di chi siamo come individui, comunità e specie.
Non a quell’epoca, ma soltanto molto tempo dopo essermi lasciato gli apiari alle spalle ho incominciato a pensare a quei momenti come al «tempo delle api». Sono diventato nel frattempo il direttore del Centre for Dialogue della mia università e, per il mio lavoro, mi sono allontanato molto dal mondo delle api. Il mio compito è facilitare lo scambio di opinioni sui temi più complessi e sfumati che le società umane contemporanee si trovano ad affrontare. Il contesto è quello delle classi e dei seminari, dei vasti dibattiti pubblici e delle conversazioni private faccia a faccia, incentrati qualche volta su temi di rilevanza pubblica spinosi e controversi, altre volte su riflessioni più intime e personali.
Pochi anni dopo il mio ingresso in questo nuovo mondo, fondato sulle relazioni interpersonali, fui intervistato da un giornalista che, dopo aver osservato come api e dialogo non sembrassero temi collegati, mi chiese se avessero qualcosa in comune. Assolutamente sì, è stata la mia risposta. Per avviare un dialogo occorre la stessa attenzione che serve quando si entra in un apiario. In entrambi i casi viene stimolata una condizione di concentrazione profonda e di coinvolgimento di tutti i sensi: ascoltare senza giudicare.
Nel corso del dialogo il tempo rallenta proprio come accade negli apiari e, parallelamente, aumenta la concentrazione su come gli interlocutori stanno interagendo. Emerge così la comprensione, i temi affrontati si chiariscono e si collegano gli uni agli altri, e la collaborazione affiora a partire dalle intenzioni e dalle azioni di molti individui. L’individuo isolato diventa comunitario.
Nel dialogo si esercita la stessa sensibilità dell’apiario, si interpretano le situazioni, distinguendo ciò che c’è da imparare da ogni costellazione irripetibile di persone, di circostanze, di temi.
Questi momenti così rari di presente consapevolezza, in cui si comprendono a fondo le interazioni umane, anche questi sono «tempo delle api».
1. Partiamo dalle api
La storia delle api si intreccia con la nostra fin dalla comparsa dei primi esseri umani. Questi insetti, infatti, sono arrivati qui molto tempo prima di noi. Le api originariamente si sono evolute dalle vespe circa 125 milioni di anni fa, smettendo di essere predatrici per diventare cercatrici di nettare e polline.
Questi primi insetti erano solitari e nidificavano nei rami cavi o nel terreno, ed erano caratterizzati da particolari peli ramificati in cui i granuli di polline rimanevano intrappolati quando l’ape si posava su un fiore. Dai peli il polline veniva trasferito (come avviene tuttora) ad altri fiori visitati in seguito, garantendo in tal modo l’impollinazione (cioè la fecondazione degli ovuli) della pianta.
I fiori producono nettare e/o polline in eccesso per attirare le api ricompensandole con il cibo: il nettare infatti è una fonte di carboidrati e il polline è ricco di proteine. Questa innovazione evolutiva determinò un’esplosione della diversificazione e dell’abbondanza delle specie di piante con caratteristiche avanzate, che è coincisa con quella delle api e, in ultima analisi, della biosfera che conosciamo.
Oggi esistono circa ventimila specie di api, presenti quasi in ogni continente con l’eccezione dell’Antartide, che mostrano una varietà sorprendente di stili di vita. Alcune sono solitarie, altre vivono in gruppi con legami deboli, altre ancora formano società molto complesse. Le diverse specie costruiscono il nido nei suoli sabbiosi, nel terreno duro, nelle tane abbandonate dai roditori, nelle cavità di rami, fusti e tronchi. Anche il modo di bottinare sui fiori varia: alcune api raccolgono nettare e polline da un’ampia varietà di specie floreali, altre hanno una relazione fissa, per cui una particolare specie di pianta può essere impollinata da una sola specie di ape, che a sua volta si posa esclusivamente sui fiori di quella pianta.
Queste diverse specie hanno un’importanza vitale per le economie umane e il benessere mondiale perché garantiscono l’impollinazione sia negli ecosistemi agricoli sia in quelli naturali. Il loro valore economico globale per l’agricoltura è stato stimato in 217 miliardi di dollari nel 2008, in quanto circa un terzo di tutte le coltivazioni beneficia o dipende in maniera esclusiva dall’impollinazione da parte degli insetti, in particolare dalle api. Senza di esse avremmo negozi di alimentari mezzi vuoti, dato che sarebbero privi della maggior parte della verdura e della frutta, comprese noci e frutti di bosco, che ci servono per avere una dieta bilanciata e star bene.
Il valore degli insetti impollinatori per gli ecosistemi naturali è incalcolabile. Possiamo infatti stabilire quanto valgono i servizi dell’impollinazione che la natura offre alle piante coltivate, ma è più difficile monetizzare l’intera gamma dei servizi offerti dalla ricca varietà di piante che dipendono dalle api. Gli altri organismi dipendono moltissimo dalle piante impollinate da questi insetti, pensiamo per esempio al cibo e al riparo che le piante offrono a numerosi animali selvatici, alla conversione del diossido di carbonio in ossigeno, un processo che rende l’atmosfera respirabile e adatta a sostentare la vita sulla Terra, al ruolo che le piante rivestono nel rendere più stabile il suolo e prevenire l’erosione, e in molte altre funzioni.
Forse, per quantificare l’importanza delle api per la natura nel suo complesso possiamo considerare quanto sia elevata la dipendenza delle piante più avanzate (le angiosperme) dall’impollinazione. Jeff Ollerton, che studia Valutazione degli ecosistemi all’Università di Northampton, segnala che il 20% di tutte le angiosperme può essere impollinato esclusivamente dalle api, mentre un altro 45% è impollinato dalle api ma anche dal vento o da altri animali, in particolare coleotteri, falene, farfalle, uccelli e pipistrelli. Ciò significa che il 65%, vale a dire 229000 delle 352000 specie attualmente conosciute di angiosperme, ha bisogno delle api per l’impollinazione o trae vantaggio da esse.
Chiaramente un calo significativo delle popolazioni di api, di qualsiasi entità, ha dunque ripercussioni che vanno ben oltre la scomparsa di questi insetti. Un mondo senza api sarebbe pressoché impossibile da immaginare e, tanto per cominciare, probabilmente non avrebbe mai permesso l’evoluzione della nostra specie.
La varietà di insetti selvatici affini alle api, i cui stili di vita e abitudini affascinano chiunque sia appassionato di storia naturale, è sorprendente. Tra i miei favoriti ci sono gli euglossini, o api delle orchidee, insetti grandi e dalla lucentezza metallica che producono un ronzio assordante mentre volano nella vegetazione tropicale in cerca di particolari fiori di orchidea, in quanto ogni specie ne impollina solo un tipo ben preciso. Una delle loro caratteristiche più notevoli è il fatto che i maschi si impregnano del profumo dei fiori e lo usano poi per attirare le femmine.
All’estremo opposto delle zone climatiche terrestri ci sono i bombi, comuni alle latitudini temperate, ma presenti anche ad alta quota nelle zone alpine e fino a 960 chilometri circa dal Polo Nord, nelle lingue di terra più settentrionali in prossimità del Mar Glaciale Artico. Questi insetti si sono adattati meravigliosamente ai climi freddi perché riescono a volare quando la temperatura si avvicina al punto di congelamento e sono perfino in grado di sopravvivere nella n...