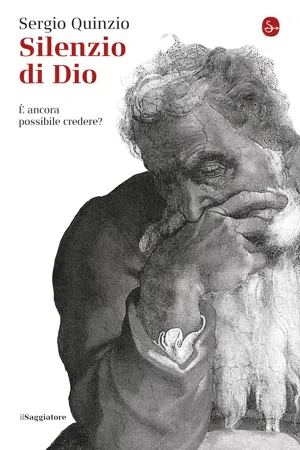![]()
1. Il ritorno del sacro
Ieri una cosa poteva sembrare certa: che la religione, il sacro, appartenesse al passato dell’umanità, all’infanzia del mondo. Oggi non più. La chiarificatrice certezza, sulla quale tante altre orgogliose certezze moderne erano fondate, si è ormai perduta.
Della situazione ultima, che registra la nuova attrazione esercitata dal sacro nelle sue diverse forme e manifestazioni, la rinnovata fascinazione dell’antico fascinans, ci sono molti segni e molte prove, e basta indicare qualche punto per rendere evidente il fenomeno e mostrarne le dimensioni.
Gli studi sulle religioni e sui miti lasciano trasparire sempre più nettamente, come loro motivazione profonda, una nostalgia del sacro che sta in equilibrio spesso precario con l’interesse scientifico: un documento esplicito in questo senso è il Giornale di Mircea Eliade, uno dei massimi storici delle religioni. La ricerca etnologica, da parte sua, in pochi anni ha rovesciato completamente la secolare costruzione del razionalismo occidentale: se i remoti e più o meno «primitivi» mondi sacrali erano stati compresi come casi particolari e minori all’interno del grande sistema della moderna ragione profana, l’etnologia ha finito per vedere il profano Occidente moderno, nei confronti dell’universale orizzonte sacro comune a tutti gli altri popoli, come un’eccezione marginale, e in definitiva colpevole, dal momento che si è posta come un riferimento assoluto in base al quale ha preteso di giudicare tutto il resto.
Il pellegrinaggio in Oriente di Hesse è diventato, specialmente fra i giovani, un modello diffusissimo, che si oppone frontalmente al modello occidentale dell’impegno e dell’efficacia storica al quale obbedivano le generazioni precedenti, completamente distaccate da qualunque atteggiamento venerabondo e contemplante. La droga, che nei primi decenni del secolo attraeva uomini «d’avanguardia» come René Daumal in quanto «esperienza superprofana», è arrivata alle porte delle scuole e spesso purtroppo le ha varcate. L’interesse per l’astrologia e per i più svariati fenomeni parapsicologici è ovunque presente e crescente. Nel Giornale, Eliade afferma: «L’uomo moderno, radicalmente secolarizzato, si crede o si vuole ateo, areligioso, o almeno indifferente. Ma si sbaglia. Non è ancora riuscito ad abolire l’homo religiosus che è in lui. Una società areligiosa non esiste ancora (io credo, per conto mio, ch’essa non possa esistere, e che se si realizzasse perirebbe in capo a qualche generazione, di noia, di nevrastenia o mediante un suicidio collettivo…)». E ancora: «Il declino del cristianesimo s’accompagna con una “apertura” verso altre forme religiose, arcaiche e tradizionali». «In California, migliaia di studenti e, in generale, i giovani dei due sessi, dopo l’esperienza della mescalina o dell’Lsd si rivolgono verso i riti tribali (nordamericani o indù).» Secondo Eliade l’Oriente sacro e in genere l’universo spirituale dei popoli del «terzo mondo» starebbero addirittura conquistando l’Occidente: si starebbe ripetendo sotto i nostri occhi la vicenda espressa dall’antico detto: Graecia capta ferum victorem cepit; o quella che, con il Rinascimento, fece rifluire la vita in Europa aprendola alla scoperta di un altro più vasto mondo, che allora era il mondo classico.
Attraverso Heidegger, Jung, Adorno e Horkheimer, il sacro (o almeno l’esigenza del sacro) è entrato, e non dall’ingresso di servizio, nella filosofia, nella psicologia, nella sociologia, o piuttosto si dovrebbe dire che ha allargato quei mondi al di là dei loro confini contribuendo a dissolverli. Fenomeno anche più significativo è l’inatteso ritorno al sacro di quei teologi che anni fa più autorevolmente si erano battuti in favore della radicale secolarizzazione, come Cox e Van Buren. E intanto, all’estremo opposto della teologia, l’esigenza del sacro si fa largo e avanza anche all’interno della società sovietica, che in certo modo rappresenta il culmine della pretesa profana moderna: un’anima religiosa, infatti, agita evidentemente una parte almeno, ma certo non trascurabile, del dissenso russo, come dimostrano i nomi di Solženicyn e di Sinjavskij, mentre in diversi paesi il «neomarxismo», allontanatosi dalla vecchia prospettiva, sente di doversi seriamente confrontare con l’istanza religiosa, come dimostrano i tentativi di Kołakowski, Machovec, Garaudy.
I sociologi Luckmann e Berger, seguiti poi da Greeley, hanno affrontato la questione della persistenza nella società attuale della religione, che anni fa la sociologia dava senz’altro in via di irrimediabile emarginazione e scomparsa. Luckmann ha sostenuto che soltanto le forme istituzionali della religione sono incompatibili con la civiltà contemporanea, non l’intimo contenuto sacro. Si sarebbe verificato cioè un passaggio della religione dalle forme sociali tradizionali a una forma nuova, «non specifica», «privata», e per questa ragione constatare con le statistiche alla mano il declino della religione nel senso ecclesiastico, non legittimerebbe in alcun modo la deduzione che il sacro stia estinguendosi. Berger, più sottilmente, ha affermato che la relativizzazione delle credenze nel «soprannaturale» operata dalla ragione moderna mediante la sociologia, riducendole cioè alle condizioni ambientali dalle quali sono sorte, per essere coerente deve giungere fino a relativizzare allo stesso modo e allo stesso titolo anche la sociologia, e quindi la sua pretesa di considerare la religione alla stregua di un costume ormai caduto in disuso: «Uno dei vantaggi liberatori della prospettiva sociologica è dato dal fatto che la relativizzazione, spinta alla sua ultima conseguenza, si rivolge su se stessa. I relativisti sono relativizzati, gli scalzatori sono scalzati e, a dire il vero, la stessa relativizzazione resta in certa misura liquidata».
Dunque: ritorno al sacro. Ma che cosa veramente sia ciò che ritorna, e che cosa implichi, e come si debba giudicare l’avvenimento, resta molto oscuro. Intanto, il sacro affiora nei luoghi più disparati e anche nelle forme più aberranti. Eliade, per esempio, riconosce il ritorno del sacro nel mito dell’arianesimo hitleriano, nel divismo del mondo dello sport e dello spettacolo, nell’ossessione del successo in quanto impulso inconscio a trascendere i limiti della condizione umana, nell’avanguardia artistica e letteraria con la caratteristica funzione redentrice e iniziatica della difficoltà della moderna opera d’arte, o con la regressione all’informale, alla condizione primordiale della materia prima e bruta. Luckmann, da parte sua, riconosce la religione nel «vasto assortimento» delle rappresentazioni oggi simbolizzanti «il fenomeno socio-storico dell’individualismo», essendosi per l’uomo moderno la «significanza ultima», e cioè il suo universo sacro, venuto restringendo alla «sfera privata» (con la conseguente «disumanizzazione della struttura sociale»). Numerosi altri autori incontrano adesso elementi sacrali e religiosi un po’ dappertutto. Per il più recente Cox, più o meno tutto è religione, perché sarebbe religiosa qualunque società che costituisce la propria identità legando insieme gli uomini in valori comuni, e che ricalca con risposte nuove gli eterni problemi del male, della salvezza, della felicità. Qualche sociologo, come M. Novak, giunge persino a scoprire la religiosità nella coscienza scientifica e professionale della classe intellettuale-manageriale americana…
È difficile immaginare una situazione più confusa. Attingendo alle indistinte acque della marea montante, che di chiaro rivela solo il rimpianto e quindi il bisogno di qualcosa che era o sembrava definitivamente morto e sepolto, ciascuno trae conseguenze a modo suo. Secondo alcuni le nostalgie sacrali sono lontane dal poter garantire una vera ripresa delle religioni in una società che resterebbe comunque caratterizzata da una radicale profanità, da un fondamentale disinteresse per la religione. Fra quelli che credono invece nella potenza storica del ritorno del sacro, c’è chi lo vede come una via salvifica che dopo le aberrazioni moderne ci riporterà al recupero di antichi irrinunciabili valori, o sic et simpliciter al ritorno all’alveo tradizionale della fede cristiana e cattolica; e c’è chi lo teme come un rigurgito di pericolosi assoluti medievali.
Per cercare di vedere con un minimo di chiarezza, è necessario io credo distinguere anzitutto fra nostalgia del sacro (e sua parziale sopravvivenza distorta) e possibilità storica di autentica rinascita. Non c’è nessuna ragione per pensare che ciò che si è perduto e di cui si ha nostalgia sia anche ciò che è realmente possibile riavere; anzi, di regola si ha nostalgia proprio di ciò che non può ritornare, come l’infanzia. Il sacro che oggi attrae è di solito un sacro nostalgicamente rimpianto, spogliato dei suoi elementi tragici e cruenti che la sensibilità moderna ha respinto e continua a respingere, e rivestito di un’aura sentimentale. Ma è soprattutto necessario distinguere – ancora sulle orme di Eliade – una sacralità di tipo cosmico, in cui vige un tempo ciclico con i suoi eterni ritorni (per esempio, i cicli stagionali con le loro ritualizzazioni e mitizzazioni), e una sacralità di tipo storico, in cui vige un tempo lineare che procede verso una definitiva meta finale (l’attesa messianica del profetismo ebraico e la tensione escatologica delle prime comunità cristiane).
È il contrasto che già i poeti Hölderlin, Heine e Rilke vivevano fra mondo religioso ellenico e mondo religioso ebraico. Ebbene, se si considera globalmente il fenomeno dell’attuale ritorno al sacro, esso appare anzitutto come un ritorno alla sacralità cosmica. Il sacro che esercita una così potente attrazione su Jung o su Heidegger, su Hesse o su Eliade, o su Simone Weil, come pure su tanti dei nostri giovani, è il sacro dell’Oriente, di mistica immersione nel cosmo divino, non il sacro storicamente incarnato dell’Occidente cristiano. L’esigenza che si manifesta è quella di uscire dal «terrore della storia» (Eliade), quella storia che ieri appariva come il cammino infallibilmente ascendente dell’«evoluzione» e del «progresso», per attingere la liberazione in una suprema coincidentia oppositorum che vanifica in un unico indefinito, ineffabile senso quello proprio di ogni singola esistenza umana.
Ma dire questo significa dire che il ritorno del sacro coincide oggi con il fallimento storico e l’abbandono del cristianesimo. Il movimento di ritorno al sacro si svolge infatti fondamentalmente in senso centrifugo rispetto alla tradizione cristiana, e anche quando intende restare nell’ambito cristiano accentua di regola quegli aspetti di mistico appagamento che stanno agli antipodi della tensione verso la trasformazione escatologica della realtà. Lo mostra, per esempio, il diffondersi dei gruppi carismatici e di preghiera, di vita comunitaria fra i giovani. È significativo che i vasti movimenti latino-americani ispirati dalla «teologia della liberazione», tesi alla redentrice trasformazione del mondo, si pongano al contrario proprio come negazione di qualunque sacralità misticheggiante che si presenti come verticale superamento anziché come risoluzione dei concreti problemi esistenziali degli uomini. Naturalmente, nella confusione dominante prospera ogni sorta di ibrido, ma le tendenze di fondo sono abbastanza chiaramente riconoscibili nella polarità fra «religione cosmica» e «religione storica», e cioè fra la dissoluzione mistica nella sacralità di tipo orientale e l’impegno storico, sociale e politico in nome della fede cristiana, spesso ormai non più distinguibile dall’analogo impegno laico, profano e mondano.
C’è tra la fede cristiana e il sacro di ogni religione più o meno «naturale», se non necessariamente opposizione come c’è secondo la teologia protestante da Lutero a Barth, almeno una profonda tensione, che i lunghi secoli dell’ellenizzazione culturale e della romanizzazione istituzionale del cristianesimo hanno nascosto. Mentre il sacro cosmico è per sua natura insuperabile, perché è il fulcro della ruota dell’universo che eternamente gira nel suo moto senza principio e senza fine, il sacro storico che è in definitiva il sacro ebraico-cristiano (sebbene attraverso l’ellenizzazione sia stato poi rivestito di forme cosmiche come per esempio l’anno liturgico) è destinato a finire. In tale prospettiva, infatti, il sacro si snoda lungo un segmento rettilineo – la «storia della salvezza» – che va in una direzione precisa e verso una precisa fine. Nella futura realtà escatologica in cui Dio sarà perfettamente manifestato non ci sarà più nulla di profano, e perciò scomparirà anche la distinzione fra sacro e profano, non ci sarà più nessun ambito sacrale separato, delimitato, privilegiato. Il profeta Isaia dice che «la terra sarà riempita della conoscenza della gloria del Signore come le acque riempiono il mare» (11,9), e il profeta Zaccaria dice: «In quel tempo, anche sopra i sonagli dei cavalli ci sarà scritto: “sacro al Signore”… E ogni marmitta di Gerusalemme e di Giuda sarà sacra al Signore» (14,20-21). La fede cristiana nasce come attuarsi di queste profezie bibliche, come compiersi cioè della fine del sacro. Gesù annuncia: «L’ora viene, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità», e non più in qualche particolare luogo sacro, come il monte Garizìm o il tempio di Gerusalemme (Vangelo di Giovanni, 4,20-23). Dio sarà «tutto in tutti» (Prima lettera ai Corinzi, 15,28). Nella Gerusalemme messianica che nell’ultimo giorno secondo la visione dell’Apocalisse scenderà dal cielo sulla terra non c’è più nessun tempio (21,22), proprio perché la stessa inattingibile maestà divina abiterà fra gli uomini; anzi, il Signore «farà mettere a tavola i suoi discepoli e passando dall’uno all’altro li servirà» (Vangelo di Luca, 12,37).
Dunque, il ritorno del sacro non è affatto un ritorno alla fede cristiana, ma è piuttosto il primo vero segno di un’età postcristiana, di cui a torto era stata considerata segno la secolarizzazione moderna, che è in realtà scimmia della cristiana fine escatologica del sacro. Come da più parti è stato visto, tutto il mondo moderno con la tensione che lo spinge verso un futuro di redenzione della condizione umana – attraverso la scienza, la tecnica, il progresso, la rivoluzione – si svolge proseguendo il solco tracciato dal cristianesimo. L’opposizione tra fede cristiana e mondo moderno sussiste, ma è l’opposizione fra due realtà appartenenti a uno stesso orizzonte, in stretto rapporto fra loro, perfettamente confrontabili. Le antiche civiltà statiche e senza futuro erano costruite sul fondamento della religione cosmica, che vedeva l’eterno nel chiuso movimento dell’identico che fatalmente ritorna; il dinamico mondo moderno è unico e diverso nei confronti di tutti i mondi antichi, proprio perché ha il suo fondamento nella religione storica, orientata al futuro messianico. Il moderno attuarsi in senso profano della volontà redentrice originariamente cristiana, in quanto è venuto storicamente in luogo del «regno di Dio» atteso invano dai primi cristiani, è la fine storica del sacro. Il ritorno del sacro è perciò il conseguente, completo, radicale abbandono della prospettiva cristiana, per ritornare a monte, alla sacralità cosmica precristiana, pagana.
Ma è possibile all’uomo contemporaneo, di fronte alla crescente minaccia di catastrofi e al dilagare di un incontenibile e disorientante pluralismo, sfuggire al «terrore della storia» per ritrovare – come vorrebbe Eliade – la realtà fresca, aurorale, del mattino del mondo e distendersi in essa con pace? È possibile riattingere il perduto orizzonte globale del sacro? Non lo credo. Credo che il ritorno del sacro non sia altro che un vano impulso della nostalgia, prezioso, ma solo come sintomo della tragica condizione dell’uomo contemporaneo.
![]()
2. Quale fede?
I frequenti viaggi continentali e intercontinentali di Giovanni Paolo ii suscitano entusiasmi enormi. Applausi e consensi di masse sterminate, ovunque. La chiesa, che appena qualche anno fa sembrava vittoriosamente assediata dalla cultura e dal costume moderni, appare improvvisamente trionfante. Se nell’ottica occidentale la chiesa, o il cristianesimo, risultano minoritari, nell’ottica planetaria, con i popoli del terzo mondo che avanzano, assumono automaticamente una posizione di guida, esercitano la potente attrazione di un’autorità carismatica, l’unica rimasta in un mondo sempre più massificato e burocratizzato. Tutto quello che di volta in volta, nel giro di pochi anni, sembrava acquisito è di nuovo messo in discussione: la supremazia dei modelli occidentali, insidiata dal ritorno del sacro, si riaffaccia in questo rinnovato, e planetariamente rilanciato, ruolo di suprema autorità carismatica del papa romano.
Alcuni, molti anzi, intravedono già un mondo ricristianizzato, un definitivo e più felice medioevo esteso a tutto il pianeta. Le voci perplesse, critiche, contrastanti sono poche, eccezioni rare ma forti e amare. Ecco cosa ha scritto Jacques Madaule, commentando su Le Monde la visita del papa in Francia («Où sont les progrès de l’amour?», 13 giugno 1980): «Questo papa a tutti familiare, questo papa che ha il dono di far sentire la sua presenza alle folle immense che la nostra epoca è capace di riunire, parla a esse, gli occhi negli occhi e nel modo più diretto, un linguaggio che hanno già mille volte udito e che si conferma di una perfetta impotenza a cambiare qualcosa nell’attuale miseria umana. Non parlo della miseria causata dai flagelli naturali, ma di quella causata dalla malizia degli uomini e dal fatto che per loro è molto difficile, più difficile che mai, amarsi gli uni con gli altri… Senza dubbio, il papa non conosce altro linguaggio al di fuori di quello che parla. Non ha nient’altro da dirci se non le verità che, lungo la storia, si sono dimostrate così poco efficaci. È questo, molto più che il progresso dei lumi, ad allontanare tanti cuori da una religione di cui si è persuasi, forse a torto, che fosse nei secoli passati oggetto di un’adesione pressoché universale. Allora si è cercato altrove, e per un momento si è persino creduto d’aver trovato. Ci si accorge adesso, in questa fine di secolo, che nulla, assolutamente nulla era stato acquisito. È a questo punto che appare il bianco pellegrino che ha sulle labbra le parole troppo conosciute. Forse ci si attende da lui qualcosa che non sia soltanto parole; dei gesti che mostrino che non porta sulle sue forti spalle solo il peso di tutte le chiese, ma anche quello della miseria umana, dell’immensa, dell’insondabile miseria umana, di tutti quelli che nel momento stesso in cui il papa parla muoiono di fame nei campi di rifugiati o nelle steppe dove sono nati; di tutti quelli che gemono nelle prigioni e nei gulag; di tutti i torturati; di tutti quelli che muoiono sotto le pallottole di un plotone d’esecuzione o d’un servizio d’ordine brutale. Il male è dappertutto e la misericordia in nessun luogo… Tale è il presente stato della famiglia umana. Un giorno il Cristo ha gridato dinanzi a una folla affamata: “Ho pietà di questa folla”. Quante centinaia di milioni di uomini oggi fanno pietà in ogni parte del mondo! Bernanos amava parlare della “dolce pietà di Dio”. È un’eco umana di questa pietà infinita che avremmo voluto percepire più chiaramente nei giorni della visita del papa. Ma è necessario credere che questo Dio pietoso è un Dio profondamente nascosto. “Veramente” come ha detto il profeta Isaia “tu sei un Dio nascosto!”».
Nello scrivere questo libretto per sostenere oggi la proponibilità della fede cristiana, intendo rivolgermi a chi è consapevole del carattere drammaticamente problematico per l’uomo contemporaneo della domanda circa la fede, quale risulta dalle frasi di Madaule che ho riportato. Non ho niente da dire a chi applaude soddisfatto, a destra o a sinistra. N...