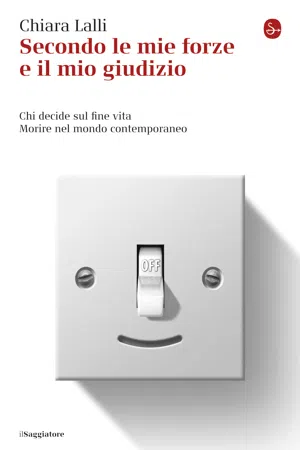1. Panorama normativo e costituzionale
Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio.
Giuramento di Ippocrate1
Ippocrate
«Non potete pretenderlo dai medici, il giuramento di Ippocrate lo vieta!» Non è raro che qualcuno provi a usare questo argomento quando si discute di interruzione volontaria di gravidanza o di fine vita. Il tentativo è destinato a fallire, e per rendersene conto basterebbe avere un’idea approssimativa del giuramento invocato.
Come possiamo appellarci a un testo redatto secoli e secoli fa? Come si può credere che possa adattarsi alla medicina di oggi? Per quali ragioni e finalità è stato formulato?
Ispirato al pitagorismo, il giuramento di Ippocrate «è scritto a partire da un tratto sociale forte che caratterizza la medicina di Ippocrate; esso è in gran parte basato sulla relazione allievo-maestro che sostituisce i legami familiari e da cui il sapere medico origina e costituisce un nucleo “corporativo” che caratterizza l’agire del medico indipendentemente dagli influssi filosofici e culturali esterni».2 Ecco le prime due spie dei profondi cambiamenti rispetto a oggi: il rapporto impari tra allievo e maestro come modello relazionale e la difesa della corporazione.3
L’adesione al giuramento era destinata principalmente a salvaguardare il prestigio della professione e a difendere la classe medica da rischi e discredito. La prescrizione del comportamento da tenere non riguardava solo il segreto professionale, ma anche il contegno del medico: un bel colorito, modi gentili e moderati, non troppo gaio. I dettami comportamentali servono a distinguere il medico dal ciarlatano e a impedire agli impostori di screditare i possessori della τέχνη.
Il giuramento è più un’iniziazione per preservare l’arte medica che un patto etico nell’interesse dei pazienti, se vogliamo includere in quell’interesse la loro volontà.
In questa visione arcaica, un buon medico è colui che applica i principi condivisi dalla scuola medica e che sa fermarsi quando si rende conto che la sua competenza non è abbastanza solida da vincere la forza della natura.
Sarà Galeno a soffermarsi sull’aspetto morale del medico: mantenere la salute è il suo compito medico e morale. Tuttavia, il medico è «detentore di un sapere assoluto e di un alto ruolo sociale che rende difficile, se non impossibile, la comunicazione con i suoi pazienti».4
Secondo Galeno, i pazienti sono testimoni inaffidabili perché mentono per paura della medicina o del medico e per non rivelare particolari segreti della propria esistenza. È difficile immaginare un rapporto alla pari tra il medico e il paziente considerati, rispettivamente, come onnisciente e menzognero.
Questo modello paternalistico della medicina e del rapporto medico-paziente5 è predominante fino al XIX secolo. La deontologia medica, nei secoli, si arricchisce di contributi e generi letterari e di influenze filosofiche, politiche e sociali.6
La strada verso l’affermazione dell’autonomia è ancora molto lunga e sarà il pervertimento della medicina compiuto dal nazionalsocialismo nei campi di concentramento a dare la spinta verso la necessità di ottenere il consenso da parte del paziente.
Il Medical Ethics di Thomas Percival, pubblicato nel 1803 e poi adottato come codice etico dall’American Medical Association7 nel 1847, è ancora caratterizzato da una visione paternalistica. Non c’è spazio per la volontà del paziente e per la sua decisione.
I medici dovrebbero, dunque, assistere il malato con la dovuta consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo; considerando che il benessere, la salute, e le vite di quelli che sono loro affidati dipendono dalle loro capacità, attenzione e accuratezza. Dovrebbero inoltre esaminare la propria condotta, così da bilanciare la dolcezza e la fermezza, la compiacenza e l’autorità, in modo da suscitare nelle menti dei loro pazienti gratitudine, rispetto e fiducia.8
Verso il Codice di Norimberga
Non è stato solo il nazionalsocialismo a compiere crimini in nome della medicina e della ricerca, ma la contaminazione compiuta nei campi di concentramento è stata una delle più organizzate e pianificate. «Monsters or Medical Leaders?», così Kevin B. O’Reilly intitola un paragrafo di un articolo pubblicato su Amednews, «Nazi War Crimes Provide Lessons in Medical Ethics».9
Robert Jay Lifton10 ha raccontato l’orrore della medicina durante gli anni del nazismo. Le uccisioni, le torture, le sperimentazioni eseguite senza consenso e spesso senza alcun senso epistemologico e metodologico. Il peso di quei ricordi è talmente gravoso che ancora oggi, ogni volta che si discute, è necessario sforzarsi per ricordare quale fosse il nodo centrale: l’assenza del consenso. Di più: l’assenza dell’idea stessa di consenso. I prigionieri o quanti ritenuti deboli o unfit erano cavie perfette, meglio dei topi e dei conigli, e come cavie erano considerati, forse ancor meno. Disumanizzati, ridotti a pezzi componenti un sistema destinato a offrire chissà quali risposte. Sacrificati in nome di un benessere della Razza, del Popolo o della Nazione, cioè di un’entità sovraindividuale che avrebbe giustificato ogni nefandezza.
Ancora oggi quel peso grava su alcune parole, talmente intrise di ripugnanza morale da evocare un’immediata reazione di condanna, come «eugenetica» ed «eutanasia».11 Mi soffermo brevemente su questi due termini perché sono utili sia per chiarire la differenza concettuale tra passato e presente (dovremmo usare espressioni diverse?), sia come esempio di quel pervertimento che ha poi reso urgente cambiare il corso del rapporto tra medico e paziente.
Eugenetica
L’ideologia razziale si è espressa in molteplici forme. La cosiddetta eugenetica negativa ha toccato atrocità inimmaginabili: per non diffondere impurità, la sterilizzazione12 sembrava un metodo perfetto.
Gli individui in buone condizioni fisiche potevano essere sfruttati per lavorare invece che essere eliminati, a condizione, però, che fosse loro impedito di trasmettere il sangue impuro alle generazioni future, propagando così l’infezione razziale. La legge sulla sterilizzazione (ovvero la legge sulla prevenzione delle tare ereditarie del luglio 1933)13 aveva permesso e giustificato la sterilizzazione chirurgica di mezzo milione di cittadini tedeschi considerati indegni di riprodursi. In questa prima fase, il progetto di igiene razziale era costato quattordici milioni di Reichsmark: troppo per ampliare la sterilizzazione al mondo. L’obiettivo era di trovare un modo economico e veloce per passare alla sterilizzazione di massa. I campi di concentramento erano il luogo ideale per testare metodi alternativi alla costosa chirurgia: erano infatti disponibili cavie umane, su cui sperimentare in assenza totale di limiti morali.
Il Blocco 10 di Auschwitz era composto principalmente da prigioniere. Era un luogo inaccessibile agli sguardi esterni e al suo interno si consumavano crimini atroci camuffati da esperimenti medici e scientifici. Le condizioni di vita nel Blocco 10 erano migliori delle condizioni dei lager, perché altrimenti il materiale da esperimento non sarebbe stato adatto. Le cavie non dovevano morire prima di avere svolto il compito assegnato loro. Una parte del Blocco 10 era esclusivamente destinata alla ricerca sulla sterilizzazione. La principale autorità medica in questo settore era Carl Clauberg, sostenuto da Heinrich Himmler nella ricerca di un metodo economico ed efficace di prevenzione delle tare. Clauberg usava un metodo sperimentale: iniettava una sostanza caustica nella cervice uterina allo scopo di ostruire le tube di Falloppio. Scelse donne diverse per età e costituzione, con preferenza verso quelle che avevano già avuto figli. A tutte effettuava diverse iniezioni nel corso di alcune settimane per provocare occlusioni e danni all’apparato riproduttivo, che poi verificava tramite radiografie. Molte di queste donne morivano a causa delle infezioni causate dalla somministrazione. In una lettera scritta a Himmler emergono gli obiettivi criminali della ricerca di Clauberg, intrisa di ideologia politica; Clauberg sottolinea in particolare l’importanza della politica demografica negativa e la possibilità di sterilizzare senza interventi chirurgici donne «indegne» di riprodursi: la sterilizzazione eugenetica per mezzo di farmaci.
Un altro programma di sterilizzazione di massa venne portato avanti da Horst Schumann tramite i raggi X. In poco tempo e con una spesa molto bassa potevano essere sterilizzate molte persone: l’ideale per preservare gli ebrei in grado di lavorare, impedendo loro di riprodursi. L’esperimento prese il via nel Blocco 30 di Birkenau, in cui i soggetti sperimentali – spesso all’oscuro di ciò che stava per accadere – venivano fatti entrare in una sala di attesa, introdotti uno per uno nel laboratorio e sottoposti ai raggi X. Le donne venivano schiacciate tra due lastre che comprimevano la schiena e l’addome prima di subire le radiazioni; gli uomini poggiavano i testicoli e il pene su una speciale lastra. Molto spesso le donne riportavano gravi ustioni e sintomi di peritonite. Qualche tempo dopo le ovaie erano asportate chirurgicamente, con un intervento invasivo e grossolano che implicava complicazioni di varia natura: emorragie, infezioni, morte. L’intervento durava pochi minuti, dopo una rozza e dolorosa puntura lombare per l’anestesia parziale. «Presero noi perché non avevano conigli» raccontò una giovane ebrea greca sopravvissuta all’intervento e alle sue gravi conseguenze.
Gli uomini riportavano scottature nell’area intorno ai genitali. Le vittime raccontarono della raccolta dello sperma tramite un apparecchio ideato da Schumann stesso (una specie di bastone introdotto nel retto che stimolava la prostata e provocava l’eiaculazione) e dell’asportazione di uno o di entrambi i testicoli in leggera anestesia. Le conseguenze di questi brutali interventi erano emorragie, setticemia, perdita di tono muscolare derivante dalle ferite. Molti morivano in poco tempo. Un gruppo di giovani polacchi fu sottoposto a dosi particolarmente massicce di raggi X, tanto che i loro genitali marcirono.
Il delirio di sperimentazione godeva di una libertà assoluta in assenza di ostacoli morali: la più potente arma di autoassoluzione era rappresentata dall’idea che quelle persone erano comunque condannate a morte, e pertanto non si stava procurando loro alcun danno.
L’eugenetica del passato era asservita a una politica razziale che eliminava quanti non corrispondevano a un certo standard. L’eugenetica di allora non ha nulla a che fare con le possibilità che la scienza offre oggi, e che potremmo chiamare manipolazione genetica migliorativa.
L’eugenetica nazista, finalizzata alla purificazione razziale, e quel movimento eugenetico che tra Ottocento e Novecento si diffuse in paesi «insospettabili» come Inghilterra e Stati Uniti sono giustamente condannati. Seppure in contesti molto dissimili, lo scopo comune dell’ideologia eugenetica consisteva nel «migliorare» la razza attraverso l’eliminazione di tutti gli elementi difettosi: prostitute, criminali vari, ma anche insufficienti mentali e fisici, poveri o appartenenti a presunte razze inferiori dovevano essere eliminati, o almeno esclusi dai processi riproduttivi, al fine di estirpare i loro geni imperfetti. Se il fenomeno dell’eugenetica nazista è ben conosciuto, forse è meno noto quanto accadde negli Stati Uniti. Tra il 1907 e il 1940, infatti, la caccia agli indegni («the hunt of unfit») causò la sterilizzazione forzata o la castrazione di migliaia di esseri umani: per la maggior parte si trattava di deboli di mente, malviventi o individui considerati moralmente degenerati; settecento furono classificati come «altro».
La differenza fra questa eugenetica e l’eugenetica attuale, però, è profonda, e l’assoluta condanna della prima non può essere trasferita, totalmente o parzialmente, sulla seconda. Confonderle, giocare con le ambiguità, è disonesto e pericoloso.
Eutanasia infantile: la morte pietosa
Il primo bambino viene ucciso in Germania tra il 1938 e il 1939: il piccolo Knauer, nato cieco, mancante di arti e apparentemente idiota. Il medico personale di Hitler, Karl Brandt, lo visita nella clinica dell’Università di Lipsia per autorizzare l’eutanasia e per rassicurare i medici che per ordine del Führer sarebbero stati annullati eventuali procedimenti legali contro di loro.
Brandt dichiara che non esiste alcun motivo per tenere in vita Knauer, in accordo con il direttore della clinica pediatrica. La procedura, cioè l’esecuzione, doveva essere camuffata da procedimento medico e i genitori non dovevano sentirsi in alcun modo responsabili della morte del figlio.
Il caso del piccolo Knauer viene utilizzato per avviare il «progetto eutanasia», sia per i bambini sia per gli adulti.
Lifton riporta la testimonianza del padre di Knauer nel 1973: «Il Führer voleva esplorare il problema delle persone prive di un futuro, la cui vita era senza valore. Da allora in poi, non avremmo più dovuto soffrire per questa terribile disgrazia, poiché il Führer ci aveva concesso l’uccisione pietosa di nostro figlio. In seguito avremmo potuto avere altri figli, belli e sani, di cui il Reich avrebbe potuto essere fiero… Si doveva costruire la Germania e c’era bisogno di ogni particella di energia. Ecco quel che mi spiegò Herr Brandt. Era un uomo magnifico: intelligente, molto convincente. Fu per noi come un salvatore: l’uomo che poteva sollevarci di un peso molto grande. Lo ringraziammo e gli esprimemmo tutta la nostra gratitudine».14
Il programma di esecuzioni «pietose» comincia a prendere piede. Si inizia dai bambini più piccoli, per poi passare a quelli di 2 o 3 anni e infine a quelli più grandi. Le uccisioni, nella scelta delle vittime e nelle procedure, diventano sempre più rapide e agili. Per gestire il programma viene creato appositamente il Comitato del Reich per il rilevamento di malattie ereditarie e congenite gravi. Lo scopo era di registrare in maniera tempestiva tutti i bambini con malattie ereditarie gravi: idiozia e mongolismo, specialmente se associati a cecità e sordità; microcefalia; idrocefalia; malformazioni di ogni sorta, soprattutto di arti, testa e colonna vertebrale; e paralisi, comprese condizioni spastiche (come stabilito in base all’Ordine segreto, 18 agosto 1939: «Oggetto – Dovere di riferire su neonati con malformazioni ecc.»).
Alla nascita la levatrice doveva denunciare lo stato di salute del bambino; i medici avevano il compito di riferire sulle sue condizioni fino all’età di 3 anni. Il ministero della Sanità del Reich distribuiva questionari, che i responsabili delle cliniche pediatriche dovevano compilare. A partire dal 1940 le informazioni richieste comprendevano notizie sulla nascita e sulla storia familiare, soprattutto riguardo a malattie ereditarie, ma anche ad abuso di alcol, nicotina o farmaci; la previsione di miglioramenti, la speranza di vita e la descrizione dello sviluppo fisico e mentale.
Compilati i questionari, una commissione composta da tre medici doveva giudicare quelli da sottoporre a eutanasia, senza visitare i bambini né leggere la documentazione medica. Un’apposita colonna del questionario indicava il Behandlung («trattamento»): il segno (+) significava a favore del trattamento (uccisione); (–) contro; nell’incertezza veniva specificato: rinvio temporaneo o osservazione. Ogni medico esaminava il modulo e, dopo averlo compilato, lo passava al collega: il secondo conosceva il parere del primo, e il terzo dei primi due. Per procedere al trattamento serviva unanimità nel giudizio: è verosimile che questo modo di procedere favorisse la condanna di quei bambini che il primo esaminatore giudicava indegni di vivere. In caso di mancato accordo, i bambini venivano mandati per «accertamenti», insieme a quelli condannati, nelle unità pediatriche deputate alle uccisioni. Trascorrevano un periodo di tempo in questi Istituti specialistici pediatrici (o Dipartimenti specialistici pediatrici o anche Istituzioni terapeutiche di convalescenza) per poi essere sottoposti nuovamente al giudizio della commissione, sulla base dei vecchi questionari.
Questi Dipartimenti erano presentati come luoghi in cui venivano offerte ai bambini le migliori terapie pediatriche: la morte era mascherata da assistenza specialistica. «Tutti procedevano come se quei bambini fossero effettivamente destinati a ricevere i doni della scienza medica, come se dovessero essere guariti invece che uccisi. La falsificazione era chiaramente intesa a ingannare: le famiglie dei bambini, i bambini stessi quando erano abbasta...