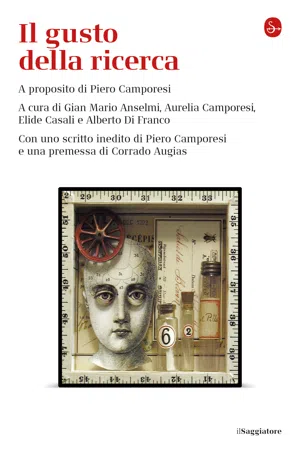![]()
1. Piero Camporesi, «un artista»
Corrado Augias
Siccome io non sono uno specialista dirò poco, che è una cosa sempre salutare, e per testimoniarvi quella che per me è l’importanza di Piero Camporesi ricorrerò a una libera associazione: a me Camporesi ricorda il regista Mario Monicelli, perché Monicelli come Camporesi – e mi rendo conto che è un paragone inusuale ma mi serve per introdurre un paio di concetti – ha usato dei materiali comuni, della commedia, della vita di tutti i giorni, per stravolgerli e tirarne fuori dei significati ai quali altri non avevano pensato. L’esempio più proprio che mi viene in mente è quello del film L’Armata Brancaleone che tutti noi abbiamo visto e che è un film apparentemente comico. In realtà dietro le stravolte e grottesche avventure di quella piccola banda di straccioni, si nasconde la tragedia della vita in questo paese, credo anche in altri, in secoli imprecisati. Perché apparentemente si parla del Medioevo mentre in realtà Monicelli si riferisce a un’età intramontabile. Ecco, Camporesi ha fatto la stessa cosa, mutatis tutti i mutandis del caso. Ha preso dei materiali comuni e usuali, per esempio il cibo, e ha tirato fuori dal cibo quell’approfondimento, quell’oceano di informazioni che ci hanno messo sotto gli occhi per la prima volta la miseria, la visionarietà, il bisogno, la fame oppure il contrario della fame cioè l’essersi saziati oltre misura in una maniera nociva, gonfia. In un’epoca come la nostra in cui da qualche anno è venuto di moda esporre in televisione gli chef, i grandi cuochi dove li si vede tagliare dei pomodori o sbattere le uova, tutto si esaurisce nel presentare alcuni ingredienti e nel mostrare la meccanica con la quale quegli ingredienti possono essere combinati insieme, dal che tirar fuori un piatto da mangiare, magari anche molto buono. Se voi paragonate la miseria di queste esibizioni televisive con la ricchezza di significati che Camporesi ha saputo trarre da ogni singolo ingrediente di quelle ricette, voi misurerete quale sia la distanza che separa il nostro povero sguardo comune sulle cose da quello di un artista! Perché io definisco Camporesi non un insigne cattedratico, non l’antropologo che nulla ha da invidiare a Lévi-Strauss, non l’uomo di scienze, il maestro dei tanti allievi, ma un artista. E sapete perché lo definisco artista? Non soltanto perché la sua scrittura è quell’italiano affabulato, che ti invita a una lettura di quelle che si gira la pagina per continuare a leggere la pagina successiva, ma anche perché l’artista è colui che sa vedere là dove gli altri non vedono. Dove gli altri vedono solo la superficie delle cose l’artista scompone quella superficie e vede oltre. È questa capacità di vedere oltre di Camporesi che gli ha permesso di utilizzare anche e soprattutto una miriade di materiali letterari minori, testi inerti per i più, dei quali lui ha intuito quante importanti informazioni contenessero, quanta storia si potesse trarre da quei libretti e libroni di agronomia, di medicina, di economia domestica.
Concludo questo mio breve contributo, più che altro una testimonianza della stima che ho nei confronti di un autore ancora tanto vitale e tutto sommato ancora poco conosciuto, con un mio omaggio: io ho scritto un libro su cui s’incontra una definizione della cucina romana che ho dedicato a Camporesi. Sono parole mie, ma sono parole ispirate a letture che avevo fatto dei suoi scritti. Si tratta di un confronto tra la cucina romana e la cucina milanese come cucina che esprime una borghesia affluente – e parlo della cucina di fine Ottocento inizio Novecento – con dei piatti dove abbonda la carne che è di per sé segno di benessere e agiatezza. La carne, le parti scelte delle bestie che ci mangiamo, infatti, sono segno di poter spendere. Metto a confronto questa cucina con quella di Roma, città che prevalentemente è stata, e ahimè, è tornata catastroficamente a essere anche in questi giorni, una città plebea che esprime infatti una cucina plebea, che io ho riassunto così:
La cucina romana è fatta di sapori e ingredienti primitivi non corrotti: alla sua base ci sono l’abbacchio arrostito sul fuoco, gli spaghetti detti alla matriciana gravidi di lardo, la coda di bue alla vaccinara – un piatto da mattatoio! – i rigatoni con la pajata, vale a dire una pasta grevemente insaporita con gli intestini di un vitello da latte, tra i formaggi il pecorino ricavato come dice il nome da latte di pecora grasso e piccante. Una cucina rozza, sapida e povera come quelli che l’hanno inventata: la plebe romana, nunc et semper (Corrado Augias, Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria, Einaudi, Torino 2017).
![]()
2. Cosa è Piero Camporesi?
Marco Belpoliti
Quando nel 1983 Piero Camporesi fu scoperto dal pubblico dei lettori e ammesso nelle patrie lettere, in cui per altro c’era già ma seminascosto sin dal 1970, Giorgio Manganelli, suo estimatore, si chiese sulle colonne del Corriere della Sera: «Chi è Camporesi?». Domanda subito corretta in «Cosa è Camporesi?». Interrogativo che metteva in scena tutta la cosalità, se così si può dire, di questo autore che non è solo un “chi” ma anche un “cosa”. Dentro i libri di Camporesi c’è infatti una “cosa” che non c’è in tanti volumi di celebrati scrittori e saggisti. C’è tutto un mondo di persone, oggetti, luoghi, parole. Dentro i libri di questo meraviglioso scrittore in prosa c’è tutto il rimosso di almeno tre secoli e mezzo della nostra storia. C’è persino il secolo appena iniziato, anche se lui se ne è andato vent’anni fa, perché i temi del corpo e del cibo sono ancora di grandissima attualità. Ed è un peccato che Piero Camporesi non sia qui con noi per chiosare le trasformazioni culinarie degli ultimi due decenni con il trionfo di una parola inglese che oggi è dovunque: food. Cosa infatti avrebbe detto di questa trasformazione linguistica, non solo sul piano dei termini, ma anche delle pratiche culinarie, che sono al centro dell’interesse simbolico ed economico del mondo contemporaneo? Cibo e turismo, cibo e corpo, cibo e sesso. Quante cose il professor Camporesi avrebbe avuto da dire!
Piero Camporesi è stato prima di tutto un professore di letteratura, almeno ufficialmente, e che professore, come si ricordano i suoi studenti degli anni settanta a Bologna. Le sue lezioni erano puro teatro barocco, scene in cui pitocchi, poveri malandati e male in arnese, uscivano dalle pagine di scrittori maggiori e minori, per raccontare il dramma delle loro esistenze, ed estendere sin dentro le aule dell’Alma Mater le atmosfere del passato, che poi erano anche quelle di quel presente, perché i poveri erano, e sono, come ci dicono le statistiche, qui con noi, effetto della economia finanziaria del xx e xxi secolo, e il cibo, la sua scarsità, è uno degli indici fondamentali dell’impoverimento di milioni di persone. Quattro milioni gli indigenti in Italia oggi, come ci dicono le commissioni ministeriali d’inchiesta, e altri ancora gravitano in quell’area di povertà prossima e ventura che sembrano un retaggio del passato. Camporesi ha raccontato come nessuno i poveri in tanti libri; ne ricordo solo uno a cui sono legato: Il libro dei vagabondi (1973).
Oltre che un professore di letteratura, Camporesi è stato uno scopritore di testi nascosti della nostra tradizione. Nel 1970 quando uscì presso Einaudi la sua edizione dell’Artusi, di colpo un tesoro di ricette e indicazioni, presente nelle case degli italiani, si trasformò in un libro “maggiore”. Scoperta culinaria, scoperta linguistica, scoperta letteraria e scoperta antropologica. Camporesi è stato un antropologo della cultura, che invece di trasferirsi nei Mari del Sud, s’è inoltrato nelle biblioteche della sua regione, l’Emilia-Romagna, per scandagliare libri e libretti, oppure ha compulsato volumoni acquistati da antiquari e sulle bancarelle: un tesoro perduto. Con lui è tornato a vivere il popolo degli esclusi.
Manganelli è stato uno dei primi ad accorgersi di quel semisconosciuto professore, che aveva frequentato anche la Facoltà di Medicina – per poi lasciarla ben presto –, e ne scrisse sul Corriere della Sera. Poi fu la volta del Libro dei vagabondi, al quale devo io stesso la scoperta di quello scrittore sconosciuto in un’epoca tumultuosa della mia vita universitaria. I vagabondi sono tornati oggi e, se Camporesi fosse ancora con noi, non tarderebbe a scrivere dei migranti che arrivano dalle lontane civiltà del globo su gommoni e bagnarole. E ci avrebbe stupiti certamente con le sue prose, perché quello che Camporesi non amava era proprio il «politicamente corretto», così come non amava lo stile falso e clericale di molte penne contemporanee. Era un uomo scomodo e difficile, scostante a volte, anche se come suo frequentatore saltuario posso testimoniare il suo garbo, il tatto e persino la dolcezza della sua persona, che alternava scatti improvvisi a tenerezze inusuali. Era anche un attore, che recitava a soggetto e spesso in modo imprevedibile, quando insegnava o nelle conferenze che teneva (ne ricordo una a Reggio Emilia dedicata all’eccellenza del maiale: divertentissima).
Mi sono messo al computer per scrivere di lui, del suo stile incredibile e straordinario, della sua prosa barocca e modernissima a un tempo. Vorrei dire solo una cosa che ritengo importante: Piero Camporesi è un classico della nostra letteratura, un classico anticlassico. Appartiene alla linea che da Longhi arriva a Gadda, che da Contini avanza fino ai nostri giorni in vari narratori giovani. L’anima barocca e l’anima labirintica si sovrappongono nella sua scrittura, che somiglia a un elegantissimo e immaginoso ghirigoro continuo, che s’inarca e procede per figure retoriche, ma lascia altresì spazio a una densità di pensieri e umori che non ha eguali nella nostra letteratura. Penso sia un classico anticlassico, almeno per me, la miglior definizione di Piero Camporesi.
Voglio concludere con qualche ricordo della nostra frequentazione. Da giovane laureato della Università di Bologna andavo a raccoglierne le sue parole per i giornali cui collaboravo, e così sono diventato, pian piano, un suo frequentatore. Quando uscivamo a pranzo, spesso nei dintorni di via Broccaindosso, ricordo il terrore che si palesava sui volti dei camerieri quando entravamo nei ristoranti e nelle trattorie bolognesi. Camporesi compulsava con attenzione il menu e lo commentava in modo puntiglioso, mentre il cameriere attendeva la comanda in piedi, impietrito, ma anche divertito. «Basta con tutto questo pomodoro!» esclamava a volte, e non riusciva a trattenersi dal pronunciare improperi e maledizioni verso la «dieta mediterranea», che imperava già in tante tavole dell’epoca.
Non ha fatto in tempo a vedere il ritorno del biologico, contro cui aveva già cominciato a lanciare i suoi strali. Che peccato non poter più uscire con lui a pranzo! Che perdita quel teatrino di commenti e reprimende; e, durante i pasti presi insieme, il suo colloquio sentenzioso, burbero e sarcastico.
Ci siamo sempre dati del Lei, ma non ha mancato di invitarmi una domenica mattina a casa sua per un pranzo “alla Artusi”. In cucina presiedeva Giovanna, sua moglie, e in tavola, all’arrivo dei piatti era un trionfo di parole e immagini. Che buono tutto, quel giorno, buonissimo. Grazie Professore, non la dimenticheremo!
![]()
PARTE PRIMA
![]()
3. Olindo Guerrini, «enigma vivente».
Un inedito di Piero Camporesi
Elide Casali
Ricordo ancora l’incanto di quel mattino,
la sua voce che inanellava parole
e l’intensità della sua narrazione:
un omaggio al nostro paese.
Maria Grazia Feletti
Piero Camporesi legge Olindo Guerrini
La «linea guerriniana»
Il mio amico Ennio Dirani mi ha fatto uno scherzo da ravennate parlando di me come conferenziere. Il fatto stesso che sia qui, con questa borsa, vi fa capire che non sono affatto un conferenziere: sono un modesto, umile uomo che ha bisogno di libri per potere dire qualcosa. La parola mi è negata, in un certo senso, ma ho alle mie spalle l’ombra, che certamente mi capisce, di Olindo Guerrini che, è notorio, in pubblico non parlava mai; era impacciatissimo se doveva dire due parole; si trovava bene soltanto in biblioteca; considerava la conferenza una vera e propria iattura. Qualcuna ne scrisse, anzi qualcuna ne lesse, ma l’aveva scritta prima. Non improvvisava mai Olindo Guerrini! Quest’uomo dotato di una rima eccezionalmente facile (un giudice severo come Carducci lo accusava moltissimo per la sua attività tecnica), questo grandissimo manipolatore di versi quando doveva parlare in pubblico preferiva tacere e diceva poche e grame parole. Io penso di appartenere a questa linea guerriniana.
Così si presentava Piero Camporesi il 24 aprile 1983 al pubblico di Sant’Alberto di Ravenna, per intrattenerlo su Olin...