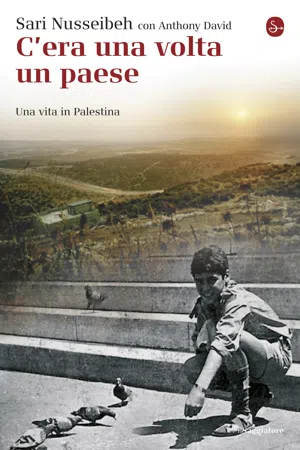1. La chiave
Quando ero bambino, mio padre una volta mi disse che noi Nusseibeh discendevamo da una lunga stirpe di ladri. Tutte le dinastie familiari, mi spiegò fra il serio e il faceto, possono ricondurre la loro nascita a un atto di brigantaggio. Credo che lo dicesse perché gli arabi si inorgogliscono spesso delle loro antiche radici. Bisogna vivere nel presente, mi ripeteva spesso. Se non ho mai identificato con certezza quei ladri, non mi è stato difficile rintracciare vecchie lapidi di arenaria corrosa su cui sono incisi i nomi che nell’immaginazione mi collegavano magicamente a milletrecento anni di avi, fino a raggiungere le sabbie ardenti d’Arabia.
La storia della mia famiglia nella Città santa ha inizio con il viaggio notturno di Maometto. Quando il Profeta intraprese il suo leggendario pellegrinaggio a Gerusalemme, lui e alcuni compagni erano già stati scacciati dalla Mecca e si erano spostati a Medina. Fu nei sobborghi di quella città nel deserto che Maometto trovò i primi seguaci: quattordici capi tribù che giurarono fedeltà a lui e all’islam.
Sorprendentemente, considerato il modo in cui il mondo contemporaneo giudica il ruolo delle donne nella cultura islamica, quattro di quei capi tribù erano appunto donne, e una di loro era Nusaybah, appartenente alla tribù guerriera di Khazraj. Di ritorno dal viaggio notturno, il Profeta e i suoi seguaci, fra cui Nusaybah e il suo clan, diressero le loro preghiere a Gerusalemme.
Nusaybah, progenitrice della mia famiglia, era una fiera combattente che a cavallo difese validamente il Profeta a rischio della sua stessa vita. In una battaglia, pur avendo perduto una gamba e due figli, continuò a combattere. Le cronache islamiche ci dicono che Maometto fu così colpito dal suo coraggio da prometterle che lei e i suoi discendenti avrebbero avuto sempre un posto in paradiso.
Uno dei racconti preferiti della mia infanzia è la storia dell’ingresso del califfo Omar a Gerusalemme, nel 638 d.C. A quel tempo Maometto era già morto, e così il suo primo successore e califfo (califfo significa appunto «successore del Profeta»), Abu Bakr. Omar il Giusto era il secondo califfo.
Per me la parte più affascinante della storia era quella in cui Omar si impadroniva della città. Come a tutti i ragazzi, mi piacevano i racconti di nobili cavalieri armati che a fendenti si aprivano un varco tra gli sventurati nemici. Ma la conquista di Gerusalemme da parte di Omar fu ben altra cosa.
La sue fede islamica lo portava a considerare la città un luogo diverso da ogni altro. Era lì che il suo maestro, il Profeta, era stato miracolosamente trasportato durante il viaggio notturno, lì, nei pressi della Roccia dell’ascensione, aveva pregato con Abramo, Mosè e Gesù. Quella non era una città conquistabile con la spada. La violenza e i bagni di sangue, che altrove avevano operato per lui meraviglie, non dovevano lordare Gerusalemme.
Quando il popolo di Gerusalemme chiese quali fossero le condizioni della resa, Omar inviò la sua risposta. Esigeva che Sefronio, il vescovo bizantino della città, lo incontrasse fuori delle porte. Nel frattempo, dietro sue istruzioni, le schiere musulmane che circondavano le mura si astennero dall’attaccare.
All’ora stabilita, Sefronio, con indosso la veste dorata simbolo della sua carica, uscì per incontrare Omar. Credeva di trovare un conquistatore armato e rimase sorpreso nel vedere un uomo vestito semplicemente che portava un cammello su cui sedeva il suo scudiero. Il comandante dell’esercito musulmano promise al vescovo che popolo, proprietà e luoghi santi di Gerusalemme sarebbero stati risparmiati. Commosso, Sefronio tese a Omar le chiavi delle porte della città e del Santo sepolcro.
Il vescovo scortò quindi il conquistatore nella chiesa più santa della cristianità, nonché ricettacolo di storia divina. Adamo, il primo uomo, era sepolto lì. Quello era il luogo che ospitava la tomba vuota del Cristo, e lì Elena, madre di Costantino il Grande, aveva scoperto la vera croce e la corona di spine. Il racconto prosegue narrando che all’ora della preghiera musulmana, Omar si rifiutò di recitarla nella chiesa nel timore di stabilire un precedente. Temeva infatti che, se avesse pregato lì, i successivi capi musulmani sarebbero stati tentati di trasformare la gloriosa chiesa in una moschea. Scelse così di officiare il rito all’esterno.
Uno dei compagni che seguirono Omar a Gerusalemme era il fratello di Nusaybah, Ubadah ibn al-Samit. Prima di lasciare la città, il califfo ne fece il primo Giudice supremo di Gerusalemme e gli consegnò la chiave della chiesa del Santo sepolcro. (Da bambino, mi piaceva visitare la tomba di Ubadah, all’angolo sud del muro che racchiude il Sacro santuario.)
I figli di Ubadah furono i primi Nusaybah (che ora si scrive Nus-seibeh) a nascere a Gerusalemme, e col tempo la famiglia si arricchì e acquisì vaste proprietà. Passarono i secoli: per lunghi periodi la nostra famiglia non è stata altro che una sterile elencazione di nomi e titoli ordinatamente divisi fra magistrati, studiosi del Corano, saggi sufi e proprietari terrieri.
Le fortune politiche dei Nusseibeh sono sempre dipese dall’impero che dominava Gerusalemme. Che ne godessero o meno i favori, i miei antenati hanno sempre scrupolosamente compiuto il loro dovere e custodito la chiave. Poiché il controllo della chiesa del Santo sepolcro era il principale oggetto del contendere fra cristiani e musulmani, il possesso della chiave rivestiva una straordinaria importanza diplomatica. E così, nel corso dei secoli, la mia famiglia ottemperò al suo compito: un antenato apriva la porta, i cristiani entravano, a sera ne uscivano e la porta veniva nuovamente chiusa fino al mattino seguente.
2. La nazione panaraba
Non vorrei dare l’impressione che la storia antica si annidi in ogni angolo della nostra vita. Al contrario. Sono stato allevato da un uomo moderno e lungimirante che adorava in ugual misura la poesia araba antica e moderna. Pur orgoglioso delle nostre antiche imprese matriarcali nel deserto, mio padre non perse mai di vista il qui e ora.
Una nuova sensibilità cominciò a diffondersi fra l’aristocrazia di Gerusalemme verso la fine del XIX secolo. I tempi stavano cambiando, soprattutto perché l’Impero ottomano era ormai divenuto il «malato d’Europa». Come in ogni sistema dispotico, i primi segni di indebolimento suscitarono malcontento in ogni angolo dell’Impero. Le comunità urbane chiedevano i diritti e le libertà di cui godevano gli europei. Ispirati dal Risorgimento italiano, nel 1909 i Giovani turchi (ufficialmente noti come Comitato unione e progresso) si impadronirono della Sublime porta di Costantinopoli, cacciarono il sultano e posero le basi per una nuova amministrazione. I Giovani turchi tentarono di strappare l’Impero alla sua letargia promettendo un futuro di legge, industrializzazione e progresso.
In Palestina, il movimento fautore di una libertà di stampo europeo era particolarmente diffuso, dato che il paese risentiva già dell’influenza europea. All’epoca di mio nonno, intorno al 1880, la lotta per la Palestina aveva già avuto inizio.
Paradossalmente, fu l’antico legato della Terra santa a determinare il cambiamento. A Gerusalemme, lo zar Alessandro II edificò la Colonia russa per ospitare il flusso di pellegrini russi diretti in città. (Attualmente, la colonia è usata come carcere dagli israeliani.) Per non essere da meno, il Kaiser tedesco costruì l’abbazia benedettina del Monte Sion. I protestanti provvidero a scuole e ospedali. I cattolici nominarono quello che doveva essere il primo patriarca latino dai tempi delle crociate, e il barone Edmond de Rothschild eresse mulini a vento per una colonia di agricoltori ebrei.
Fra gli arabi di Gerusalemme, il movimento per le riforme politiche fu indirettamente rafforzato da questa frenesia edilizia e missionaria, in parte perché molti riformatori erano influenzati dalle idee moderne circolanti nelle scuole gestite dagli europei. Studenti dell’Arab College e, successivamente, della mia alma mater, la scuola anglicana St George’s, scoprirono il panarabismo, un movimento capitanato da arabi cristiani di Beirut e Damasco, e da figure quali Abduh e Afghani al Cairo. Questi intellettuali, molti dei quali valenti poeti e pensatori, consideravano i vecchi legami di clan, tribù e sette come residui del feudalesimo che aveva arrestato il progresso scientifico e culturale arabo.
In Palestina, una fonte importante del fervore nazionalista fra gli ebrei era costituita dal sionismo. Gli ebrei erano sempre stati una parte organica della Gerusalemme islamica. (Scavando fra antichi documenti rimasti sepolti per secoli in una vecchia sinagoga in Egitto, mio cugino Zaki scoprì lettere che elogiavano il califfo Omar per aver permesso agli ebrei di fare ritorno nella città dopo secoli di interdizione da parte di Roma e del cristianesimo.) Verso la fine del XIX secolo, gran parte degli ebrei cittadini erano o ortodossi provenienti dall’Europa dell’Est o ebrei di lingua araba che vivevano con gli arabi da tempo immemorabile, e nella vita e nella cultura araba si sentivano pienamente integrati.
Il movimento sionista aveva radici ben diverse. Theodor Herzl, giornalista e commediografo fallito viennese, era un ebreo ungherese assimilato. All’epoca in cui scrisse Lo stato ebraico, non era mai stato in Palestina, ma la conosceva solo dai libri. Ciò che aveva in mente era uno stato per quegli ebrei che non potevano o non volevano integrarsi nelle società europee. Gli arabi, pensava, non avevano nulla da temere. «Gli ebrei non hanno alle spalle alcuna potenza belligerante» scrisse «né hanno una natura incline alla guerra.»
Gli arabi erano persuasi del contrario. Dieci anni dopo la stesura di Lo stato ebraico, il giornalista palestinese Najib Nassar pubblicò un richiamo alla consapevolezza, Zionism: Its History, Aims and Importance. Cominciarono a diffondersi timori di un’«invasione» di ebrei europei. Il sindaco di Gerusalemme, Zia al-Khalidi, era così allarmato che scrisse all’amico Zadoc Khan, rabbino capo in Francia. «Chi può contestare i diritti degli ebrei alla Palestina?» scrisse. «Dio sa se storicamente quello è davvero il loro paese.» Nondimeno, la «forza brutale della realtà», vale a dire il fatto che il paese contasse una numerosa popolazione araba, impediva il trasferimento in massa degli ebrei. «In nome di Dio» concludeva Khan «lasciate in pace la Palestina.»
3. Promesse, promesse
La Prima guerra mondiale vide la fine dei califfati, un sistema vecchio di milletrecento anni, e inaugurò un’epoca di grandi speranze per i nazionalisti arabi. Sotto questo aspetto, mio padre, venuto al mondo nel 1913, nasceva in un momento di auspici favorevoli. Una sua fotografia da bambino lo mostra vestito e compunto come un giovane nobile. Era ancora troppo giovane per capire che il movimento arabo che avrebbe abbracciato per tutta la sua vita stava per essere strangolato sul nascere.
Con lo scoppio del conflitto, nel 1914, ebbe fine quell’epoca prebellica relativamente tollerante. I turchi commisero l’errore di appoggiare gli Imperi centrali; il loro governatore, Jamal Pasha, meglio noto con l’eloquente soprannome di «il Macellaio», governava la Palestina come se fosse un suo feudo personale. Non tollerava dissensi e, a mano a mano che la guerra si trascinava e la collera degli arabi si volgeva contro i signori di Costantinopoli, il vendicativo turco emanò sentenze di morte con la disinvoltura con cui una successiva generazione di forze di polizia avrebbe stila...