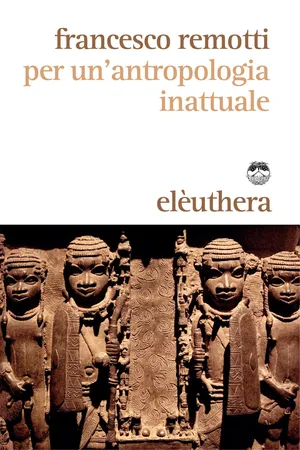![]()
capitolo terzo
Questione di sopravvivenza.
Un ripensamento epistemologico
per l’antropologia culturale
1. Un futuro molto incerto
Sarà bene chiarire subito che in questo scritto uso l’espressione «antropologia culturale» come la categoria più ampia, comprensiva di tutti gli altri saperi di tipo demo-etno-antropologico (quelli che, ponendoci nell’ottica della burocrazia ministeriale, rientrano nel settore scientifico-disciplinare m-dea/01), e come categoria che meglio si presta a differenziare questo insieme di saperi da altre antropologie, tra cui soprattutto la bio-antropologia. Entrando in argomento, espongo subito la considerazione che mi sta maggiormente a cuore. Provo un sentimento di apprensione e persino di timore per il futuro dell’antropologia culturale: di quella italiana in primo luogo, ma anche di quella internazionale. Mi pongo cioè la domanda se l’antropologia culturale sia in grado di sopravvivere nei prossimi anni, quanto meno in ambito accademico.
Poiché questo scritto è stato originariamente pubblicato poco dopo essere andato in pensione, è molto probabile che alcuni scorgano in questi miei sentimenti l’incapacità, tipicamente senile, di scorgere e apprezzare i segni di vitalità, dovuti alle trasformazioni in atto. Dico subito che sono disposto ad ammettere questa possibilità, e anzi aggiungo che sarei davvero molto contento, se mi si dimostrasse che la visione fosca del futuro sia dovuta soltanto ai miei limiti personali e di età. Il fatto è, però, che non sono soltanto i vecchi a vedere buio nel futuro, ma sono anche e soprattutto i giovani. Nella lettera aperta che i giovani antropologi, per lo più «non strutturati», hanno presentato il 25 gennaio 2013 alle associazioni degli antropologi culturali (anuac e aisea), si parla in maniera del tutto esplicita del «rischio concreto della scomparsa della disciplina dentro e fuori le mura accademiche».
Del resto, a partire dalla data di quella lettera, i segni che suscitano timore e apprensione per la sopravvivenza dell’antropologia non hanno fatto altro che aumentare: e questi segni non sono sentimenti o impressioni soggettive; sono fatti, dotati di una loro indiscutibile oggettività. È sufficiente pensare alla crisi istituzionale che ha investito in questi anni i nostri dottorati e i nostri corsi di laurea, molti dei quali sono stati cancellati, e al rischio fortissimo che il nostro stesso settore scientifico-disciplinare perda la sua autonomia concorsuale. Dottorati, corsi di laurea, autonomia del settore: si tratta, come è ovvio, dei canali preposti alla sopravvivenza di un sapere accademico. La realtà dunque è che noi stiamo assistendo quanto meno a un processo di smantellamento: la questione è se questo processo andrà avanti fino alla fine o se invece si avranno forza, mezzi, opportunità per contrastarlo e arrestarlo (e anche, chissà, per invertire la tendenza).
2. Lotta tra saperi
La seconda considerazione ha un carattere più generale e riguarda una specie di lotta di «classe» – se così posso esprimermi – tra i saperi accademici: una lotta per la sopravvivenza, determinata probabilmente da una progressiva mancanza di risorse, la quale vede le scienze umanistiche ed umane (quelle che lo storicismo tedesco chiamava scienze dello spirito o della cultura) subire azioni di marginalizzazione, se non addirittura divenire oggetto di discredito.
L’antropologia culturale fa ovviamente parte delle scienze umane e si trova a condividere con altri saperi umanistici una condizione di precarietà, la quale pone a rischio la sua sopravvivenza. Se questa considerazione ha un qualche fondamento, sarebbe importante per l’antropologia culturale partecipare attivamente e consapevolmente all’elaborazione di una strategia che coinvolga un po’ tutta la «classe» delle scienze umane e umanistiche.
3. Debolezza interna
Con questa considerazione di ordine generale non si può tuttavia eludere una domanda più particolare, quella che attiene alle condizioni interne dell’antropologia culturale, ovvero le scelte di natura epistemologica che essa ha compiuto negli ultimi decenni, valutandone l’efficacia in termini di sopravvivenza. In altre parole, il fatto che si stia assistendo a una prevaricazione aggressiva da parte di altre forme di sapere non deve indurci a esaminare soltanto l’aggressione degli altri, tralasciando di chiederci se disponiamo di valide armi di difesa o se invece le scelte compiute abbiano per caso reso poco difendibili le nostre posizioni. Ritengo che porsi questa domanda sia un passo fondamentale e un presupposto ineludibile per procedere a ciò che i giovani ricercatori hanno suggerito nella loro lettera: «rivedere criticamente traiettorie e strategie».
Questo ripensamento dovrà riguardare anche le scelte compiute dall’antropologia culturale in ambito internazionale, se – come sottolinea Francesco Faeta nella sua risposta alla lettera dei giovani antropologi – «non è […] vero […] che l’antropologia fuori d’Italia viva una situazione tranquilla»: essa – prosegue Faeta a seguito di esperienze presso diverse università straniere – offre «un quadro di disorientamento complessivo», oltre che «di restringimento e ridimensionamento degli insegnamenti, di annacquamento della specificità antropologica dei dipartimenti, di riduzione dei finanziamenti». Anche Faeta pone in luce la politica di aggressione di cui l’antropologia rimane vittima, come quando afferma che «la crisi dell’antropologia si colloca […] dentro il contesto globale della liquidazione dei saperi che hanno a che fare con la memoria sociale e con l’anamnesi critica del presente». Ma non si esime per nulla – come del resto aveva già fatto in alcuni suoi testi recenti (Faeta 2005; 2011) – a chiedersi se in tutto ciò non abbiano svolto un ruolo decisivo alcuni «nostri errori». Tra questi – egli sostiene – vi è l’«abbandono assai evidente delle tematiche in grado di produrre modelli» teorici: «poca teoria», insomma, e al suo posto, un grande darsi da fare per conquistare spazi di interventi, «in concorrenza con lo psicologo, con l’assistente sociale e con il sociologo», nelle asl, nelle scuole, nei centri di accoglienza degli immigrati, in tal modo «rinunciando alla propria specificità».
Faeta è ben consapevole che occorre chiedersi «quale tipo di antropologia» si intenda proporre «nella società del terzo millennio». Ma fa capire anche quale sia la specificità del sapere antropologico che sarebbe bene salvaguardare: essa coincide con la capacità di «produrre modelli» teorici, «utili a porre in discussione le visioni acquisite della realtà», costruendo «il più cospicuo e sofisticato apparato di riserva concettuale delle scienze sociali».
Ammetto di avere tagliato e ricucito a mio uso alcune frasi di Faeta, ma spero di non avere tradito il suo pensiero, che dichiaro di condividere nella maggior parte delle sue argomentazioni, anche là dove, proprio accogliendo le sfide della società in cui viviamo, auspica un «lavoro futuro di restauro» del nostro sapere.
4. Impegno per il riconoscimento
Interpreto il restauro che invoca Faeta come la ricostruzione di un territorio e la messa in opera di espedienti o il ripristino di strutture che ne consentano la difesa. Anche in base alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, non ho esitazione ad affermare che siamo in guerra e che dunque occorre adottare un comportamento quanto meno difensivo. Ma, guerra per che cosa? Quali sono i contenuti e i motivi di questa guerra? E che cosa occorre difendere? Darei questa risposta: guerra per il riconoscimento e difesa della dignità scientifica dell’antropologia culturale, sempre che, beninteso, coloro che vi appartengono e vi si riconoscono, e soprattutto coloro che da essa traggono mezzi per il proprio sostentamento, ammettano che ne valga la pena, ovvero che l’operazione sia credibile e necessaria.
Non so in effetti fino a che punto si sia mai preso in considerazione questo argomento: a pensarci bene, un argomento fondamentale e che forse spiega in maniera adeguata le circostanze in cui versa oggi l’antropologia, soprattutto l’antropologia italiana. Voglio dire che l’antropologia culturale – sempre nel senso ampio chiarito all’inizio di questo scritto – ha dato da vivere, in senso letterale, a tutti coloro che, specialmente in ambito accademico, hanno insegnato qualcosa o hanno condotto ricerche su qualcosa, sfruttando questa insegna. Credo di non sbagliare se dico che la maggior parte di coloro che hanno fruito di questa copertura non si sono dati da fare quel granché per spiegare a sé e agli altri la motivazione profonda di questo tipo di sapere, la sua plausibilità scientifica: ai loro occhi, era sufficiente utilizzare l’etichetta «antropologo», applicandola a se stessi, alla loro posizione, ai propri insegnamenti e alle proprie ricerche.
Spesso, o quasi sempre, come Georg W. F. Hegel aveva chiarito molto bene, il riconoscimento è una faccenda di conflitti. Siamo in guerra, e si tratta, tra le altre cose, di una guerra di riconoscimento della dignità scientifica dei vari saperi che affollano ciò che un tempo si chiamava (con Kant e l’illuminismo) la repubblica delle scienze e delle lettere, e che...