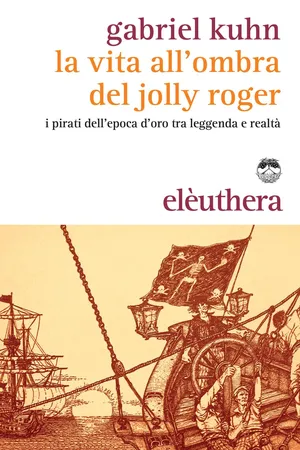
La vita all'ombra del Jolly Roger
I pirati dell'epoca d'oro tra leggenda e realtà
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
Informazioni su questo libro
L'enorme attenzione che i pirati hanno ricevuto negli ultimi anni non si limita al grande schermo o al reparto giocattoli dei grandi magazzini. Questi "malfattori" di trecento anni fa hanno impregnato a fondo l'immaginario contemporaneo, riuscendo a creare una mitologia tuttora vitale. Nonostante la loro epoca d'oro sia collocabile tra il 1690 e il 1725, ancora oggi studiosi, scrittori, sceneggiatori e appassionati si dividono in accanite diatribe tra chi vede in loro degli audaci ribelli sociali, capaci di realizzare le prime forme di democrazia diretta, e chi invece li considera dei briganti crudeli e sanguinari. E in effetti i pirati furono entrambe le cose: fuorilegge pronti a depredare chiunque incrociasse la loro rotta e uomini liberi che rifiutavano una società "legittima" oppressiva e altrettanto violenta. Passando da Nietzsche a Foucault, da Che Guevara a Hobsbawm, da Sahlins a Clastres, l'autore ci racconta la storia non convenzionale di queste comunità nomadi, descrivendo – sempre in bilico tra leggenda e realtà – la vita quotidiana all'ombra della bandiera nera pirata."Il diavolo si porti voi e la vostra coscienza, io sono un principe sovrano, con lo stesso diritto di far guerra al mondo intero che ha un monarca con cento navi in mare e un esercito di centomila uomini in campo; e me lo dice la mia coscienza; ma è inutile discutere con mocciosi come voi, che si lasciano prendere a calci dai superiori per tutto il ponte, e che prestano fede a un ruffiano di prete, che è una palla di sego che non crede né pratica ciò che mette in testa agli imbecilli cui tiene la predica".Saul Bellamy, capitano pirata.Gabriel Kuhn, austriaco di nascita, vive e lavora a Stoccolma. Studioso delle micro-società, ha scritto numerosi testi sulle dinamiche interne di queste comunità circoscritte.
Domande frequenti
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Informazioni
Indice dei contenuti
- Titoli affini
- Titolo
- Colophon
- Indice
- Introduzione
- capitolo primo
- capitolo secondo
- capitolo terzo
- capitolo quarto
- Conclusioni
- Principali testi sui pirati