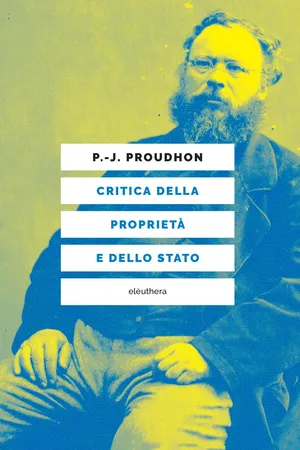![]()
La giustizia come equilibrio
Per stabilire l’equilibrio si fa ricorso a diverse ipotesi. Gli uni, considerando che l’uomo non ha valore che per la società e che al di fuori della società esso ricade allo stato bruto, tendono con tutte le loro forze, in nome degli interessi particolari e sociali, ad assorbire l’individuo nella collettività. Cioè non riconoscono altri interessi legittimi che quelli del gruppo sociale, e di conseguenza non riconoscono altra dignità, altra inviolabilità, che nel gruppo, da cui gli individui traggono in seguito quelli che vengono chiamati, ma molto impropriamente, i loro diritti. In questo sistema, l’individuo non ha esistenza giuridica; non è niente di per se stesso; non può invocare diritti, non ha che doveri. La società lo produce come sua espressione, gli conferisce una peculiarità, gli assegna una funzione, gli accorda la sua parte di felicità e di gloria: egli le deve tutto, essa non gli deve nulla.
Tale è, in poche parole, il sistema comunista, preconizzato da Licurgo, Platone, dai fondatori di ordini religiosi e dalla maggior parte dei socialisti contemporanei. Questo sistema, che si potrebbe definire la decadenza della personalità in nome della società, si ritrova, leggermente modificato, nel dispotismo orientale, nell’autocrazia dei Cesari, e nell’assolutismo di diritto divino. È il fondo di tutte le religioni. La sua teoria si riduce a questa proposizione contraddittoria: asservire l’individuo al fine di rendere libera la massa. Evidentemente la difficoltà non è risolta: è aggirata. Si tratta di tirannia, di tirannia mistica e anonima; non di associazione. Così il risultato è stato quello che si poteva prevedere: avendo privato la persona umana delle sue prerogative, la società si è trovata sprovvista del suo principio vitale; non c’è un esempio di comunità che, fondata sull’entusiasmo, non sia finita nella imbecillità.
Lo spirito va da un estremo all’altro. Resi accorti dall’insuccesso del comunismo, si è ricaduti nell’ipotesi di una libertà illimitata. I partigiani di questa opinione sostengono che non c’è, in fondo, opposizione tra gli interessi; che essendo gli uomini tutti della stessa natura, avendo tutti bisogno gli uni degli altri, i loro interessi sono identici, e pertanto facilmente accordabili; che solo l’ignoranza delle leggi economiche ha causato questo antagonismo, che sparirà il giorno in cui, più illuminati sui nostri rapporti, ritorneremo alla libertà e alla natura. In breve, si conclude che se vi è disarmonia tra gli uomini, ciò deriva soprattutto dall’ingerenza dell’autorità in cose che non sono di sua competenza, dalla mania di regolamentare e legiferare; che non resta che lasciar agire la libertà, illuminata dalla scienza, e tutto rientrerà infallibilmente nell’ordine. Tale è la teoria dei moderni economisti, partigiani del libero scambio, del lasciar fare, lasciar passare, del ciascuno da sé, ciascuno per sé, ecc.
Come si vede, è sempre non risolvere la difficoltà; è negare che essa esista. Noi non sappiamo che farcene della vostra giustizia, dicono i liberali, dal momento che non ammettiamo la realtà dell’antagonismo. Giustizia e utilità sono per noi sinonimi. È sufficiente che gli interessi, sedicenti opposti, si comprendano perché essi si rispettino: la virtù, nell’uomo sociale, come nell’uomo solitario, non è che egoismo beninteso.
Questa teoria, che fa consistere l’organizzazione sociale unicamente nello sviluppo della libertà individuale, sarebbe forse vera – e si potrebbe dire che la scienza dei diritti e la scienza degli interessi sono una sola e identica scienza – se, una volta fatta la scienza degli interessi, o scienza economica, la sua applicazione non incontrasse alcuna difficoltà. Questa teoria, dicevo, sarebbe vera se gli interessi potessero essere fissati una volta per tutte e rigorosamente definiti; se, essendo stati sin dall’inizio uguali e, più tardi, nel loro sviluppo, avendo camminato di pari passo, avessero obbedito a una legge costante; se non fosse necessario, nella loro disuguaglianza crescente, attribuire una così larga parte al caso e all’arbitrio; se malgrado tanto numerose e stupefacenti anomalie, il minimo progetto di regolarizzazione non sollevasse da parte degli individui interessati proteste così vive; se si potesse prevedere sin da ora la fine della disuguaglianza, e proprio a causa dell’antagonismo; se per la loro natura essenzialmente mobile ed evolutiva, gli interessi non giungessero continuamente a ostacolarsi, a scavare tra di loro delle disuguaglianze nuove; se non tendessero malgrado tutto a interferire, a soppiantarsi; se la missione del legislatore non fosse precisamente, infine, quella di consacrare per mezzo delle sue leggi, a mano a mano che essa si sviluppa, questa scienza degli interessi, dei loro rapporti, del loro equilibrio, della loro solidarietà: scienza che sarebbe la più alta espressione del diritto se la si potesse credere definitiva, ma scienza che, venendo sempre dopo il fatto, non prevenendo mai le difficoltà, essendo costretta a imporre le sue decisioni per mezzo dell’autorità pubblica, può ben servire da strumento e da ausilio all’ordine, ma non può affatto essere presa per il principio stesso dell’ordine.
A causa di queste considerazioni, la teoria liberale, o dell’egoismo beninteso, inconfutabile se la scienza economica fosse costituita e fosse dimostrata l’identità degli interessi, si riduce a una petizione di principio. Essa suppone come realizzate delle cose che non possono mai esserlo; delle cose la cui realizzazione incessante, approssimativa, parziale, variabile, costituisce l’opera interminabile del genere umano. Così, mentre l’utopia comunista ha ancora i suoi praticanti, l’utopia dei liberali non ha potuto ricevere il minimo inizio di esecuzione.
Scartate l’ipotesi comunista e l’ipotesi individualistica, la prima in quanto distruttrice della personalità, la seconda in quanto chimerica, non resta da prenderne in esame che un’ultima sulla quale del resto la moltitudine dei popoli e la maggioranza dei legislatori sono d’accordo: quella della giustizia.
La dignità, nell’uomo, è una qualità altera, assoluta, insofferente di qualsiasi dipendenza e di qualsiasi legge che tenda alla dominazione degli altri e all’assorbimento del mondo.
Si ammette a priori che, davanti alla società di cui fanno parte, tutti gli individui, considerati semplicemente come persone morali, e fatta astrazione dalle capacità, dai servizi resi, dalle mancanze commesse, sono di ugual dignità; di conseguenza, essi devono ottenere per le loro persone la stessa considerazione, partecipare allo stesso titolo al governo della società, alla elaborazione delle leggi, all’esercizio delle cariche. [...]
Abbiamo visto che il comunismo parte dall’idea che l’uomo è un essere fondamentalmente non socievole e cattivo, homo homini lupus; che non ha nessun diritto da esercitare, nessun dovere da compiere verso i suoi simili; che la società sola fa tutto in lui, essa sola gli dà la dignità e fa di lui un essere morale. Non è altro che la decadenza umana posta come principio: cosa che ripugna alla nozione dell’essere e implica contraddizione.
Nel sistema della libertà pura, la dignità del soggetto, che si credeva di salvaguardare con una esagerazione in senso contrario, non è meno sacrificata. Qui l’uomo non ha più né virtù, né giustizia, né moralità, né socialità, poiché l’interesse solo fa tutto in lui, cosa che ripugna alla coscienza che non si lascia ridurre al puro egoismo.
L’idea giuridica sembra dunque, da quest’ultimo punto di vista, soddisfare le più nobili aspirazioni della nostra natura: essa ci proclama degni, socievoli, morali; capaci di amore, di sacrificio, di virtù; incapaci di conoscere l’odio se non attraverso l’amore, l’avarizia se non attraverso la devozione, la fellonia se non attraverso l’eroismo; e ciò perché essa si aspetta solo dalla nostra coscienza ciò che le altre concezioni impongono alla nostra sottomissione o sollecitano dal nostro interesse.
Per ciò che riguarda la società, metteremo in evidenza delle differenze analoghe.
Nel comunismo, la società, lo Stato, esterno e superiore all’individuo, gode da solo dell’iniziativa; al di fuori di lui nessuna libertà d’azione; tutto si assorbe in un’autorità anonima, autocratica, indiscutibile, la cui provvidenza benevola o vendicativa distribuisce dall’alto, sulle teste prostrate, le punizioni e le ricompense. Non è una cité, una società; è un gregge presieduto da un gerarca, al quale solo, per legge, appartengono la ragione, la libertà e la dignità dell’uomo.
Nel sistema della libertà pura, se fosse possibile ammetterne per un istante la realizzazione, ci sarebbe ancor meno società che nel comunismo. Poiché, da un lato, non si riconosce l’esistenza collettiva e, dall’altro, si pretende che per mantenere la pace non siano necessarie concessioni reciproche, e che tutto si riduca a un calcolo di interesse, l’azione politica o sociale diviene superflua: non vi è realmente società. È un’agglomerazione di individualità giustapposte, che marciano parallelamente ma senza nulla di organico, senza forza di collettività, dove la cité non ha nulla da fare, dove l’associazione, ridotta a una verifica di conti, è non dico nulla, ma quanto meno illecita.
Perché ci sia società tra creature ragionevoli bisogna che vi sia un ingranaggio delle libertà, una transazione volontaria, un impegno reciproco: cosa che non può farsi senza l’aiuto di un altro principio, il principio mutualista del diritto. La giustizia è commutativa per sua natura e forma; così la società, ben lungi dal poter essere concepita come esistente al di sopra e al di fuori degli individui, come accade nella comunità, deriva solo da essi, risulta dalla loro azione reciproca e dalla loro comune energia: essa ne è l’espressione e la sintesi. Grazie a questo organismo, gli individui, simili per la loro indigenza originale, si specializzano per i loro talenti, per le loro industriosità, per le loro funzioni; sviluppano e moltiplicano, a un grado sconosciuto, la loro azione e la loro libertà. In modo che arriviamo a questo risultato decisivo: volendo far tutto per mezzo della sola libertà, la si diminuisce; obbligandola a transigere, la si raddoppia.
Per ciò che riguarda il progresso.
La comunità, una volta costituita, lo è per sempre. Dunque niente rivoluzioni, niente trasformazioni: l’assoluto è immutabile. Il cambiamento le ripugna. Perché dovrebbe cambiare? Non consiste proprio nell’assorbire sempre più nell’autorità anonima ogni vita, ogni pensiero, ogni azione, nel chiudere gli sbocchi, nell’impedire il lavoro libero, il commercio libero e il libero esame? Il progresso qui è un nonsenso.
Con la libertà illimitata è naturale, ovviamente, che il progresso possa manifestarsi nell’industria, ma esso sarà nullo nella vita pubblica, nullo nelle istituzioni, perché secondo l’ipotesi, essendo identici il giusto e l’utile, confondendosi la morale e gli interessi, non vi è solidarietà sociale, non vi sono interessi comuni, né istituzioni.
Solo la giustizia, dunque, può essere detta progressista, poiché essa suppone un emendamento continuo della legislazione, secondo l’esperienza della vita di tutti i giorni, e pertanto un sistema sempre più fecondo di garanzie.
Del resto, ciò che costituisce il trionfo dell’idea giuridica sulle due forme ipotetiche del comunismo e dell’individualismo è che, mentre il diritto è sufficiente a se stesso, il comunismo e l’individualismo, incapaci di realiz...