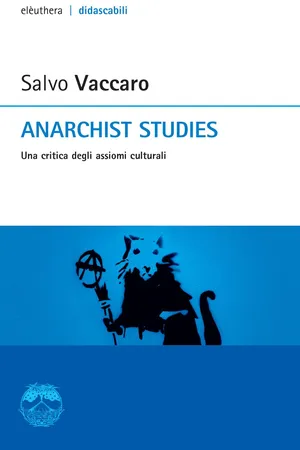
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Anarchist studies
Informazioni su questo libro
L'autorità, il potere e la sua visibilità, la filosofia occidentale e il pensiero anarchico, la rappresentanza e la rappresentazione dell'unità, il sapere e la conoscenza: ecco i temi portanti della critica che l'autore muove alle categorie implicite che sottendono, senza farsi notare, inavvertite, i più comuni postulati del nostro modo di ragionare. Tanto più nella politica, ossia in quella dimensione in cui è possibile immaginare un mondo e un modo di vivere diversi, lasciandosi alle spalle secoli di dominazione, di sfruttamento, di assenza di libertà. Criticando alcuni assiomi culturali, centrali nel nostro tempo, l'anarchismo come pensiero e come pratica collettiva ritrova la sua fecondità, instaurando fertili legami con altri segmenti del pensiero critico del ventesimo secolo, nell'intento di rilanciare una rinnovata proposta anarchica e libertaria all'altezza delle sfide che ci attendono nel ventunesimo secolo.
Salvo Vaccaro (Palermo, 1959) insegna Filosofia politica all'Università di Palermo.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
FilosofiaCategoria
Filosofia politicaquattro
E pluribus unum.
Una critica dell’Unità
Unità rimane la parola d’ordine,
da Parmenide a Russell.
Max Horkheimer, Theodor W. Adorno,
Dialettica dell’illuminismo
Pour Eckhart, il s’ensuit qu’il faut laisser
les principes. Non pas les annuler,
mais ne plus y recourir simplement.
Reiner Schürmann, Des hégémomies brisées
Prologo
È universalmente noto il celebre passo del ix libro dell’Odissea in cui viene narrata l’avventura di Ulisse con il ciclope Polifemo. Completamente svenuto per l’abbondanza di vino somministratogli da Ulisse, Polifemo si risveglia accecato nell’unico occhio, emettendo urla di dolore e di rabbia che richiamano l’attenzione degli altri ciclopi, i quali accorrendo in soccorso gli chiedono chi sia la causa di tali urla e per cosa. «Nessuno, amici, m’uccide d’inganno e non con la forza», risponde Polifemo, e così rassicurati gli amici ciclopi se ne vanno non senza invitarlo a pregare gli dèi per il male che lo affligge senza altrui responsabilità.
L’antefatto scenico che giustifica la paradossale risposta di Polifemo rappresenta uno dei numerosi passaggi epici in cui si narra l’astuzia di Ulisse. Naufragato nell’isola dei ciclopi, viene di fatto catturato nell’antro di uno di essi, Polifemo appunto, che trasgredisce le usuali leggi di ospitalità tipiche della civiltà greca e comincia a divorare uno dopo l’altro alcuni suoi compagni di equipaggio. Cercando la via di fuga e meditando la vendetta, alla richiesta di rivelare il suo nome, Ulisse così si svela:
«Ciclope, domandi il mio nome glorioso? Ma certo, lo dirò;
e tu dammi il dono ospitale come hai promesso.
Nessuno ho nome: Nessuno mi chiamano madre e padre
e tutti quanti i miei compagni».
Così dicevo; e subito mi rispondeva con cuore spietato:
«Nessuno io mangerò per ultimo, dopo i compagni;
gli altri prima;
questo sarà il dono ospitale»1.
Il passo evoca commenti di diversa natura, che spaziano tra gli altri dalla giusta punizione per aver infranto una legge fondamentale della civiltà greca, l’ospitalità sacra a Zeus, cifra di superiorità rispetto alle culture primitive cui appartenevano i ciclopi, al calembour linguistico (outis-metis) che testimonia la conoscenza da parte del Nome proprio Omero o della sua epoca rispetto al fondamento linguistico della specie umana, il cui cortocircuito avviato da Ulisse è ingestibile da una diversa specie quale rappresentavano i ciclopi cannibali, per finire al primato epistemico dell’occhio la cui cecità comporta la disfunzione comunicativa della parola in un’era anteriore alla centralità del logos2.
Forse è possibile azzardare un’ulteriore lettura di questo passo, di genere più prettamente filosofico-politico. Il gesto di Ulisse è un atto specificamente politico, un sabotaggio politico, che tuttavia non mira né a un rovesciamento di regime, né a una sostituzione della figura sovrana. L’attentato di Ulisse che priva Polifemo dell’unico occhio che tutto controlla e osserva, al centro del volto del ciclope come immagine epica e pre-visuale di ogni dispositivo panottico, non è teso ad abbattere il regime dei ciclopi né a sostituire Polifemo, bensì a sottrarsi alla sua cattura, alla sua presa dominante, letteralmente micidiale. La sottrazione politica difficilmente si integra nel codice politico che, da Aristotele in poi, legittima il nesso tra potere e politica solitamente attraverso un indice numerico pieno: Uno, Molti, Pochi (con le note derive patologiche introdotte da Aristotele per ogni corrispondenza).
Nella sottrazione, in gioco è proprio il codice della politica costruito da sempre sul suo nesso con il potere, mentre Omero mette in scena la sua decostruzione: l’indice numerico Nessuno destabilizza la comprensibilità del gesto politico, che pertanto non viene inteso in quanto tale poiché non corrisponde a nessun incrocio tra potere e politica. Nessuno sfugge al codice del potere, ma il suo successo deve essere immediatamente anestetizzato per venire relegato nell’angolo dell’impolitico, dell’impossibile politico: nessuno non può inaugurare un nesso dif/ferente tra politica e potere in cui la disgiunzione mostra la sua plausibilità sperimentale di riuscita, esattamente come narra il mito omerico.
Un’invenzione fatale
Solamente uno stile politico proteso al dominio dell’uomo sull’uomo può pensare come problema la pluralità effettuale dei membri di un consesso umano, con le loro volontà, passioni, interessi, da governare attraverso una strategia, posizionale e procedurale all’unisono, idonea a conferire a esso unità di corpo politico. Il dispositivo simbolico e performativo che gioca la trasposizione dei rispettivi aggettivi, da umano a politico, è la rappresentanza. In essa si instaura la frattura dualistica della società, già resa sostanza unitaria grazie all’egemonia di un immaginario politico dell’istituito, in governati e governanti, la cui divisione trova sforzo di ricomposizione dialettica nell’unità del corpo politico così dimidiato. Quel dispositivo simbolico occulta le tracce della propria performatività, in maniera da rendere natura seconda il peso della propria necessità: istituire un’auto-percezione del divenire-sociale di un consesso umano non in direzione della pensabilità del pluralismo istituente, bensì in direzione della gravità ontologica di un’unità istituita, cui dare il nome di politico.
Beninteso, lo squarcio di lettura qui appena aperto non intende affatto emarginare o sottovalutare altre prospettive sul dispositivo della rappresentanza, ugualmente rilevanti per la comprensione della politica3. Dalla più banale questione del rispecchiamento sociale a quella più cruciale del nesso di attivazione di presenza e assenza, dalle diverse tappe evolutive interne alla storia della filosofia politica, nell’intreccio di nomi propri e di ere ben specifiche, sino alla sempiterna radice iconica che qualifica la cultura dell’Occidente da Platone al primato del visuale dei giorni nostri, dalla decisiva rottura della modernità alla sua transvalutazione grammaticale nella teologia politica, la rappresentanza costituisce un inesorabile quadrillage concettuale da attraversare con prudenza e circospezione, in particolare in quei momenti in cui sembra che il suo dispositivo stia per collassare senza più rispondere alla funzione cruciale per la quale è stato letteralmente inventato.
Giacché, qualunque sia il modello prospettico adottato, di invenzione umana si tratta, da cogliere in quanto tale, trattenendo e restituendo le mosse e i vari contesti in cui si è giocato questo specifico dispositivo. Come peraltro ci insegna Weber, sono stati inizialmente i «principi», nella loro auto-percezione in quanto ceti privilegiati, a «liberare», per così dire, la rappresentatività vincolata e revocabile imponendo il divieto del mandato imperativo, grazie al quale il rappresentante acquista un primato sui rappresentati che pur lo eleggono, divenendo così loro «signore […] e non il loro servitore»4. Il target dell’unità del (corpo) politico è il banco di prova su cui decifrare le strategie di formazione e di funzionamento, ossia il suo ruolo sovrano.
Hofmann ha magistralmente illustrato le diverse fasi genealogiche attraverso le quali la rappresentanza si è declinata nella rappresentazione simbolica in segni di natura teologica. L’analisi è talmente poderosa e minuziosa che risulterebbe vana fatica ripercorrerla in pochi passaggi, meglio rinviare il lettore al testo. Qui interessa rilevare una notazione relativa alla mimesi teologica del dispositivo della rappresentanza in epoca cristiana, ossia un gesto concettuale di riproduzion...
Indice dei contenuti
- titolo
- colophon
- indice
- introduzione
- uno
- due
- tre
- quattro
- cinque
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Anarchist studies di Salvo Vaccaro in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Filosofia politica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.