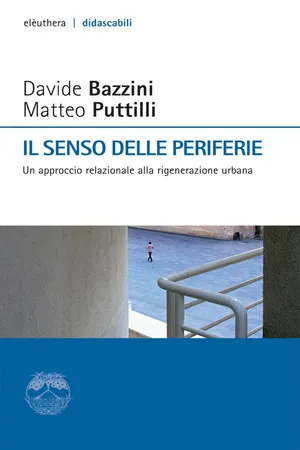![]()
capitolo quinto
L’esperienza di Mirafiori sud
1. Un esempio di approccio relazionale
Nel corso dei capitoli precedenti si è argomentata l’importanza di affrontare le trasformazioni urbane contemporanee attraverso un approccio fondato sulla relazione: una relazione trasversale al territorio, capace di mettere in comunicazione le persone, gli attori sociali, le istituzioni, gli accompagnatori sociali che operano insieme in un contesto urbano in via di trasformazione. In quest’ottica, è stata posta l’attenzione su alcuni elementi che ci sono sembrati fondamentali per poter assumere e praticare un approccio di tipo relazionale, che è la base sulla quale costruire gli interventi di facilitazione e accompagnamento sociale utili alla costruzione di comunità consapevoli.
Ora intendiamo esplorare l’ipotesi che l’intervento di accompagnamento sociale realizzato nell’ambito della riqualificazione urbana di Mirafiori sud, a Torino, possa essere una esemplificazione, certamente parziale e imprecisa ma comunque significativa, dell’approccio relazionale che abbiamo precedentemente delineato.
Anche in questo tentativo di applicazione a un territorio specifico dell’approccio relazionale manterremo salda la convinzione che tale approccio rappresenti una discontinuità rispetto alla prevalente tendenza economicista degli interventi orientati allo sviluppo locale, in cui è facile osservare come la performance economica sia l’indicatore principale attraverso il quale vengono raccontati i territori.
Questa tendenza economicista è a volte lo sfondo sul quale vengono proposti interventi che potremmo definire identitari più che relazionali. Il riferimento è dunque a quegli interventi che, per comunicare verso l’esterno un territorio coeso, omogeneo, competitivo dal punto di vista economico, puntano a una logica relazionale esclusiva e non inclusiva, basata sulla crescita del consenso interno, che è di solito ottenuto con il richiamo alle sirene identitarie, con l’invenzione della tradizione, con la riscoperta di antichi riti e miti fondativi più o meno posticci. Una logica in cui è lo stesso operatore che lavora sul territorio a stimolare la produzione e la condivisione di valori identitari e comunitari al fine di aumentare, dall’esterno, il grado di coesione e saldatura delle relazioni sociali.
Ora, gli studi più recenti sui concetti di comunità e di identità collettiva rilevano come queste comunità «rivolte al passato» in effetti non esistano. Ad esempio, Francesca Governa1, riprendendo scritti di Bagnasco, osserva come le comunità contemporanee (così come i territori) vadano costruite riferendosi alla capacità di agire le relazioni nel presente, attraverso una capacità di progettazione e di relazione collettiva degli attori verso il futuro, e non attraverso il richiamo a presunti elementi identitari del passato. Questi, certamente, possono entrare a far parte del processo identificativo, ma non possono esserne in alcun modo il fondamento, se si vuole costruire una società «viva», capace di produrre territorio e comunità, e non semplicemente una società ricettrice passiva di interventi esterni.
L’approccio relazionale deve innanzi tutto prestare attenzione a evitare che la sua stessa essenza risieda nella logica identitaria, maneggiando con cura i concetti di identità e comunità e badando a non rinchiuderli in una logica inclusiva o neocomunitarista. Ecco allora che, per descrivere e verificare la dimensione relazionale dell’intervento di riqualificazione urbana e l’accompagnamento sociale realizzati a Mirafiori sud, evitando semplificazioni economiciste o identitarie, occorre una chiave di lettura che riporti le dinamiche sociali al centro dell’attenzione. Detto altrimenti, è necessario verificare se e come gli interventi di riqualificazione urbana e le azioni di accompagnamento sociale ivi condotte siano stati in grado di produrre capitale sociale e capacità relazionale; se e come siano riusciti a stimolare la capacità degli attori di relazionarsi tra loro e di ricostruire il territorio attraverso queste reti di relazione; se e come sia cresciuta la capacità di autogoverno.
Senza pretendere di porci in una prospettiva di tipo valutativo, che richiederebbe certamente un’analisi differente, cercheremo quanto meno di descrivere come sia stato tentato un approccio relazionale in via Artom, a Torino, e quali esperienze di autogoverno abbia generato. Lo faremo concentrandoci su tre macroambiti sui quali si è maggiormente lavorato sul territorio:
a) l’auto-organizzazione nell’ambito dell’abitare e dell’housing;
b) la progettazione partecipata degli spazi;
c) la costruzione di una conoscenza territoriale partecipata.
2. Un quartiere che cambia
Via Artom, Mirafiori sud: simboli, loro malgrado, della città fordista, dell’esplosione delle periferie urbane, della loro difficile integrazione nel tessuto urbano. Simboli, loro malgrado, della città operaista, di un boom economico che ha ammassato nelle città del nord l’Italia contadina.
Ma al contempo Via Artom, Mirafiori sud, sono anche il tentativo di vedere, provare, sperimentare la rigenerazione urbana, la ricostruzione e il mantenimento del tessuto sociale. Sono il tentativo di fare tutto ciò coniugando gli interventi diretti, materiali (siano essi urbanistici o edilizi), con una serie di azioni più immateriali, legate alla formazione, alla capacità di auto-organizzazione, all’avvio di processi di sviluppo locale.
Via Artom, Mirafiori sud, sono dunque il teatro di un’azione di trasformazione urbana giocata attorno a un paradosso, a una scommessa: è possibile fare interventi, anche pesanti, sul tessuto urbano ed edilizio di un quartiere usando, nella gestione delle dinamiche sociali che quell’intervento genera, delle logiche relazionali, delle modalità inclusive e partecipative? I rapporti tra l’approccio relazionale e quello interventista si sono insomma sviluppate, nel caso di via Artom, nella viva carne di un quartiere. Nel provare a descrivere la relazione tra i due approcci, come prima li abbiamo delineati, l’esperienza di rigenerazione urbana di Mirafiori sud può essere paradigmatica. Proviamo allora a descrivere gli elementi che connotano l’aspetto relazionale delle azioni condotte su via Artom, partendo dall’inquadrare il quartiere stesso nel suo contesto storico-geografico (riprendendo qui la ricostruzione operata da Angelo Castrovilli e Carmelo Seminara2.
Nel 1585 il duca Carlo Emanuele i dona alla giovane moglie la Villa Pellegrina, sulle sponde del Sangone. La giovane moglie si chiama Caterina, Caterina d’Asburgo; è spagnola e il nome della villa diventa in suo onore un invito: Miraflores, «guarda i fiori». Il nome e l’invito finirono per designare anche il borgo e la chiesa. Con quel nome, Mirafiori, nasce nel 1866 una parrocchia autonoma.
Nel 1910, il 13 e il 15 novembre, nel cielo di Mirafiori volano i primi aerei: decollano e atterrano in mezzo al prato di quello che oggi è il Parco Colonnetti. Nel 1936 gli aerei nel cielo di Mirafiori non sono più una novità: il primo aeroporto di Torino, denominato «Gino Lisa», nasce proprio lì, davanti agli attuali palazzoni di via Artom. Nel 1939 viene costruito lo stabilimento di Fiat Mirafiori e le zone circostanti cominciano a essere edificate con le «Case Fiat». Gli anni successivi sono anni di guerra. Una guerra che si porta via anche la giovane vita di Emanuele Artom, partigiano torturato e morto poco più che ventenne, cui verrà intitolata la via che attraversa il quartiere.
Dopo la guerra, la città cresce: nel 1951 gli abitanti sono 719.300, nel 1958 sono 916.652, nel 1963 1.114.300. Gli uomini e le donne del sud arrivano a Torino con le loro povere cose e le loro ricche speranze. In molti non trovano nemmeno una casa. Nel 1962 il governo Fanfani approva la legge 167, che dota i comuni di strumenti per procedere a esproprio delle aree fabbricabili a prezzi inferiori di quelli del mercato speculativo. Nello stesso anno il comune delibera l’incremento del «Piano Torino Casa» con la previsione di costruire circa 800 alloggi da assegnare in locazione: al bando si presentano in 13.000. Tra il 1963 e il 1971 l’intervento pubblico (Gescal, iacp, Poste, ecc.) favorisce la costruzione di quasi 17.000 alloggi. L’area dell’ex aeroporto «Gino Lisa» viene destinato all’Edilizia residenziale pubblica (erp): i nuovi quartieri vengono ...