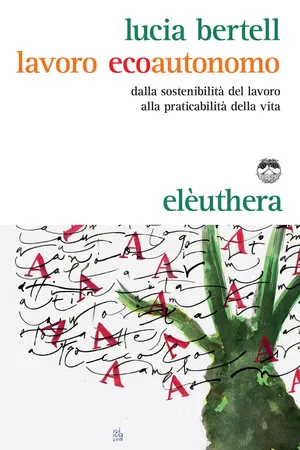![]()
capitolo terzo
Non di economia si tratta.
Dalla sostenibilità del lavoro
alla praticabilità della vita
Se vogliamo che la soggettività rifugga il regime di mercificazione peculiare della nostra epoca storica, è necessario un salto qualitativo (…) Noi abbiamo bisogno di divenire quel tipo di soggetti che desiderano attivamente reinventare la soggettività come insieme di valori mutevoli e che traggono il loro piacere da questa attività, non dalla perpetua riproposizione di regimi familiari.
Rosi Braidotti
Non sapendo che era impossibile, andò e lo fece.
Mark Twain
Ci si arriva come se si entrasse in una matrioska o in una di quelle scatolette chiuse l’una dentro l’altra e che, una volta aperte, riempiono la tavola. Un centro città dentro la città, una piazza dentro il centro città, una corte dentro la piazza, una libreria dentro la corte. Ma non è proprio finita così perché quando si arriva alla libreria non c’è subito la libraia ma ci sono una piccola vetrina illuminata da una lampadina dentro una bottiglia di plastica diventata un fiore, libri a non finire (ma questo è ovvio in una libreria), copertine di stoffa con dentro libri, per chi li ama come il proprio cane, una scultura femminea che accoglie gli avventori e poi, in fondo a sinistra, un mobile alto di quelli da piccole reception, la cui altezza è amplificata dalle pile di libri in attesa di essere schedati. Quando si è nel mezzo della stanza una testina si solleva dal lavoro: buonasera, Roberta… Una libraia dentro la libreria.
«È un lavoro che non è un lavoro di fatto, è un modo di vivere, probabilmente».
Il breve racconto a introduzione di questa terza parte, che è il cuore del libro, riguarda una delle protagoniste della ricerca, una lavoratrice ecoautonoma, che subito ci porta nella sostanza emersa dalle voci dirette dei protagonisti e spiega che non di economia si tratta, ma di vita.
Il mio lavoro di ricerca con il gruppo tilt e con la Rete di Economia Solidale di Verona, con i Bilanci di Giustizia a livello nazionale e con altri gruppi e circuiti collegati alle economie diverse e a pratiche di cittadinanza dal basso, si è ampliato fino a includere nella comunità di ricerca i cosiddetti «portatori di pratiche», in primis tra il Veneto e la Sardegna, ma anche con altre realtà nazionali e non. Tutto ciò spinti da alcune domande di ricerca riguardanti dapprima le loro pratiche di apprendimento e circolazione del sapere e in seguito il loro «lavorare» e le loro pratiche di «benessere». Sono partita dal chiedermi cosa muove le persone che scelgono di lavorare diversamente, in una posizione che vuole essere fuori dall’organizzazione così come intesa dal sistema di mercato; donne e uomini che lasciano lavori o possibilità/immaginario di lavori certi e continuativi per intraprendere attività che si collocano ai confini del sistema capitalista, definendo così altre organizzazioni e differenti modi di lavorare che mettono radici e si fondano su nuove premesse.
Ciò che è emerso è stato un approccio al lavoro che ha a che fare con la vita, non con il profitto. Per i nostri protagonisti e le nostre protagoniste, il lavoro prende altri significati da quelli comunemente concettualizzati dalla sociologia o dalla psicologia del lavoro, si muove da altri presupposti, prende altre corporature che informano in modo nuovo l’organizzazione dei processi, delle reti, dei luoghi di scambio (in senso lato) e dei contesti sociali1.
Le esperienze prese in considerazione si caratterizzano per le loro specifiche motivazioni, pratiche d’azione e manifestazioni organizzative, che problematizzano le tradizionali modalità di produzione e consumo e il rapporto che tra esse si instaura. Non ho incontrato lavoratori ecoautonomi che non fossero in stretta relazione con consumatori critici (co-produttori) organizzati in gas o meno, ma anche che non fossero in stretto rapporto (come vedremo tra poco) con altre lavoratrici e altri lavoratori produttori ecoautonomi.
Il lavoro è per loro non più una merce (Gallino 2009), un mezzo di accumulo, quanto, una delle attività necessarie all’esistenza. Tutto ciò in sintonia con quanto mostrato – da un punto di vista storico-teorico – da Dominique Méda, Ivan Illich, Jean-Pierre Vernant, Philippe Godard e altri, che riposizionano il lavoro, così come oggi lo intendiamo, in un breve e recente tratto della storia dell’umanità, restituendo dignità a un pensiero sul e del lavoro aderente alle vite e non all’economicismo capitalista.
Come emerge da un precedente studio di casi, dove mi ero posta soprattutto la domanda «perché lo fanno?», le donne e gli uomini impegnati nel lavoro/produzione che ho intervistato risultano essere portatori di lavoro come di un fattore esistenziale connesso alle altre vite, umane o meno. Certamente non portano con sé l’idea di lavoro così com’è nel nostro immaginario moderno. Non sono lavoratori immersi in un’etica del lavoro strumentale dove il lavoro è funzionale al reddito e questo al consumo. Il lavoro è, piuttosto, un’istanza personale (che poi si sposa anche a valori di condivisione e collaborazione) e risponde in primis alla necessità interiore che anche l’attività lavorativa, oltre al resto della vita, possa essere in armonia con le scelte riguardanti uno stile di vita rispettoso dell’ambiente, degli animali, e attento alle questioni di giustizia sociale. L’adesione a un nuovo stile di vita e, anche, il malessere dovuto all’incapacità di aderire a un mondo dominato dalla strumentalità spingono a ricercare strade di benessere concrete e alternative che non si limitano a una militanza ideologica (Secondulfo 2011).
Quel che emerge è che il lavoro è tenuto nella vita proprio come espressione, testimonianza di ciò che si è: «Molto spesso noi abbiamo bisogno di mettere quel che siamo noi nel lavoro che facciamo»; «Per me non c’è differenza fra vita e lavoro, io non è che vengo a lavorare, altrimenti non so se ce l’avrei fatta, mi piace»; «Non è solo passione, è sentirmi a casa mia quando sono in campagna».
Il lavoro è un medium per sentirsi orgogliosi di sé, del proprio essere e del proprio saper fare: «In campagna ero qualcosa, dovevo fare qualcosa che mi piacesse e di cui essere orgogliosa anche»; «Ne sono orgoglioso comunque perché siamo consapevoli che la nostra esistenza è basata sul nostro modo di affrontare i problemi».
Il lavoro è ricerca di significazione della vita: «Vedo che ci sono molti vuoti di significato anche nella maniera in cui è stato inteso il lavoro. Il lavoro come reddito lascia un vuoto di significato».
Questo tenere il lavoro nella vita, a partire da o a causa di una necessità esistenziale, si radica in una critica alla mercificazione della vita e in pratiche quotidiane di resistenza al sistema dominante.
Molto si è parlato e si parla di lavoro e del cambiamento delle forme del lavoro, ma è disponibile ancora poca letteratura su questi «lavori fuori pista» che solcano percorsi non mappati dalle carte degli studi ufficiali, interconnessi a processi di consumo critico e cambiamenti radicali nello stile di vita (dove invece comincia a esserci una certa letteratura).
Le nuove forme di socialità – le Reti di economia solidale con i gas, i Bilanci di Giustizia, le reti di permacultori, le sperimentazioni degli ecovillaggi, alcune comuni storiche, i centri di sperimentazione all’autosviluppo, i genuini clandestini – sono improntate sulla valorizzazione delle dimensioni relazionali e di reciprocità e attivano un modo diverso di intendere e organizzare i processi di produzione. I lavoratori-produttori ecoautonomi, come li ho chiamati, intrattengono uno stretto legame con il territorio e costruiscono relazioni durature e simmetriche con altri attori della società e dell’economia locale, attraverso una focalizzazione sul valore d’uso e non di mercificazione delle risorse locali e altri processi di profondo ripensamento dell’agire economico dominante.
All’atteggiamento strumentale o espressivo, con il quale si guarda tradizionalmente al lavoro, si vanno associando altre attenzioni, relative ai legami sociali, all’impatto sull’ambiente, alla compatibilità fra vita e lavoro, e così via. In sintesi, in questa prospettiva si vanno facendo più complesse le culture del lavoro perché le persone manifestano una forte tensione nella ricerca di senso nel lavoro. È in ...