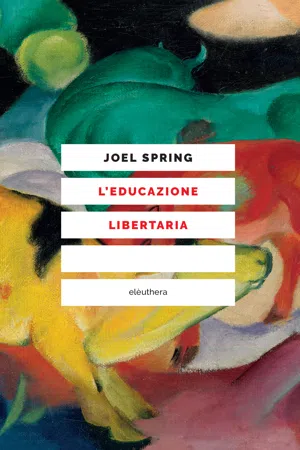![]()
capitolo quarto
La rivoluzione sessuale e Summerhill
Senza dubbio il concetto di possesso di se stessi elaborato da Max Stirner e la metodologia educativa realizzata da Paulo Freire mirano a trasformare i fondamenti stessi dell’individuo. Ma uno dei limiti delle loro tesi sta nel fatto che la struttura caratteriale ha le sue radici profonde nelle prime fasi dello sviluppo psichico del bambino. Se il bambino matura un tipo di condotta sociale autoritaria o non autoritaria può infatti dipendere più dalla prima fase dello sviluppo che dalle successive forme di socializzazione come l’educazione formale.
Del tutto ovviamente, l’attenzione per le pratiche utilizzate in puericultura e la loro relazione con una possibile rivoluzione sociale e politica si è andata concentrando sull’organizzazione stessa della famiglia. Da qui è scaturito un ampio dibattito sulla validità delle pratiche educative collettive, in alternativa a quelle della tradizionale famiglia nucleare, le cui figure di maggior rilievo sono state Wilhelm Reich e Alexander S. Neill, che tra l’altro, negli ultimi anni della loro attività, hanno collaborato strettamente.
La convinzione di Reich che il tipo di educazione infantile sia direttamente correlato alle forme di organizzazione sociale deriva dal suo tentativo di combinare la sociologia marxista con una reinterpretazione dell’analisi freudiana. Reich ritiene possibile che il popolo si sbarazzi dell’irrazionalità della politica e del governo e realizzi quella che chiama una «democrazia del lavoro», fondata su una struttura caratteriale capace di auto-regolarsi: una società priva di istituzioni autoritarie, ivi compreso lo Stato, dove le relazioni sociali si sviluppano a partire dalle organizzazioni economiche create dai lavoratori stessi. Reich non solo stabilisce una relazione tra la struttura caratteriale autoritaria, che auspica il controllo delle istituzioni autoritarie, con i metodi educativi applicati durante l’infanzia e la repressione sessuale, ma dichiara con forza che il compito prioritario della pedagogia, nel ventesimo secolo, deve essere la liberazione sessuale e l’abolizione della famiglia patriarcale. Quando nel 1937 Neill, che ha fondato la scuola di Summerhill in Inghilterra, incontra per la prima volta Reich, gli dirà: «Reich, tu sei l’uomo che ho cercato per anni, l’uomo che è riuscito a unificare l’aspetto somatico con quello psichico. Posso essere un tuo allievo?»1. Una collaborazione che, come vedremo in seguito, sarà fondamentale per l’evoluzione delle idee di Neill.
Per comprendere la teoria reichiana della struttura caratteriale auto-regolata si devono prima capire le differenze che ci sono con le teorie di Freud. Uno dei punti fondamentali in cui differiscono è la natura dell’aggressività. Freud, in accordo con una filosofia sociale estremamente conservatrice, sostiene che l’aggressività è un istinto umano innato e che il rapporto di ognuno con la civiltà e il proprio Io va descritto in termini di una contrapposizione tra gli istinti conflittuali di thanatos ed eros e la realtà. In Das Unbehagen in der Kultur (Il disagio della civiltà), Freud asserisce che l’ordine sociale può essere mantenuto solo con la repressione e il controllo dell’istinto aggressivo di thanatos: tale controllo è appunto la funzione delle istituzioni autoritarie. Il quadro che Freud fa della civiltà non è né gradevole né promettente: l’umanità è dilacerata tra eros, la passione di abbracciare il mondo, e thanatos, il desiderio di distruggerlo. Con il progredire della civiltà, gli istinti aggressivi devono essere repressi, il che comporta un atteggiamento aggressivo verso il proprio Io e crescenti sensi di colpa. Per Freud, l’inevitabile prezzo che l’umanità deve pagare al progredire della civiltà è un aumento dell’autorità e del senso di colpa2.
Se la si assume, questa visione culturale toglie ogni fondamento al pensiero utopico e rivoluzionario: accettando Freud, il massimo che uno può sperare di conseguire è una misera tregua tra il proprio Io e la società. Le istituzioni autoritarie appaiono quindi necessarie per controllare l’istinto aggressivo e per guidare lo sviluppo di un forte Super-io. Sostanzialmente, la tesi freudiana rimanda a posizioni del tipo law and order, in quanto avanza l’ipotesi che se la polizia, le leggi e i tradizionali metodi autoritari per educare i bambini fossero eliminati, ne risulterebbe lo scatenarsi di thanatos in un bagno di sangue di distruzione reciproca.
Reich respinge la concezione freudiana dell’istinto di morte ed è convinto, al contrario, che i tratti caratteriali crudeli e aggressivi siano il risultato di pratiche educative autoritarie e sessualmente repressive. La repressione sessuale porta a una forte paura del sesso, che a sua volta causa una più generale paura del piacere. Per Reich, l’incapacità di provare piacere e i tratti caratteriali aggressivi vanno sempre di pari passo, come peraltro risultano legati la capacità di provare piacere e i tratti caratteriali non ostili. Al centro della concezione reichiana del piacere ci sono gli impulsi sessuali. A differenza di Freud, convinto che tali impulsi fossero in conflitto con gli istinti aggressivi, Reich vede l’aggressività come una conseguenza della repressione degli impulsi sessuali. Negli anni Venti, confrontando i tratti caratteriali sadici con quelli non sadici, scrive: «La mitezza e la gentilezza negli individui capaci di soddisfazione genitale risultano per converso impressionanti. Non ho mai visto individui capaci di soddisfazione genitale che avessero tratti caratteriali sadici»3.
Il carattere rivoluzionario delle tesi reichiane sta nel fatto che queste offrono non solo la possibilità di ideare un sistema educativo e un’organizzazione sociale tali da eliminare l’aggressività e l’autoritarismo, ma anche un metodo per analizzare le strutture politiche in base ai loro sistemi educativi. A strutture politiche autoritarie e repressive generalmente corrispondono pratiche educative che riflettono le stesse caratteristiche, cosa certamente vera, afferma Reich in Psicologia di massa del fascismo, nel caso dell’avvento del nazismo in Germania. Ma anche la Rivoluzione russa, come chiarisce in Die Sexualität im Kulturkampf (La rivoluzione sessuale), non ha mantenuto le promesse dei primi anni (etica rivoluzionaria e metodi sperimentali nell’educazione e nella puericultura), instaurando di conseguenza una società autoritaria e non quella società non repressiva che auspicava inizialmente.
Tra i primi obiettivi di un movimento rivoluzionario ci deve quindi essere la liberazione della struttura caratteriale dell’individuo. Il che, aggiunge Reich, non può essere raggiunto a livello di massa attraverso il ricorso alla psicoterapia. Se le strutture sanitarie psichiatriche possono aiutare un certo numero di pazienti, la loro incidenza globale è abbastanza limitata. Negli anni Venti, dopo aver lavorato per otto anni in una clinica psicoanalitica, Reich si rende conto che «la psicoanalisi non è una terapia che si possa applicare su larga scala»4, dato che in clinica ogni paziente richiede un’ora giornaliera di terapia per almeno sei mesi. La sola speranza risiede perciò nella prevenzione. Il che significa liberare la società da quelle che Reich considera le sue istituzioni più repressive, basate su una morale sessuale repressiva: non solo la famiglia patriarcale ma anche il matrimonio coercitivo, espressione di quella concezione sociale tradizionale che vuole il rapporto sessuale limitato al matrimonio, il quale va poi rispettato e mantenuto per l’intera vita della coppia.
L’importanza attribuita da Reich alle trasformazioni istituzionali rivoluzionarie riflette bene il suo rifiuto della tendenza conservatrice in psicologia e l’interesse per la filosofia sociale marxista. Sente dunque l’esigenza di marcare la differenza tra psicologia reazionaria e psicologia sociale, e lo fa evidenziando il tipo di domande che vanno sollevate di fronte a individui che rubano perché affamati o che scioperano perché sfruttati. La psicologia conservatrice, sostiene Reich, cerca «di spiegare il furto e lo sciopero in termini di motivazioni suppostamente irrazionali, con l’inevitabile risultato di una razionalizzazione reazionaria». Dal canto suo, la psicologia sociale non dovrebbe sentire il bisogno di spiegare perché certe persone rubano quando hanno fame o scioperano quando si ritengono sfruttate, ma dovrebbe piuttosto cercare di spiegare «perché la maggior parte di quelli che hanno fame non rubano e perché la maggior parte degli sfruttati non scioperano»5.
Reich sente che i problemi sollevati dalla psicologia sociale forniscono l’elemento mancante alla filosofia sociale marxista. Alla sociologia scientifica di Marx mancavano infatti gli strumenti per spiegare come mai tutti i lavoratori sfruttati non scendessero in sciopero: il marxismo riusciva a spiegare la razionalità e le modalità dello sfruttamento, ma non riusciva spiegare perché i lavoratori accettassero di essere sfruttati. E in effetti le spiegazioni socio-economiche non possono dar conto degli atteggiamenti e comportamenti che sono incongruenti con il contesto definito dagli interessi economici. Reich è convinto che Marx non avrebbe saputo spiegare perché la maggior parte dei lavoratori tedeschi avesse appoggiato l’avvento del nazismo. A suo avviso, ciò che è mancato in Germania ai movimenti contrari alla dittatura «è stata la comprensione dei comportamenti irrazionali, apparentemente immotivati, o, in altre parole, della sfasatura tra economia e ideologia». Bisogna invece rendersi conto non solo che, come affermava Marx, «le idee della classe dominante sono le idee dominanti», ma che, come afferma Reich, «ogni regime sociale produce nella massa dei propri membri quella struttura caratteriale di cui ha bisogno per raggiungere i propri obiettivi fondamentali». Nel caso del nazismo tedesco, la struttura caratteriale autoritaria delle masse è stata una diretta conseguenza della natura repressiva della famiglia tedesca6.
Reich ritiene che ogni individuo abbia una «corazza» caratteriale che si manifesta nell’incapacità di agire in maniera spontanea e naturale e che deriva dall’esperienza storica dell’individuo: «Tutta l’esperienza passata vive nel presente sotto forma di attitudini caratteriali. La struttura di una persona è data dalla somma funzionale di tutte le esperienze passate». La terapia individuale è il tentativo di aprirsi un varco negli strati di quella «corazza», ed è grazie a questo processo terapeutico che Reich scopre come nel carattere individuale l’istinto di distruzione sia solo rabbia dovuta alla frustrazione, in generale, e alla negazione della gratificazione sessuale, in particolare. In questo contesto, l’istinto distruttivo è una reazione all’incapacità di provare piacere, un’incapacità che determina una paura del piacere e una corazza caratteriale in grado di innalzare una barriera tra l’individuo e il piacere, inducendo a un atteggiamento ostile verso tutte le esperienze che producono piacere. Secondo Reich, la paura del piacere e la corazza caratteriale possono spiegare come mai la gente sia disposta a sacrificare la propria felicità a favore delle istituzioni autoritarie e delle consuetudini sociali. Oltretutto, la corazza caratteriale porta le persone non solo a vivere un’esistenza priva di gioia, ma a esigere che anche gli altri si conformino a queste struttur...