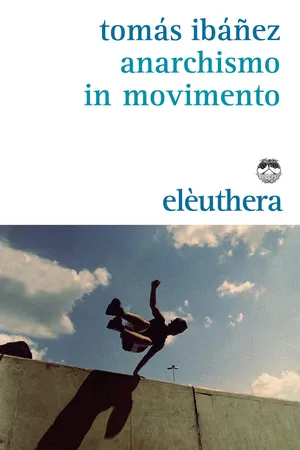![]()
appendice 1
Dalla modernità alla post-modernità
Il periodo che stiamo vivendo in questo inizio di xxi secolo si inscrive interamente nel quadro generale della modernità o al contrario si avvertono già i primi indizi di una trasformazione sufficientemente radicale da permettere di parlare dell’avvento di una nuova epoca storica?
Le opinioni al riguardo sono discordanti e, al momento, non ci sono evidenze certe a favore di nessuna delle due opzioni. Ciononostante, mi arrischierò a sostenere la tesi che la modernità, pur essendo un’epoca storica ancora del tutto vigente, è però entrata in una fase di transizione verso un’altra epoca, che per comodità chiamerò post-modernità.
Da una parte, è conclamato che in pochi decenni si sono prodotti, tanto in campo tecnologico quanto geo-politico o economico, cambiamenti di grande portata che hanno influito sulla società nel suo complesso. Questi cambiamenti non si contraddistinguono solo per la loro ampiezza, ma anche per la costante accelerazione del ritmo con cui si producono. È fuor di dubbio che l’attuale velocità dei processi di cambiamento rappresenta un fattore inedito che marca la differenza con i secoli precedenti, quando i processi evolutivi erano molto più lenti.
Dall’altra parte, ogni epoca produce l’ideologia che la legittima e la modernità non sfugge a questa regola. La sua ideologia legittimante, che si è formata essenzialmente durante l’Illuminismo, oggi non rappresenta più l’unico modo di apprendere il mondo e – sintomo forse del cambio d’epoca già in corso – è fatta oggetto di critiche radicali. A questa regola non sfugge neanche la post-modernità, che attualmente sta generando la propria ideologia legittimante anche attraverso una decisa opposizione ai postulati della modernità.
Passiamo ora brevemente in rassegna le caratteristiche della modernità e della post-modernità in quanto epoche storiche e in quanto ideologie legittimanti di quelle epoche.
La modernità come epoca storica
Come tutte le epoche, la modernità ha un inizio e una fine. Con «un inizio» non si deve però intendere un’origine precisa, ma un processo di costituzione più o meno lungo. Il riferimento a «una fine» allude a un periodo di decadenza, anch’esso più o meno lungo, che fa da preludio al suo esaurimento e alla nascita di una nuova epoca. In effetti, la modernità non appare in un momento preciso, già provvista di tutti i suoi attributi: i diversi elementi di cui è composta si costituiscono progressivamente durante un periodo di vari secoli. Allo stesso modo, nemmeno la loro scomparsa sarà improvvisa.
L’epoca moderna ha cominciato a prendere forma in Europa a partire dal xv secolo, durante il Rinascimento, con fenomeni quali la costruzione di una nuova razionalità scientifica, l’invenzione della stampa, i progressi nell’arte della navigazione o la conquista del Nuovo Mondo… Tuttavia, è solo nel xviii secolo, con l’Illuminismo, quando fanno la loro comparsa lo Stato-nazione o la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, che si configura effettivamente e che articola nitidamente il suo discorso legittimante.
Uno dei tratti fondamentali della modernità è il suo legame inscindibile con la favolosa impresa della «Scienza», i cui effetti sul nostro modo di essere, vivere e pensare sono stati enormi. Di fatto, la modernità nasce in concomitanza con un insieme di innovazioni tecnologiche che danno origine a un nuovo modo di produzione, il capitalismo, che si configura nel corso dei secoli, dando avvio a un processo di industrializzazione che si accelera e generalizza nella seconda metà del xix secolo.
Per comprendere il processo di costituzione della modernità, vale la pena soffermarsi alcuni istanti su ciò che alcuni ricercatori, come Pierre Lévy, hanno chiamato le «tecnologie dell’intelligenza». Queste tecnologie, inscrivendosi nel processo stesso del pensiero e avendo per funzione ed effetto di rendere possibili determinate operazioni concettuali non del tutto realizzabili prima della loro comparsa, consentono l’emergere di nuove forme di pensiero. La scrittura, che ha avuto innumerevoli effetti sulla produzione di conoscenza, e la stampa ne sono due esempi importanti.
L’invenzione della stampa, o più precisamente la diffusione sociale del suo utilizzo, segna l’inizio della modernità. Innovazione cruciale, essa ha permesso, grazie ai libri e alle loro implicazioni, la costituzione della ragione scientifica. E questo perché la stampa non è solamente un vettore di diffusione e socializzazione delle conoscenze, ma incide anche sul modo in cui queste vengono presentate e prodotte, influenzando così la forma e la natura stessa di queste conoscenze. Gli effetti del libro stampato vanno ben oltre una semplice facilitazione della circolazione dei testi. Per esempio, se il soggetto umano – autore o semplice trascrittore che sia – è costantemente presente nel manoscritto, la sua presenza si attenua nella pagina stampata, il che contribuisce a costruire l’idea di oggettività, cruciale per la ragione scientifica moderna. Anche le tabelle, le immagini e i grafici, che vengono riprodotti in molteplici copie senza la minima differenza tra loro, concorrono a oggettivare la rappresentazione come qualcosa di certo e affidabile, favorendo lo sviluppo di un’ideologia della rappresentazione che è uno dei principali elementi del discorso della modernità.
Come la stampa nel xv secolo, tutte le grandi innovazioni nel campo delle tecnologie dell’intelligenza hanno impresso alla società dei veri e propri sconvolgimenti. Non deve quindi sorprendere che anche la comparsa del computer e dell’elaborazione informatica dei dati a metà del xx secolo abbia avuto effetti sociali profondi.
L’ideologia della modernità
Malgrado la considerevole eterogeneità delle concezioni e delle analisi che hanno plasmato la visione del mondo propria della modernità, è possibile abbozzare i tratti generali che la definiscono. La Riforma di Martin Lutero e l’Umanesimo di Erasmo da Rotterdam hanno certamente contribuito a elaborare il suo discorso, ma a darle corpo è stata la filosofia dell’Illuminismo, definendone più precisamente i contenuti. Li possiamo sintetizzare negli undici aspetti che seguono:
Il primo è l’ipervalorizzazione della ragione. In base a una concezione teleologica della storia, secondo la quale questa avanzerebbe verso una meta determinata, la ragione scientifica e la ragione in generale appaiono come vettori di progresso e di emancipazione. Secondo questa visione, la storia parte da un’origine e progredisce in una direzione, che è quella corretta solo se è la ragione a guidarla. Nel corso del processo teso a istituire la ragione come l’elemento centrale – distintivo del nostro «io», secondo Descartes – si è giunti a postulare una relazione intrinseca tra ragione e libertà, tra ragione e progresso, tra ragione ed emancipazione. In quest’ottica, un incremento di razionalità comporterebbe un incremento di libertà e di progresso sociale. La ragione sarebbe quindi intrinsecamente emancipatrice.
Il secondo aspetto rimanda all’ideologia della rappresentazione. Questa ritiene che la conoscenza sia una rappresentazione della realtà e ne subordina la validità al fatto che rappresenti correttamente tale realtà. In quest’ottica, la conoscenza è, in qualche modo, una trascrizione del reale, una sua traduzione in un altro piano – il piano della conoscenza – che deve essere il più fedele possibile. Affermando tale possibilità, il discorso della modernità instaura così una dualità, una dicotomia oggetto-soggetto che si protrarrà per tutto il periodo moderno.
Il terzo aspetto consiste nell’adesione all’universalismo e alla credenza che la verità – e i valori – poggerebbero su basi di una validità assoluta e incontestabile. Di fatto totalizzanti, le concezioni della modernità si presentano come valide per tutti gli esseri umani e tutte le epoche. È questa la ragione per cui le grandi narrazioni, le metanarrazioni della modernità, si esprimono sempre in termini di valori e progetti di carattere universale.
Il quarto aspetto si ricollega all’affermazione della centralità del soggetto e della coscienza. Dato per autonomo, il soggetto, in linea di principio, può arrivare a essere padrone di se stesso e attore della propria storia. Allo stesso modo, la coscienza può arrivare a essere trasparente a se stessa. Diversi importanti pensatori della modernità hanno segnalato possibili vie attraverso le quali la coscienza può liberarsi dall’alienazione e arrivare a essere trasparente a se stessa, ma è stato Karl Marx a formulare l’analisi sociale più pertinente delle determinazioni che alienano la coscienza e ne offuscano la trasparenza.
Il quinto aspetto riguarda l’adesione a un umanesimo basato sulla credenza che esista una natura umana essenziale e, più in generale, nell’adozione di una concezione essenzialista. Anche se l’essenzialismo non è esclusivamente moderno, dato che pervade l’intera filosofia occidentale, rappresenta però il postulato della modernità che più incisivamente è stato messo in discussione dal post-strutturalismo (si veda in specifico l’Appendice dedicata al post-strutturalismo).
Il sesto aspetto concerne la creazione del concetto di individuo e la diffusione dell’individualismo come ideologia. In effetti, l’immaginario moderno ci sprona a pensarci principalmente come individui che sono tra loro equivalenti in quanto tali, ma che al contempo non appartengono ai diversi gruppi, comunità o categorie sociali se non in modo supplementare e circostanziale. Così, possiamo transitare attraverso un certo numero di questi insiemi sociali, ma non possiamo smettere di essere individui. Ciò significa che nella società moderna l’individuo soppianta la comunità in quanto unità costitutiva del sociale e diventa il soggetto del diritto. Durante il xvii e il xviii secolo, pensatori come Jeremy Bentham o John Locke hanno concepito un nuovo ordine morale che ha lentamente plasmato il modo in cui immaginiamo la società e il nostro posto al suo interno. A loro avviso, le strutture di potere operanti nella società poggiano sull’accordo dei suoi membri a sottomettersi a talune regole derivate da una sorte di contratto sociale fondante che costituisce la fonte stessa della loro legittimità. Questo contratto implicito definisce il modo in cui i vari membri della società devono comportarsi reciprocamente per garantire la propria sicurezza e ottenere il massimo beneficio comune. Il che determina un insieme di diritti e doveri che stabiliscono ciò che la società e i suoi componenti possono esigere gli uni dagli altri e ciò che ognuno è tenuto ad apportare. La novità consiste nel fatto che il legame sociale si fonda sui diritti e sugli interessi degli individui, in modo tale che gli obblighi imposti dalla società si giustificano soltanto se preservano quei diritti e quegli interessi. È come se l’individuo della modernità dicesse ai propri governanti: «Ti riconosco il diritto di governarmi soltanto se lo fai per il mio bene e se riconosci che sono stato io a concedertelo».
Il settimo aspetto poggia sull’idea di progresso e sulla subordinazione del presente al futuro. La modernità è forse la prima epoca che si concepisce come tale, ovvero che si pensa come un momento particolare inserito in un determinato processo. Ne consegue che è il passato a conferire senso al presente, e dunque il momento attuale si può comprendere soltanto in relazione a ciò che lo ha preceduto. Ciò vuol anche dire che il presente deve farsi carico della responsabilità di configurare il futuro. Il tempo presente si trasforma allora in tempo utile per il futuro, assumendosi l’impegno di far sì che quel futuro sia il p...