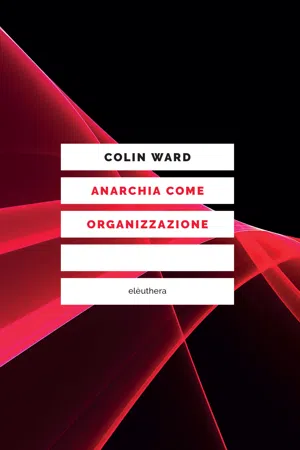![]()
CAPITOLO DODICESIMO
Il fallimento dello Stato assistenziale
Tutte le istituzioni, tutte le organizzazioni sociali, impongono alla gente modelli che ostacolano lo sviluppo delle qualità individuali; più ancora, a me sembra, limitano il dispiegarsi delle più autentiche doti umane… Mi pare che ci sia un dato connaturato a tutte le istituzioni, abbiano esse obiettivi positivi, come scuole, università, ospedali, o assolutamente negativi, quali le prigioni. Chiunque sia coinvolto in un’istituzione, deve continuamente sforzarsi di adeguare se stesso a quella, o ad altra gente, quando invece il connotato più sublime del genere umano è quello di sapere adattare l’ambiente agli uomini, non gli uomini all’ambiente.
John Vaizey, Scenes from Institutional Life
Gli anarchici si sentono dire molto spesso che la loro concezione dello Stato come baluardo dei privilegi dei potenti risulta clamorosamente inadeguata nella situazione della nostra epoca: la previdenza sociale avrebbe cambiato lo Stato. Alcuni dirigenti politici rivendicano addirittura ai loro partiti il merito di aver «inventato» gli istituti previdenziali. Negli ultimi anni della sua vita, ad esempio, Hugh Gaitskill, descrisse lo Stato assistenziale «come un nuovo risultato dell’iniziativa laburista», aggiungendo che «sfortunatamente la gratitudine non sembra costituire una solida garanzia politica». E nei fatti i candidati alle cariche pubbliche nella maggior parte dei paesi occidentali impostano le loro campagne elettorali sulle promesse di stanziamenti previdenziali più elevati di quelli degli avversari.
Vediamo un po’ che cosa significa concretamente lo Stato assistenziale. Non è indispensabile un’organizzazione di tipo statuale perché si diano forme di assistenza sociale. D’altra parte lo Stato può benissimo esistere, come spesso avviene, senza assumersi responsabilità nel campo dell’assistenza. Qualsiasi associazione di uomini in realtà può funzionare come società previdenziale: i sindacati, i gruppi di beneficienza natalizia, le Chiese e financo le bande giovanili – che presumibilmente mirano tutte al reciproco aiuto, al benessere e alla sicurezza comuni – possono tranquillamente essere considerate anche come istituzioni previdenziali. Lo Stato, come abbiamo visto, è una forma di organizzazione sociale che differisce da tutte le altre da due punti di vista: in primo luogo perché rivendica l’adesione di tutta la popolazione e non solo di coloro che intendono farne parte; in secondo luogo perché dispone di mezzi coercitivi per imporre tale adesione. Forme associative finalizzate all’aiuto reciproco esistono fino dai primordi dell’umanità (se non ci fossero state non saremmo qui a discuterne), al punto che si può affermare che la loro necessità è biologicamente fondata. Kropotkin, che nel suo Il mutuo appoggio fa la storia delle manifestazioni di questa innata tendenza umana, descrive non il rafforzamento, ma l’indebolirsi delle istituzioni sociali che tale tendenza incarnavano, parallelamente alla crescita del moderno Stato nazionale europeo dal quindicesimo secolo in poi:
Nei tre secoli successivi gli Stati, sia sul continente sia su questo arcipelago [Gran Bretagna], si dedicarono sistematicamente all’estirpazione di tutte le istituzioni nelle quali la tendenza all’aiuto reciproco aveva trovato espressione fino a quel momento. Le comunità di villaggio vennero private delle loro assemblee, dei tribunali e delle strutture amministrative indipendenti; le loro terre vennero confiscate. Le gilde furono spogliate dei loro possedimenti e di ogni libertà, e sottoposte al controllo, ai capricci e alla corruzione dei funzionari statali. Le città si videro togliere il diritto di sovranità e assistettero alla soppressione delle sorgenti autentiche della loro vita sociale: l’assemblea di villaggio, i magistrati eletti dal popolo e le loro amministrazioni, il municipio sovrano e la gilda sovrana; il funzionario statale prese possesso di ogni articolazione di ciò che una volta era un insieme organico… si cominciò a sostenere, dalle cattedre universitarie e dai pulpiti delle chiese, che le istituzioni, nelle quali gli uomini erano soliti veder incarnato il loro bisogno di aiuto reciproco, non avrebbero più potuto essere tollerate in uno Stato adeguatamente strutturato; che solo lo Stato era in grado di rappresentare i legami che univano i suoi sudditi; che federalismo e «particolarismo» erano nemici del progresso, e che sullo Stato soltanto era possibile contare per uno sviluppo ulteriore1.
Non si tratta in questo caso di un punto di vista romantico e sorpassato relativo alle circostanze che portarono al superamento della cultura medievale; analoghi giudizi si trovano nelle opere di studiosi moderni, ad esempio in Principi di governo e politica nel Medio Evo di Ullmann. Neppure si può considerare paradossale l’amaro resoconto di Kropotkin, come dimostra la storia del pauperismo in Gran Bretagna. Nel Medio Evo si interveniva contro la povertà anche senza il coinvolgimento dello Stato. I membri di una gilda caduti in povertà venivano assistiti dai propri confratelli, che si occupavano anche degli orfani e delle vedove. C’erano ospedali e lazzaretti per i malati, e l’ospitalità nei monasteri era garantita a chiunque ne avesse bisogno. Ma con lo stabilirsi di un solido Stato nazionale con i Tudor, significativamente la prima legge statale sulla povertà prevedeva che i mendicanti venissero cacciati, la seconda che fossero addirittura marchiati. E per finire, era punitiva l’essenza stessa della legge sui poveri approvata nel 1601, emendata nel 1834 e scomparsa solo ai giorni nostri. Tutti i membri delle Claimants’ Unions obbietterebbero, però, che la legge sui poveri è tuttora in vigore, come in vigore sono le sue caratteristiche punitive.
Potrebbe sembrare paradossale che lo Stato, i cui simboli sono il poliziotto, il secondino e il soldato, possa essere diventato l’organizzatore dell’assistenza sociale. In realtà la connessione tra assistenza pubblica e necessità belliche è molto stretta. Ancora nella seconda metà del diciannovesimo secolo lo Stato si avvaleva, nelle sue guerre, di soldati di professione e di mercenari, ma allargandosi il campo d’azione e le dimensioni delle guerre, gli Stati si videro costretti a dedicare sempre maggiore attenzione alle doti fisiche delle reclute, fossero volontari o coscritti. La scoperta che gran parte della potenziale carne da cannone era fisicamente inadatta a quel ruolo (scoperta rinnovata in occasione di ogni guerra negli ultimi cento anni) spinse lo Stato a prendere misure che contribuissero a migliorare la salute fisica della nazione. Richard Titmuss, nel suo saggio War and Social Policy, sottolinea che «fu in occasione della guerra sudafricana, una guerra non certo tale da cambiare i destini dell’umanità, come altre che la storia ricorda, che si avviò quel movimento a favore della tutela della salute individuale che conseguì alla fine i suoi obiettivi, nel 1948, con l’istituzione del servizio sanitario nazionale»2.
Con l’estensione della guerra alla popolazione civile, insieme alla necessità di tenere alto il morale con la formulazione di «obiettivi di pace», al generale senso di colpa nei confronti delle passate ingiustizie sociali, alla volontà di fare meglio in futuro, che sempre tiene dietro alle guerre, le preoccupazioni relative alla salute investirono altri settori di benessere sociale. «La tendenza, caratteristica del tempo di guerra a universalizzare le provvigioni pubbliche di alcuni beni di prima necessità», scrive Titmuss, «vuol dire in realtà che un sistema sociale deve essere organizzato in modo tale da mettere tutti i cittadini (non solo i soldati) in condizione di sapere che cosa fare della propria vita in tempo di pace. In questo contesto risulta comprensibile sia l’Education Act del 1944, sia il Rapporto Beverige del 1942, sia le leggi sulle assicurazioni, sugli assegni familiari e sul servizio sanitario nazionale. Tutti questi episodi di legislazione sociale erano in parte espressione del bisogno, naturale portato di una strategia di guerra, di omogeneizzare le condizioni di vita della popolazione civile e non civile»3. La sua sardonica conclusione è questa: «Obiettivi e contenuti della politica sociale, sia in pace sia in guerra, risultano così determinati – almeno in considerevole misura – dalla necessità di garantire la collaborazione di massa indispensabile a un efficace esercizio della guerra».
L’assistenza sociale, insomma, affonda le sue radici in numerose tradizioni ben distinte tra loro, prodotto di atteggiamenti completamente differenti nei confronti dei bisogni sociali. Tali tradizioni sono sopravvissute perfino nell’ambito unitario della legislazione previdenziale dello Stato. Un mio amico, uno psicologo sperimentale che ha occasione di visitare molti ospedali, sostiene che, sebbene siano passati molti anni dall’istituzione del servizio sanitario nazionale, gli è ancora possibile riconoscere se un particolare istituto, prima dell’intervento dello Stato, era un ospedale privato, oppure municipale, oppure un centro di assistenza istituito dalla legge sulla povertà. C’è la tradizione secondo la quale il servizio è offerto malvolentieri, imposto in modo punitivo e autoritario; e c’è la tradizione che esprime corresponsabilizzazione sociale, o disponibilità all’aiuto reciproco e all’autosufficienza. Nel primo caso ci troviamo di fronte a istituzioni, nell’altro ad associazioni.
Il gergo della pubblica amministrazione ci offre un vocabolo brutto ma espressivo, «istituzionalizzazione», che non significa altro se non «costringere la gente dentro le istituzioni». C’è anche un’altra parola, se possibile ancora più brutta, «deistituzionalizzazione». Per quanto ostica questa parola possa sembrare, descrive una tendenza molto importante da un punto di vista anarchico. Con il termine «istituzione» si definisce in generale «una legge, un’abitudine, un costume, oppure un’organizzazione consolidata, o comunque elementi della vita politico-sociale di un popolo». Esiste poi un significato particolare abitualmente attribuito a questo termine, cioè quello di una «fondazione educativa, filantropica, correttiva o penale, nella quale un edificio, o un complesso di edifici, gioca un ruolo centrale, come ad esempio una scuola, un ospedale, un orfanotrofio, un ospizio o una prigione».
Se si accettano come valide queste definizioni, è facile vedere come l’anarchismo sia ostile alle istituzioni nel senso più generale, ostile cioè all’istituzionalizzazione in forme prestabilite, o in entità legali di vario genere, dei diversi tipi di associazioni umane. Opposto è il suo atteggiamento nei confronti della deistituzionalizzazione: in altre parole gli anarchici sono favorevoli all’eliminazione delle istituzioni.
Considerando il significato più particolare del termine istituzione, tra i teorici e gli operatori del settore prevale attualmente un orientamento favorevole alla deistituzionalizzazione. È possibile individuare un modello di evoluzione caratteristico della maggior parte di queste particolari istituzioni. In molti casi esse furono fondate o modificate da pionieri o filantropi, laici o religiosi, al fine di soddisfare alcuni bisogni sociali particolarmente pressanti, o di porre rimedio alle piaghe più vistose della società. Successivamente intorno a esse si coagulò l’iniziativa di associazioni volontarie, e con il passar degli anni, nel corso del diciannovesimo secolo, ottennero il riconoscimento e l’appoggio dello Stato.
Le autorità locali provvidero a riempire le lacune nella distribuzione territoriale di tali istituti, e infine, nel ventesimo secolo, si procedette alla istituzionalizzazione definitiva, cioè alla nazionalizzazione, o assorbimento da parte dello Stato che ne faceva un veicolo di pubblico servizio.
Nel momento del loro massimo sviluppo, però, sul conto di queste istituzioni è sorto un grave dubbio. Ci si è cominciati a chiedere se esse servano effettivamente al proposito che si prefiggono, cioè se curino i mali della società com’è nelle loro intenzioni, o se non stiano, invece, ottenendo il risultato opposto, quello di favorirne la perpetuazione. Nasce una nuova generazione di pensatori di avanguardia che propone di rovesciare il processo e, a seconda dei casi, di abolire quelle istituzioni, o disaggregarle in tante unità non istituzionali, o soddisfare con metodi non-istituzionali gli stessi bisogni sociali. Sono proprio questi orientamenti che ci inducono a riflettere su un problema di fondo: in che misura cioè le istituzioni «separate» possano essere considerate dei microcosmi e quindi utilizzate come modello per l’analisi critica degli «istituti» più generali della società.
Si può dire che le istituzioni abbiano trovato la loro espressione architettonica in quella gerarchia di mastodontici edifici vittoriani che costella i margini delle città. «Non lontano dal cimitero», scrisse C.F. Masterman, «si ergeva l’immenso ospedale per le malattie infettive…; di fronte, un gigantesco ospizio per i poveri; dietro, l’imponente manicomio; sulla destra, una scuola militare di proporzioni analoghe; sulla sinistra, la prigione… Le zone periferiche dell’agglomerato urbano sono popolate di questi enormi edifici, prigioni e palazzi, testimonianze degli sforzi della città alle prese con i problemi delle vite mutilate o traviate; testimonianze, a un tempo, della sua forza e dei suoi fallimenti. Gente caduta in rovina, ribelli, pazzi, vecchi soli, sono tutti confinati dietro maestosi cancelli e muri intonacati»4. Questo il commento di Heather Woolmer: «Masterman interpreta questi elementi come segno di un deliberato rifiuto da parte della società verso ciò che per una qualche ragione essa preferisce rimuovere, ad esempio la morte, o verso ciò che le risulta scomodo, ad esempio il povero, il vecchio oppure il malato di mente. È come se a un’intera sottocultura fosse presa in un processo ai margini della metropoli che la rinchiude negli istituti assistenziali, negli ospizi per poveri, nelle case di ricovero per vecchi, negli ospedali, e infine al cimitero: tutti come polli d’allevamento in attesa del nastro che li porti alla morte»5.
In effetti l’istituzionalizzazione è un problema con il quale abbiamo a che fare dal primo all’ultimo giorno di vita. Il «modello ideale di nascita» accettato dalla scorsa generazione aveva come scenario le sale parto degli ospedali. Il bambino veniva sottratto alla madre da un’infermiera con tanto di mascherina e deposto in un’asettica cabina di vetro, donde usciva, a ore rigidamente stabilite, solo per essere allattato. Baci e coccole erano considerati anti-igienici. (Naturalmente, la maggior parte dei bambini non veniva al mondo in quelle condizioni, che comunque erano considerate le migliori). Oggi il quadro ideale è completamente mutato. Il bambino nasce in casa, con il padre che aiuta premurosamente e gli altri figli incoraggiati a «condividere» l’esperienza, l’arrivo del fratello. Quest’ultimo viene vezzeggiato da tutti i presenti e basta che si lamenti perché gli si dia da mangiare. (Anche in questo caso, il quadro descritto non è generalizzabile oltre certi limiti, per quanto rappresenti la condizione ritenuta ottimale). L’evoluzione cui si è accennato può essere attribuita a oscillazioni del pendolo della moda, o al buon senso che riprende il sopravvento, o ancora alle...