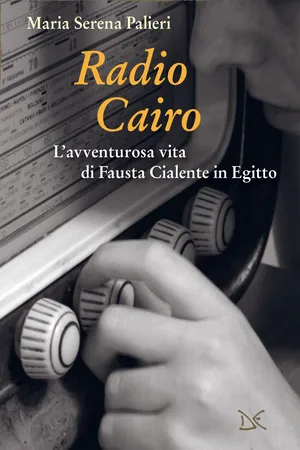
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
«Questo mio giornale di guerra mi pento d'averlo fatto e poi anche conservato. Rientrarvi, per me, significa buttarmi dentro le fiamme d'un piccolo inferno – perché le guerre sono inferno e gli uomini in guerra sono infernali, e non sempre eroi». Fausta Cialente
Un'avventura poco nota, ma straordinaria,quella vissuta al Cairo, negli anni della seconda guerra mondiale, da Fausta Cialente (1898-1994), una tra le più grandi scrittrici italiane del Novecento. Siamo nel 1940 e la futura vincitrice del Premio Strega (nel 1976, con Le quattro ragazze Wieselberger) da tempo ormai vive in Egitto, insieme al marito e alla figlia. Voce importante dell'antifascismo nel paese africano, dopo l'entrata in guerra dell'Italia, intenzionata a svolgere un ruolo più attivo, decide di collaborare con la contropropaganda britannica che ha sede al Cairo. Lascia quindi la famiglia ad Alessandria e si trasferisce nella metropoli cairota, dove intraprende quella che si rivelerà un'esperienza totalizzante, tanto da farle dimenticare per alcuni anni di essere una scrittrice. Capitale di uno Stato ufficialmente non in guerra, base cruciale per gli Alleati e rifugio per i fuorusciti dei paesi dell'Asse, Il Cairo è un ambiente cosmopolita, una zona franca dove la vita mondana è rinvigorita dalla presenza delle alte gerarchie militari e le giornate sono scandite da cocktail, ricevimenti e vernissage: le acque ideali, insomma, per i pesci grossi e piccoli dello spionaggio. E in quelle acque Fausta imparerà a nuotare: decisa, ma sfuggente come un'anguilla. In un'attenta e appassionata ricostruzione biografica, Maria Serena Palieri mette in scena quegli anni egiziani, con l'aiuto della stessa protagonista. Per la prima volta, infatti, vedono la luce in questo volume stralci dei diari tenuti allora da Fausta Cialente – oggi conservati nel Centro Manoscritti di Pavia –, che ci consentono di avvicinarci al mondo intimo di una scrittrice che della riservatezza ha fatto la parola d'ordine. Quello che si apre davanti a noi è un quadro vivissimo e impietoso dello scenario cairota dell'epoca, in cui non mancano ambiguità e insidie, e un autoritratto senza veli della donna che vi prende parte: pagine in cui la passione civile si alterna a un'ironia tagliente e ricca di brio. Dal '41 al '47 Fausta scrive, coordina e conduce una trasmissione quotidiana su Radio Cairo, produce materiale per i volantini della Raf, dirige un giornale, vive una tormentata relazione con un capitano dell'esercito britannico, è inviata in missione in Palestina. In questa battaglia contro le fake news dell'Asse non mancano le difficoltà. A sue spese, la scrittrice imparerà a muoversi fra le diverse anime della «Resistenza lontana» e a contrastare i tentativi di censura da parte inglese: gli ostacoli – confesserà – «svegliarono una persona che non avrei mai supposto di poter essere con tutta la malizia, l'arroganza, la capacità d'intrigo e di aggressione che richiedevano la quotidiana difesa dell'indipendenza e dell'efficienza del nostro lavoro». Riannodando gli anni egiziani a quelli dell'infanzia e della maturità – attraverso articoli, lettere, romanzi, interviste –, il libro racconta le tappe di un'intera esistenza: gli amori, la figlia, l'affetto per il fratello Renato (uno dei più grandi attori dell'epoca) e il dolore per la sua improvvisa perdita, le prime prove narrative, il successo, il giornalismo, i viaggi. Prende forma, in queste pagine, il destino di una nomade, lo spirito irrequieto e irriverente di una grande scrittrice.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Radio Cairo di Maria Serena Palieri in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Editore
Donzelli EditoreAnno
2018eBook ISBN
9788868438203Diario di guerra
Comincia con passo mondano, il racconto in presa diretta della vita di Fausta Cialente al Cairo. Il 2 febbraio 1941 è domenica e la giornata viene spesa in buona parte con gli amici del milieu artistico e gauchiste. Fausta Cialente è una donna che, andata sposa giovanissima, benché la sua unione col marito Enrico Terni, di ventidue anni più anziano di lei, sia ispirata a un credo di «libertà» – qualunque cosa questo voglia dire – e benché abbia avuto ad Alessandria una consuetudine di animata vita sociale, sta assaporando al Cairo un’esperienza del tutto nuova: lontana dalla famiglia, autonoma sul piano economico, in prima linea alla radio, immersa in un ambiente non affetto da quel singolare «cosmopolitismo provinciale» che connota Alessandria d’Egitto, dove ha lasciato marito e figlia, un clima, così come lo descriverà trent’anni dopo nel romanzo Il vento sulla sabbia, tanto a se stante da meritare quest’ossimoro.
Eccola «per un whisky», dunque, in una delle case aperte agli ospiti nella domenica cairota. L’anfitrione è Étienne Mériel. Qui qualcuno racconta la discussione della sera prima all’Union Démocratique «fra i cosiddetti giovani egiziani socialisti massimalisti, che sono poi autentici e stupendi fascisti e i cosiddetti stranieri, Georges, Lucienne, Cosseri ecc…», riassume Fausta. Georges e Lucienne sono due nomi che torneranno a più riprese nel diario. Mentre «Cosseri» è presumibilmente Albert Cossery, lo scrittore ribattezzato «il Voltaire del Nilo». Accanto a lui si affaccia la figura di un suo sodale, un altro protagonista della bohème cairota di quella stagione, Kamel el-Telmissany, esponente del gruppo di pittori che – in nome della difesa, contro il nazismo, dell’«arte degenerata» – facevano del surrealismo una bandiera: «Il pittore Telmissany, del loro gruppo e veramente egiziano, lui (mais pas plus fier pour ça, pare che dica) ha fatto una carica a fondo contro gli altri», racconta il diario. «Non vede, ha detto, perché si debbano stabilire differenze: in Egitto, come dovunque, esistono gli sfruttati e gli sfruttatori, e non capisce perché si debba essere egiziani per sentire un problema che è universale. All’Egitto egli sente di non dover niente – lui, Telmissany – e tutto quello che qui è stato fatto di buono è tutto dovuto alle influenze europee, finora. Pare che abbia detto tutto ciò con slancio e vivacità, e i fascisti egiziani non sapessero cosa rispondere, portati su un terreno troppo pericoloso. Avrebbero dovuto confessare il loro nazionalismo a oltranza».
Tiene banco la storia di uno scandalo da poco avvenuto: su ufficiali italiani caduti prigionieri sono state trovate copie dei piani di difesa dell’Egitto, a Marsa Matruh e sul Canale di Suez, con fotografie delle lettere d’accompagno del generale Archibald Percival Wavell, Commander-in-Chief Middle East. Chi glieli ha forniti?
Poi a cena da Ganache: paté maison, pollo mayonnaise, Bordeaux e acquavite di lampone. E per finire: «Mi sentivo stanca e avrei voluto tornare prima, ma 2 australiani ubriachi zuppi, cui avevamo risposto levando il bicchiere a un brindisi a distanza, si sono precipitati alla nostra tavola e non c’è stato mezzo di “mollare”. Uno dei due è stato ditirambico sul conto di Lucienne e mio: occhi profondi come le acque del Barrage, denti come perle, corpo come Cleopatra, gambe come pomidori e dita come asparagi. Erano ambedue coltivatori e allevatori della Nuova Zelanda. Prima di andar via ci hanno baciato su una guancia».
Il tono scanzonato in realtà si appaia alla riflessione che sta maturando: «Verso tardi da Lucienne dove abbiamo preso il tè. Mi ha raccontato avvenimenti importanti della sua vita che non conoscevo e mi hanno fatto venire la pelle d’oca. Mi domando, ripensandoci, se la vita di una donna sposata non è, dopotutto, più protetta. Credo di sì», ha scritto la domenica; e la sera dopo, 3 febbraio, eccola annotare: «Lavorato tutto il giorno. Avevo esitato ad accettare di passare la serata con S. [Christopher Sykes] e cenare con lui, ma ha insistito “Mi piace parlare di letteratura con voi” dice. […] Abbiamo parlato […] dei rapporti tra uomini e donne in generale e gli ho esposto, in parte, le mie teorie. Ne è rimasto sorpreso. “Non avrei mai creduto che voi (sottinteso ‘bolchévisante’) foste ancien régime su questo argomento”. Ho cercato di esprimere, brevemente, perché non mi piace dilungarmi su quest’argomento, che non è questione di modernismo o passatismo».
Qualche giorno dopo, il 7, aggiungerà: «Ieri lavorato meno bene del solito, con poca voglia. Sempre quest’ossessione di smettere. Non so se sia per colpa della solitudine, del non sentirmi sorretta in questo difficile compito, ma lotto ogni giorno con un irresistibile desiderio di togliermi tanta responsabilità di su le spalle».
Un’ultima nota intima: «Oggi è la festa di Renato. Tristezza di non potergli mandare neanche un telegramma».
Renato, primogenito di Alfredo Cialente ed Elsa Wieselberger, il 2 febbraio ha compiuto 44 anni. La guerra impedisce di comunicare tra l’Egitto in mano ai «protettori» britannici e l’Italia fascista. Non sa, Fausta, che in questo stesso diario fra trentasei mesi celebrerà, in occasione della ricorrenza, un rito straziato per il fratello investito, alla fine del ’43, da un automezzo militare tedesco.
Ma, appunto, il lavoro anzitutto. Il diario non ci dà strumenti per capire quale sia, concretamente, la scena in cui esso si svolge. Sappiamo che il Soe – Special Operations Executive, l’organizzazione nata per condurre la guerra non convenzionale: sabotaggi, ricognizioni, spionaggio – aveva sede nei Rustom Buildings, un complesso nell’area cairota di Garden City, indirizzo così blindato che i tassisti, agli agenti che chiedevano di esserci portati, sorridendo ribattevano: «Sì, al palazzo segreto…»; che il quartier generale si trovava nei cosiddetti Grey Pillars e che da quegli edifici il 1° luglio 1942, ricordato come il «Mercoledì delle ceneri», sarebbero volati brandelli dei documenti segreti bruciati sotto la minaccia dell’arrivo dell’Afrikakorps. Per immaginare gli ambienti che ospitano la radio, però, dobbiamo rifarci a Ballata levantina, il romanzo che Fausta pubblicherà nel 1961 e che evoca, tra l’altro, Il Cairo degli anni di guerra: qui la protagonista, la bella e giovane Daniela, lavora come stenografa per gli inglesi, decrittando le trasmissioni radio che arrivano, via etere, dai paesi nemici. C’è un’ampia sala del monitoring dove ci si riposa su sedie polverose bevendo Bovril portato da un attendente e dove notte e giorno si susseguono all’ascolto «un po’ di tutto, dai francesi “liberi” ai “liberi” polacchi; e i cechi, gli austriaci, i bulgari, i rumeni», poco considerati e poco amati dai padroni di casa, i britannici.
Tornando alla realtà, Fausta il 1° febbraio ha chiesto a Sykes di poter effettuare nuove interviste ai pows nei campi: l’obiettivo è trovare collaboratori, ma anche spunti e materiali per i commenti quotidiani al microfono. Sykes ha rifiutato.
Sul fronte della guerra, sono i giorni in cui Bengasi, provincia libica, comincia a vivere la sua drammatica altalena: il 6 febbraio è occupata dagli inglesi, ma tra il 4 e il 5 aprile vedrà il ritorno degli italo-tedeschi, solo però per otto mesi…
E dunque il 7 febbraio Fausta e Lello Battino vanno dal colonnello a protestare: «Il momento è delicato e la situazione anche, e se lasciano andare le cose a questo modo, invece di essere noi a fare una buona propaganda antifascista, saranno i fascisti nei campi di concentramento civili e militari a fare esattamente il contrario, cioè propaganda fascista su elementi scoraggiati e inclini ad accettarla».
«Hamsin, polvere, perciò trasmissione cattiva», chiosa a fine giornata. È quasi primavera e da Sud arriva l’hamsin o khamaseen, il vento che porta la sabbia del deserto.
Un fine settimana ad Alessandria illumina la situazione familiare: il legame con la figlia Lili, non ancora diciottenne, la spinge a casa, il disagio con il marito la risospinge al Cairo; ma soprattutto fa entrare in scena per la prima volta i giovani amici Laura Levi e Renato Mieli. Il gruppo antifascista informale, che fa capo ad Alessandria, tende a usare lei, Fausta, come testa di ponte: adesso vogliono che tenti di incontrare William Joseph Donovan, quel «Wild Bill» come gli americani chiamavano il più insignito dei loro generali, al vertice dell’Office of Strategic Services e poi ispiratore della Cia, che in quello scorcio d’inverno, ancora colonnello, alla vigilia dell’entrata in guerra degli Usa sta tessendo per il presidente Roosevelt la tela nel Mediterraneo. Fausta, forte del legame con gli alti gradi britannici, dovrebbe presentargli un’istanza in favore degli antifascisti italiani rifugiati in Francia e ora, con l’occupazione tedesca, lì intrappolati. Donovan svolazza tra Grecia e Bulgaria, Palestina ed Egitto e resta al Cairo una sola notte, tra il 7 e l’8 febbraio. Così il 18 febbraio il diario riporta: «Settimana disastrosa in tutto e per tutto […]. Primo fiasco: l’incontro con Donovan non ha potuto aver luogo, per quanto sia intervenuta direttamente e immediatamente l’Ambasciata».
Ma in questa seconda decade di febbraio 1941 Fausta ha sfiorato tutt’altro «disastro»: ha sfidato i capi dell’So1 – cioè Special Operations 1, Propaganda –, ha sfidato anzi la filosofia stessa dell’apparato del colonnello Thornhill, nel diario «T.».
Ricordiamoci quanto ha scritto nell’abbozzo di romanzo: «Avevo premesso che avrei accettato solo a condizione di essere un’italiana che parlava agli italiani e non una trasmissione britannica in italiano. […] Evidentemente era un gomitolo col quale bisognava giocare come il gatto col topo, per utilizzare le direttive sulla linea che doveva essere la nostra e non sempre poteva coincidere con quella dei “dirigenti”».
Ora, in occasione di uno degli speech del primo ministro britannico alla nazione, si concede di commentarlo in chiave critica. È il discorso che va sotto il titolo Give Us the Tools: il 12 febbraio Fausta e il capitano Nacamuli – «Nac.» – l’hanno tradotto e dattiloscritto in italiano; qui Churchill muove il più ampio e articolato dei suoi attacchi a Mussolini e, a valle delle vittorie riportate in Libia con l’«Operazione Compass», critica nel suo complesso l’esercito italiano «che aveva tanto vantato la sua virilità e le sue virtù militari».
Fausta, così ci dice nel diario, si è attribuita un ruolo diverso da quello che, il 25 dicembre, aveva adempiuto in occasione di un altro discorso di «Winnie». All’antivigilia di Natale il premier britannico aveva lanciato un appello agli italiani. Ma lì, da un lato si era rivolto al popolo perché rovesciasse Mussolini, il dittatore che l’aveva portato in una guerra che non poteva desiderare, dall’altro al nostro «coraggioso» esercito, al quale chiedeva di sottrarsi a una guerra in cui – diceva – certo non credeva, e di prendere a cuore, invece, «la vita e il futuro» del paese.
Stavolta Fausta ha ritenuto di dovere essere lei a muovere dei distinguo tra il dittatore e gli italiani chiamati alle armi: le parole di Churchill le sono infatti sembrate insultanti verso i nostri connazionali. Lo ha fatto in diretta al microfono, benché – e siamo in tempo di guerra! – inquadrata come dipendente dell’Ambasciata britannica. Sta giocando d’azzardo: quanti codici vìola? Ecco la sua cronaca in quei giorni.
18 febbraio
Incidente discorso […] di Churchill. […] Se non mi avessero costretta a farne il riassunto, forse avrei passato sotto silenzio; ma dato che ne dovevo parlare, «ho detto la mia» (stretta la foglia, lunga la via, dite la vostra che ho detto la mia…). Non è andata liscia, certo no.
Per riuscirci ha infranto il regolamento, cioè non ha sottoposto il testo, com’è consuetudine, alla censura: «Ma ho finito il commento alle 7 di sera e non è certo a quella squilibrata dama del Broadcasting che lo avrei presentato. Qui sta non solo il mio errore, ma la mia colpa: se dicessi che non ero perfettamente cosciente dell’uno e dell’altra direi una gran bugia», annota.
Com’è normale, anche in quelle stanze allignano invidie e giochi di potere. «La bomba scoppiò soltanto l’indomani mattina e – seppi dopo – per opera della deliziosa M.me M. che non soltanto mi ha denunciato, ma ha sobillato S.».
La stessa «M.me M.» giocherà carte anche più dozzinali, facendole intendere che nell’ambiente corrono pettegolezzi su di lei perché, donna, vive da sola al Cairo e «riceve uomini in camera». Fausta sa metterla a posto con sarcasmo.
Di tutt’altro tono lo scontro coi superiori. Eccola al quartier generale dove affronta Sykes. «Ebbi a sostenere l’urto. Rimasi perfettamente calma, anche perché S. avendo adoperato per introduzione la parola “ignoble” (Ce que vous avez fait est ignoble), lo misi subito in stato d’inferiorità facendogli intendere che lo scusavo perché non conosce il francese […]. La mia calma finì per sconcertare S. e non potendone – egli – aver ragione, tentò di impaurirmi a forza di minacce: cioè che avrei dovuto sopportare un “terrible orage” con il Colonnello, perché egli era costretto a denunciarmi. Gli risposi di fare esattamente quello che era suo dovere di fare, che assumevo tutta la responsabilità delle mie parole e del mio gesto; che si fosse trattato di rifarlo l’avrei rifatto; che non ero affatto pentita, ma solo dispiacente di creare difficoltà a lui e agli altri per la questione della Censura. “Avete tradito la nostra fiducia” è stata la frase che mi sono sentita dire cento volte – e che del resto è contenuta nella lettera del Colonnello, giuntami poi. Ci lasciammo apparentemente non in cattivi termini, ma uscita che fui sentii il coraggio e la calma abbandonarmi».
Il passo successivo è dal suo diretto superiore, il segretario d’ambasciata B.A.B. Burrows. «Corsi immediatamente da Bob a portargli la copia del commento e gli dissi calma e sorridente: “Ecco, pare che io abbia provocato un temporale, ‘un disastro sulla linea’, giudicate voi se la cosa è proprio tanto grave. Non credo di aver detto molto di più dell’altra volta, ad ogni modo me ne assumo la responsabilità e ne sopporterò le conseguenze”. Sorridente anche lui e impassibile ma con una punta di malizia negli occhi e con l’aria di uno che si diverte mi rispose: “Va bene, lasciatemi tempo, vedrò di neutralizzare il temporale”».
In realtà siamo in una fase in cui, agli ordini di Thornhill, gli inglesi ancora sembrano credere in questa guerra dell’etere della quale, sul fronte italiano, Fausta Cialente è protagonista. Tant’è che l’assoluzione arriva grazie alle capacità che lei ha finora dimostrato nel suo ruolo.
In quelle stanze non si parla d’altro. Arriva la telefonata di Nacamuli che definisce il commilitone Sykes «un esaltato». Sopraggiungono due dei Battino, Lello e uno dei fratelli, e si complimentano. E «capitò subito S. che ricevetti il più freddamente possibile», racconta il diario.
Fausta gli annuncia che quella sera e nei giorni successivi Siamo Italiani, parliamo agli Italiani dovrà fare a meno dei suoi commenti alle notizie, perché lei non ne scriverà, che, cosciente di quanto ha fatto, è disposta ad andarsene e – ecco l’argomento risolutore – è pronta ad assumersi tutte le responsabilità «se questa storia vi procura delle noie e siete voi che avete paura delle conseguenze». Sykes reagisce com’era da aspettarsi. L’abbiamo già visto punto nel vivo la prima sera, nell’episodio della signora armena. Ora va in bestia, benché controllandosi, all’insinuazione che possa essere un codardo:
Andò via assai furioso e sulla porta mi disse: Awful woman. Però siete la più meravigliosa propagandista che si possa immaginare.
Può sembrare un alterco galante. Non fosse che in gioco c’è ben altro: abbiamo visto infatti quali rischi Fausta Cialente abbia deciso di affrontare, per sé e per i suoi cari in Egitto come in Italia, schierandosi a fianco del «nemico»; cosa succederebbe adesso a tutti loro se la espellessero dalla radio? Il 16 febbraio 1941, però, il suo azzardo raccoglie frutti significativi: «Domenica mattina mi venne la lettera del Col. […] Lettera grave e dura, ma ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- Premessa
- Radio Cairo
- Antefatto
- Diario di guerra
- 1898-1940. La sua vita, prima
- 1947-1994. La sua vita, dopo
- Le fonti