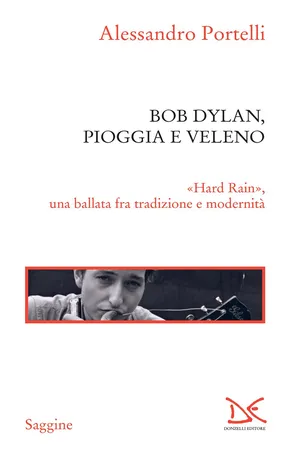
eBook - ePub
Bob Dylan, pioggia e veleno
«Hard Rain», una ballata fra tradizione e modernità
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
«C'è una profonda giustizia poetica nel fatto che lo stesso giorno in cui abbiamo perduto il premio Nobel Dario Fo, Bob Dylan veniva insignito del Nobel. Si tratta di due artisti che cambiano il nostro rapporto con la parola intrecciandola con il suono, la voce, il corpo, la performance. Entrambi affondano le radici della loro creatività nel mondo delle culture popolari: da Mistero Buffo a "Hard Rain", sono le voci dei vagabondi e dei saltimbanchi delle campagne italiane e le voci dei braccianti neri del Delta e dei vagabondi della depressione che si impadroniscono del centro della scena e diventano nuovi linguaggi della modernità».
Due cantautori, su tutti gli altri, hanno dato voce al sentimento dell'America profonda, incarnandone nella maniera più autentica l'anima popolare: Bruce Springsteen e Bob Dylan. Dopo avere consacrato a Springsteen (e alla sua canzone «Badlands») un libro memorabile, Portelli si dedica ora a Dylan, e sceglie come emblema e protagonista del libro «Hard Rain», la canzone che Dylan incise per la prima volta nel 1962, agli esordi della sua attività. Non è certo un caso se, durante la cerimonia dell'assegnazione a Dylan del premio Nobel per la letteratura 2016, la canzone che Patti Smith scelse di cantare fu proprio «A Hard Rain's A-Gonna Fall». Ed è ormai largamente noto il giudizio espresso dalla rivista «Rolling Stone», che l'ha definita «la più grande canzone di protesta scritta dal più grande autore di canzoni della sua epoca». Meno noto è che Dylan ha costruito «Hard Rain» a partire da un intenso dialogo con un'antichissima ballata di tradizione orale, il «Testamento dell'avvelenato», di cui si trova traccia addirittura nell'Italia del Seicento, e che si diffuse in tutto il mondo anglosassone, col titolo di «Lord Randal», per passare poi in America attraverso i canali propri della tradizione orale. Esplorando le relazioni fra queste due canzoni, il libro mostra come il testo di Dylan si alimenti della profondità storica incorporata nell'antica ballata, la proietti verso un immaginario contemporaneo, e li illumini entrambi. In quel momento, Dylan è immerso nel folk revival, ma si prepara a uscirne; è come se fosse «in bilico fra mondi», scrive Portelli, in un momento di «prodigioso equilibrio che neanche lui avrebbe mai più ritrovato con altrettanta potenza». Grazie a un confronto serrato con le forme della canzone narrativa popolare e della sua storia plurisecolare, il libro scava nell'immaginario di Dylan, nella sua visione della storia e del futuro, dall'incombente minaccia nucleare ai disastri ecologici del nostro tempo, mettendo in luce il rapporto che il grande folksinger intrattiene con i linguaggi della musica, della poesia, dell'industria culturale. Ne emerge una lettura di Bob Dylan la cui unicità consiste nel collocarsi sapientemente, come solo un artista della parola cantata può fare, nel punto in cui si incontrano oralità e scrittura, testo e performance, folklore e popular culture, fra la globalizzazione dei movimenti e delle culture orali e quella dell'industria culturale. Al bivio fra due possibili vie della storia, apocalisse o liberazione.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Bob Dylan, pioggia e veleno di Alessandro Portelli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Mezzi di comunicazione e arti performative e Musica classica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Categoria
Musica classicaIII. Il testo e la voce
1. Tempo.
La ballata è l’insieme di tutte le varianti e versioni note, ignote e possibili. Non esiste un «originale», un unico testo o musica «autentico». Il «Testamento dell’avvelenato»cantato da Giovanna Nobili nel 2005 è altrettanto originale e autentico quanto quello che potrà avere ascoltato il Bianchino nel 1629. La ballata è la sua storia, compresa la preistoria (c’è chi connette «Lord Randal»con eventi scozzesi del 1300: «È una storia vera, è successo davvero» in Scozia, «Dio sa quando», spiega Betsy Miller, madre e fonte di Ewan MacColl)1 e il suo futuro. La cosa importante non è l’antichità e l’origine della ballata ma la sua durata e la sua presenza. Ogni volta che viene cantata, è come Anteo che prende nuove energie ogni volta che tocca terra: ogni nuova esecuzione è sia una nuova «interpretazione», tanto in senso artistico quanto in senso ermeneutico, sia soprattutto garanzia della sua sopravvivenza. La ballata vive solo se qualcuno la canta. E siccome nessuno la canta due volte esattamente come l’ha cantata prima2 o come l’ha sentita cantare da altri, ma deve ogni volta reinventarla recuperandola dal fondo della memoria e ricostruendola secondo la propria visione del mondo, la ballata è sempre la stessa ma non è mai uguale: non è «senza tempo» o «timeless»3 ma esattamente il contrario, esiste solo nel tempo e si evolve con la storia. È capace di diramarsi, diventare irriconoscibile e dare vita a «Dove sei stato mio bell’alpino» nella prima guerra mondiale, che a sua volta diventa «Cosa rimiri mio bel partigiano» nella Resistenza. O trasformarsi in una filastrocca per bambini, che finisce pure in versione rock sul pianoforte di Jerry Lee Lewis e rimbalza fino a un Bruce Springsteen del 2007, «The Last Carnival». La filastrocca dice:
Where have you been, Billy Boy, Billy Boy
Where have you been all the day, charming Billy?
I’ve been to seek a wife, she’s the joy of my life
She’s a young thing and cannot leave her mother4.
E Bruce Springsteen, che «Billy Boy» lo sa probabilmente dall’infanzia ma ne ha senz’altro rinnovato il ricordo anche ascoltando «Hard Rain»:
Sundown, sundown
They’re taking all the tents down.
Where have you gone my handsome Billy?
Sundown, sundown
The carnival train’s leaving town.
Where are ya now my darlin’ Billy?5
A differenza di «Lord Randal», «Hard Rain» di Bob Dylan ha un originale autentico, riprodotto su vinile e in cd in milioni di copie identiche e persino manoscritti venduti da prestigiose case d’asta6. Certo, non è mai eseguita dal vivo esattamente nello stesso modo, come non sono mai del tutto identiche neanche due esecuzioni della stessa sonata di Chopin dallo stesso pianista; tuttavia in entrambi i casi le variazioni sono condizionate dall’esistenza del «testo». Quelli che hanno sentito Dylan cantare «A Hard Rain’s A-Gonna Fall» dal vivo sono solo una frazione di quelli che la conoscono dal disco. Quando la cantano altri – Pete Seeger, Joan Baez, Patti Smith a Stoccolma o Lou Majaw a Shillong – le loro interpretazioni sono percepite come «cover» della matrice originale e con essa devono comunque confrontarsi, misurate sulla qualità, la fedeltà o la capacità di reinventarla7. In nessuna delle «cover» di cui ho notizia, nessuno cambia una parola del testo – salvo sbagliarsi, come Patti Smith a Stoccolma o come lo stesso Dylan che si ingarbuglia sull’ultima strofa il 10 luglio 2013 a St. Paul, Minnesota. D’altronde è una canzone lunga e un testo molto scritto, difficile da memorizzare.
Tra il 20 settembre 1962 e il 17 giugno 2017, Bob Dylan ha cantato «A Hard Rain’s A-Gonna Fall» in concerto 457 volte. Per forza che si annoia a rifarla sempre uguale8. Quella sera a St. Paul, non lontano dalla natia Hibbing, cambiò la melodia e l’arrangiamento e biascicò le parole fino quasi a spegnerla (partono un po’ di applausi non all’inizio, come avviene di solito, ma solo alla fine del burden – segno che hanno capito che cosa stavano ascoltando solo quando hanno riconosciuto le parole)9. Dylan infatti rifiuta programmaticamente di cantare nessuno dei suoi brani due volte nello stesso modo, e cerca semmai di renderli tutti irriconoscibili per un pubblico che in gran parte, come spesso ai concerti, vorrebbe più celebrare una cerimonia di riconoscimento che ascoltare qualcosa di nuovo. Peraltro, può farlo proprio perché sa benissimo che il pubblico del concerto non ha bisogno di capire le parole o seguire la melodia in quel momento perché, grazie al disco o altra tecnologia del suono, le sa già. È una denegazione, una negazione che evoca l’oggetto negato, un ennesimo «it ain’t me babe», ripetuto alla folla e non ascoltato: «Dylan sarà sempre Dylan», ribadisce imperturbata una fan10.
Come tanti artisti americani, da Faulkner a Mark Twain, Dylan è disturbato dall’idea che un «testo», una volta scritto o «inciso», sia congelato, ossificato in un’immobilità mortale. Una volta registrate le canzoni in studio, dice, «non le voglio sentire più. Le conosco. Le suono, ma non le voglio sentire su un disco»11. Ma anche in performance, l’ombra dell’originale incombe: sia perché parte del suo pubblico vorrebbe che lo ripetesse identico e si risente a trovarlo cambiato, sia perché Dylan sa che è proprio con quel «testo» che lui stesso si misura cercando di liberarsene con la sua voce12. Tuttavia, le performance dal vivo di «Hard Rain»non aggiungono granché di significativo alla canzone, forse perché non c’è niente da aggiungere; non sono una ricerca di significati nuovi, ma si limitano soprattutto a sottrarre, a negare il testo di partenza per non ripeterlo, quasi uccidendolo per tenerlo vivo. Al contrario, brani di una fase successiva, come per esempio «High Water» o «Tangled Up in Blue», hanno «una vita propria in performance»: la ricerca non finisce con la pubblicazione in disco ma continua. Così, «la versione pubblicata di “High Water” è servita più come punto di partenza che come riferimento fisso»13, mentre «Tangled Up in Blue»racconta due storie molto diverse: in prima persona nella versione in studio in Blood on the Tracks (1975), in terza persona nella variante proposta a Roma nel 1984 e poi nel disco dal vivo dello stesso tour, Real Live (2004)14. Ed è proprio un’altra storia.
Parte dell’unicità di Bob Dylan è proprio il modo in cui cerca di essere sia permanente come testo, sia effimero come performance, collocandosi come solo un artista della voce può fare, sul punto dove si incontrano testo e performance, oralità e scrittura. Ora, l’oralità e la scrittura sono entrambe attraversate da una contraddizione fra tecnologia e ideologia. Come nell’economia classica, ciascuna di queste due forme del linguaggio attribuisce valore a ciò che possiede in misura più scarsa e all’inverso di quello che le è tecnicamente possibile. Le culture orali hanno un’ideologia della conservazione proprio perché non hanno modo di conservare niente se non nell’intangibilità labile della memoria. Perciò l’ideologia della conservazione si innesta su una pratica inevitabile del cambiamento: cantori e narratori affermano sempre di raccontare e cantare come i loro antenati ma in realtà non possono evitare di cambiare loro stessi di volta in volta; rivendicano la tradizione come permanenza e la praticano come processo.
Per converso, le culture della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte (che per la parola comincia almeno con l’invenzione della stampa)15 hanno una pratica della ripetizione infinita e un’ideologia dell’innovazione: riproducono libri e dischi in migliaia e milioni di copie, e inventano le avanguardie, il modernismo e il postmodernismo che valorizzano il nuovo, l’unico, l’originale. Persino l’originaria irriproducibilità della performance poi finisce identica su YouTube con centinaia di migliaia di viewers e nei bootleg dei concerti dal vivo. Perciò, mentre i cambiamenti della tradizione orale sono in gran parte preterintenzionali, necessitati, quelli delle avanguardie sono dichiarati e progettuali. Dylan svisa e maschera i suoi brani ogni volta che li canta proprio perché sa che da qualche parte stanno incisi in forma permanente e immutabile, e che le sue reinvenzioni sono misurate sulla memoria condivisa e la presenza incombente di quel «testo» che nessuno imparerà mai per sola tradizione orale.
Oralità e scrittura istituiscono un rapporto duplice e incrociato con la vita e con la morte: la voce nega la morte con il suo movimento e il suo legame indissolubile col corpo, ma la evoca col suo svanire; la scrittura evoca la morte con la sua immobilità ma la nega con la sua permanenza. Per questo, come tutto ciò che è vivo, la ballata è in continuo cambiamento; ma è anche sempre a una generazione dalla scomparsa. Carmela Luci era sui quarant’anni quando la incontrai nel 1973; Teresa Tacchini era del 1914; Giovanna Nobili è nata nel 1920; Ada Barbonari, Vienna Di Lorenzo, Rosa Scorsolini, Angiola Pitari, le signore da cui Valentino Paparelli ascoltò il «Testamento dell’avvelenato»in Umbria fra il 1974 e il 1978, avevano fra i 43 e gli 86 anni16. Forse non ci sono più, forse l’hanno dimenticata; o forse l’hanno passata a qualche figlia o nipote più giovane, forse nelle Highlands o negli Appalachi c’è qualche adolescente che la canta adesso. Non lo sappiamo. La canzone popolare è stata sempre sull’orlo dell’estinzione, ma finora l’estinzione è stata sempre rimandata.
Grazie alla riproducibilità tecnica della musica, «A Hard Rain’s A-Gonna Fall» non corre questo rischio. Il fotografo Mark Edwards racconta una storia straordinaria: nel 1969 si era smarrito nel deserto del Sahara; il nomade tuareg che venne a salvarlo accese un fuoco sfregando due bastoncini, gli offrì un tè, poi accese un vecchio mangiacassette a batterie, e ne uscì la voce di Bob Dylan che cantava «Hard-Rain»17 – non la voce dell’ultima performance dal vivo, ma quella fissata per la prima volta in disco nel 1963. Se per avventura nessuno cantasse o ricordasse più «A Hard Rain’s A-Gonna Fall», potremmo sempre ritrovarla, anche fra qualche secolo, come i manoscritti di un poeta dimenticato, nei vinili e nei cd sugli antichi scaffali o nelle matrici dell’archivio della Columbia, e ricominciare ad ascoltarla e cantarla18. La differenza, naturalmente, sarebbe che grazie al potere di fermare il tempo che hanno le tecnologie della parola, dalla scrittura all’elettronica, avremmo ancora accesso all’«autentico» originale, e forse solo a quello.
Però c’è un altro giro di vite. La tecnologia della voce che fissa una volta per tutte lo standard di «A Hard Rain’s A-Gonna Fall» è anche quella che permette a me, che non le ho mai sentite «dal vi...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- I. Senza rimpianti né vergogna
- II. Canti di innocenza e di esperienza
- III. Il testo e la voce
- IV. Talking Atomic Blues
- V. Il senso della storia
- Testi