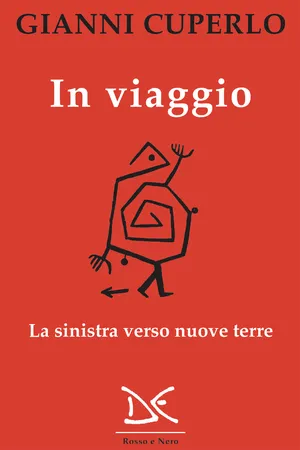
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
«La sconfitta non è uno scalino sceso male. Né si risolve con la semplice scelta di un nuovo capo. Bisogna decidere cosa saremo e quale lingua ci distinguerà. Bisogna farlo adesso, perchè nei vent'anni passati siamo usciti troppe volte con l'abito sbagliato. Per riuscirci avremo sete di nuovi termini e azioni. Per me, per tanti, questa è la battaglia di una vita».
4 marzo 2018. Per la sinistra italiana la sconfitta più bruciante della storia repubblicana. Prima però, il 24 settembre dell'anno passato, c'era stato il deludente voto tedesco. E ancora prima la débâcle socialista in Francia. Col caso unico nella Quinta Repubblica di un presidente in carica neppure ricandidato e una percentuale umiliante nelle urne. Se il millennio compie diciott'anni e diventa maggiorenne, la sinistra sembra immersa nella sua quarta età, dirottata verso un binario morto. Ma è davvero così? Quella dei riformisti e del Pd è una parabola definitivamente segnata? Oppure è proprio quando il vento soffia contrario che l'alternativa di pensiero, presenza e senso di una comunità riscopre la sua matrice? In un pamphlet leale e al tempo stesso impietoso, scritto a ritmo serrato e non privo di provocazioni, la famosa traversata da compiere viene raccontata dall'interno, come un percorso faticoso, duro. Forse carico di nuova passione. Con la coscienza che questa volta serviranno idee radicali e qualche appiglio nell'utopia. Ma è quando tutto pare irrimediabilmente compromesso che la sinistra trova motivo per rinascere. A patto di...
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a In viaggio di Gianni Cuperlo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Politica e relazioni internazionali e Governo americano. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Politica e relazioni internazionaliCategoria
Governo americanoQuinto bagaglio. Partito
Meglio evitare giri di parole. Il Partito democratico venne pensato per la gente, per il «popolo». Ma la messa in opera ha avuto un timbro diverso. Il disegno, utopico nell’ispirazione, è stato cucito come un vestito di sartoria per un ceto politico. Molti dei guasti di adesso derivano da quella scelta. Dopo la sconfitta peggiore della nostra vita, senza una correzione alla radice il progetto non avrà terra per ricrescere. Ecco perché, tra tutti, il quinto bagaglio andrebbe considerato in testa a ogni altro pensiero.
★
Cosa c’era di più ambizioso della fusione tra ceppi divisi del riformismo italiano? Cattolici, comunisti, socialisti, verdi, radicali (pochi), amanti dei diritti e del diritto, azionisti per elezione, liberali e modernisti, senza patria o partito, donne, uomini, ragazzi, intellettuali, precari, casalinghe, pensionati, reduci dell’altro secolo, orfani della questione morale, imprenditori di quarta generazione, patiti di start up, millennials, blogger e vai avanti tu.
All’appello non mancava nessuno. Perché tanti hanno scorto l’imprevisto, la novità capace di sradicare appartenenze da proiettare in uno spazio tutto da arredare.
Le condizioni per farlo erano ispirate alla storia. L’89 aveva archiviato l’anomalia a sinistra col più grande partito comunista in Occidente aggrappato all’ultimo vagone prima di appiedarsi per sempre. Il triennio 1992-94 a sancire la fine del sistema costruito su due baluardi: una democrazia impedita e la spesa pubblica come diga di consenso. Sepolti i partiti maggiori, al centro e a sinistra, estirpata con scarso riguardo la radice socialista, c’erano le premesse di una unità dei progressisti da contrapporre alla coesione di moderati e destra. Due campi. Un bipolarismo, magari immaturo, ma per i tempi l’alba del nuovo giorno.
L’Ulivo si genera lì. A detta di alcuni doveva restare un’alleanza elettorale corredata di un programma e leader condivisi, per altri era un percorso destinato a generare il partito del secolo.
In verità le ragioni dell’approdo affondavano – pure questa non ti sembri una novità – nella vicenda del paese. Nello specifico in quei due filoni di giudizio sulla natura della Nazione per come si era evoluta.
Da una parte gli arrendevoli a una malattia inguaribile per una popolazione fragile in sé. Scarso senso del pubblico, legalità a singhiozzo, spinta a evadere le regole almeno quanto il fisco, regioni intere dominio di criminalità incistata nello Stato e supplente di troppe carenze sociali. Insomma, vizi, storture, così pesanti da doverci convivere. Da qui la metafora giolittiana del governare l’Italia come vestire un «gobbo». Oppure l’altra soluzione, «cancellare la gobba», ma a condizione di affidare le redini a un’élite illuminata, estranea per censo e formazione a cattive abitudini e pessime condotte. Da Croce a Salvemini, passando per Einaudi, una cerchia di monumenti della Repubblica non lesinò consenso alla visione meno disponibile a redimere dal basso quella società generata male e vissuta peggio.
Poi c’è l’altro filone. Bellissimo per tante ragioni. Non nega guasti e patologie. Anzi, li studia, li scava a fondo in pagine fondamentali per comprendere il carattere degli italiani, la «biografia» della Nazione. In quel percorso convivono storie tragiche assieme a gesti di riscatto. E comunque fu questa seconda via ad aprire il cantiere della ricostruzione dopo il ventennio e la guerra. In quel solco, prima di allora, erano vissuti Gobetti e Gramsci. E Sturzo. Vennero poi le culture fondative del patto repubblicano e del compromesso costituzionale.
Ora, per mezzo secolo quelle identità avevano marciato divise seppure cogliendo, in un’epoca di fratture ideologiche, l’arte di conoscersi e rispettarsi. Ci sono frasi di Moro sui comunisti meritevoli di tributo. E lo stesso se inverti le parti. Ma la politica aveva i suoi ingaggi e prima della svolta, a inizio anni novanta, tutto ciò non avrebbe avuto modo di imporsi su una democrazia piantonata.
Certo, quelle bandiere e i loro simboli si erano incrociati nelle piazze. Era accaduto spesso, nel segno dell’unità contro terrorismo e stragi o nelle celebrazioni sulla lotta di Liberazione. Ma solo trent’anni fa, anzi meno, si riuscì a condurre i blocchi diversi a una sintesi da proiettare, senza abiure, in un tempo prossimo. L’Ulivo ebbe quel valore e aprì la strada all’atto fondativo di un partito – il Pd – originale in ogni senso. Una forza inedita perché impossibile nel mondo precedente la caduta del Muro e la fine del modello di crescita perseguito dall’Italia nei cinquant’anni dopo la guerra.
Bene, fine della ricostruzione. Ma credimi, senza la cornice faresti fatica a comprendere l’entusiasmo esploso attorno alla scelta. Non a caso erano personalità del tempo trascorso le più pronte a coglierne la portata. Pietro Scoppola, Alfredo Reichlin. Intellettuali o politici, per molti tra loro le qualifiche si fondevano, in grado di capire la fine di un’epoca e l’ingresso nell’altra.
Queste furono le premesse. Alte, se vuoi. Persino esagerate. Comunque in conflitto con la materia disponibile. Intendo le culture riversate nell’impresa e il metodo scelto per predisporla. Come avviare la costruzione di un palazzo e all’apertura del cantiere trovarsi in dotazione solo sabbia.
« Pensammo una torre, scavammo nella polvere » è il verso scolpito da Ingrao per figurare il comunismo, «grande ambizione e grande fallimento». Parafrasandolo nel partito del secolo dovremmo dire « Pensammo una torre. E non pensammo più ». Doppiamente colpevoli dinanzi a un mondo in procinto di capovolgersi sotto i nostri occhi.
All’atto fondativo ricordo personalità spiegare senza titubanze la vera rottura. A nascere non era solo una forza post-ideologica, e fin qui al più si poteva eccepire. No, il cambio di scenario era dare vita a un partito post-identitario. Nella traduzione equivale a dire «senza identità». Ecco, tra mille peripezie, almeno quel traguardo è stato raggiunto.
La verità? Temo sia nella diagnosi di Massimo Cacciari e in quel giudizio sulla fusione di storie ormai dormienti: «C’è oggi chi ciancia di un’identità da ritrovare. Ma quale identità può ritrovare chi mai l’ha avuta?». Aggiungendo da parte sua l’invito a spolverare la memoria e su questo, al punto in cui siamo, solo chi voglia fingere può non vedere.
★
Più o meno questo intendevo nel dirti l’ispirazione del soggetto. Il Pd non è stato un episodio, un capitolo slegato da prima. E neppure una formula a compensare la carenza di protagonisti. Nelle intenzioni, ma solo in quelle, è stata la forza pensata per catturare passioni e generosità di un popolo sparso e in parte sperso perché orfano di ancore ideali tese a riscattarlo. Questo voleva significare «un partito pensato per la gente». E la reazione all’inizio fu conferma di una comunità in attesa, ben disposta e tutto sommato fiera, dopo tanto peregrinare, di trovare la casa del sogno. O dell’umana e ragionevole utopia. La nuova casa per una sinistra «di lotta e di governo».
★
E invece? Invece il disegno più ambizioso del secolo ha presto fatto spazio alle ambizioni di un ceto politico inadatto a ritrarre lo sforzo. Non solo per modestia soggettiva. Di quella ciascuno sopporta il peso e prova a conviverci. Tanto meno a ragione di una moralità difettosa. Anche questa c’è stata, ma ha punito i singoli e non riguarda il discorso aperto qui. No, la critica – l’autocritica – investe la scelta di una classe dirigente convinta di presidiare sé stessa nell’unica forma possibile, l’esercizio del potere, dentro e fuori.
L’intera costruzione si è piegata a quello scopo. Statuto, regole, filiere, correnti e carriere, ogni passo da lì in poi ha teso a esasperare un profilo schiacciato sulle istituzioni, con la sola vocazione al governo, ma in una scissione dalle ragioni più prossime al mondo esterno.
Del resto quale altra pozione o intruglio avrebbe spinto persone di senno a raccontare le primarie come discrimine della nuova identità? Le primarie capisci? Non l’idea di giustizia o la frontiera di emancipazione, o il soddisfare bisogni vitali in ambiti sempre più espulsi dalla relazione tra inclusi e non. Le primarie! Conferendo alla deliberazione dal basso – tout le monde al modico prezzo di due euro – il diritto a scegliersi il «sovrano». Ma quella logica, in nulla agganciata a una visione del nuovo da costruire, rispondeva allo scopo: centralizzare il consenso sulla persona scambiando un’adesione cosciente col metadone dei gazebo. Un pasticcio destinato a peggiorare col tempo. Penso di doverlo dire anche per diretta complicità avendo preso parte a una di quelle contese.
Il punto è stato confinare la cittadinanza politica a una dimensione giocata, da lì in avanti, su piani diversi: l’uso dei media, l’abilità a cumulare risorse fuori dai canali pubblici, il comporre alleanze estranee all’universo sociale di ieri. Se vogliamo riflettere con onestà, questa logica, in parte esasperata nella stagione ultima, viene da prima. Origina dall’equivoco dell’inizio, la gerarchia invertita tra punta e base della piramide.
Non capiamo neppure la performance del 4 marzo se non le restituiamo questo respiro. Perché fenomeni del genere non si improvvisano, nel bene o nel male. In questo la scarsa analisi della sconfitta, l’ennesima rimozione, lascia interdetti perché presuppone l’idea di aver fatto buona parte del lavoro come si doveva. Seguendo questo filo però si lasciano fuori dalla porta le chiavi di accesso alla perdita di milioni di voti. Non lo scrivo per rovesciare su altri le responsabilità. Se posso una parentesi, sento di essere partecipe, e al fondo tra gli artefici di tanto abbaglio fosse solo per averlo taciuto anche prima dell’ultima fase. Quindi la durezza è necessaria perché il tempo è scaduto. Da molto. E ora sull’onda degli eventi, e della sconfitta, merita compiere quel reset troppe volte evocato e rimasto a mezz’aria. E allora via, una volta scelto di remare controcorrente, facciamolo come si può e si deve.
★
Primo. Pensare a un partito del mondo digitale secondo parametri e categorie del tempo di prima è come inserire il gettone nello smartphone. Non ricordo chi l’ha detta, ma mi piacque tantissimo!
Esiste oramai un’intera letteratura su come la rete ha travolto le forme dell’adesione e del deliberare. Forse non a caso Lega e 5Stelle la mattina della vittoria hanno ringraziato per primi i militanti digitali. Ora, mentre noi eravamo presi dalla campagna elettorale a Washington proseguiva l’inchiesta sul condizionamento delle presidenziali 2016 per mano di hacker riconducibili a una regia di marca russa. Nessuno, neppure il procuratore capo del Russiagate, pensa siano state interferenze determinanti sull’esito. Ma è possibile, a questo punto probabile, abbiano indebolito i candidati scomodi a partire da Hillary, e favorito i due outsider, Trump e Sanders. D’altra parte basterebbe questo a far suonare l’allarme. Cosa accade quando la competizione per il consenso subisce alterazioni indotte non dal posizionamento di singoli media «interni», ma da centrali straniere attrezzate a influire sull’opinione pubblica a migliaia di chilometri da sé? Soprattutto di quali anticorpi la democrazia dispone fuori dalla logica autoritaria, finché durerà, tipica di regimi come la Russia stessa, la Turchia o la Cina?
Le scuse tardive di Zuckerberg sull’uso di 50 milioni di profili da parte di Cambridge Analytica, anche in quel caso a fini di influenza sul voto per la Casa Bianca, raccontano più di tanti editoriali l’impatto di processi capaci di ridurre la sovranità di singole nazioni, fosse pure la più ricca e potente della terra. Arginare il rischio sarà compito di leggi e procedure, nonché accordi sovranazionali tutti da scrivere. Ma come spiega Michele Mezza serviranno soprattutto «saperi, pratiche e relazioni oggi indispensabili per dare forza e forma a una macchina politica». Insomma, per stare al gettone telefonico, non combatti la criminalità in rete aggiungendo inchiostro al ciclostile.
Neppure si può immaginare di iscrivere la tecnica all’esercito avversario. George W. Bush qualcosa del genere teorizzò pochi mesi dopo le Torri parlando all’accademia militare di West Point, «la tecnologia è oggi il principale nemico degli Stati Uniti». Per il presidente erede dell’Apollo 11 un’affermazione forte.
Il tema comunque esiste. E non è materia da delegare agli specialisti, per quanto preziosi. Abbiamo bisogno di una miscela tra nuova epistemologia, il discorso razionale su scienza o tecnica, e l’incrinarsi di ogni legame intessuto tra politica e società. Senza questa coscienza non capiremmo il disprezzo, o comunque la distanza, verso l’anima dei partiti. Ma non tutto può rientrare nella critica alla corruzione.
Sarà banale ricordarlo, ma quel divorzio affonda in aspetti diversi già accennati, a cominciare dallo snodo del lavoro. Sono le strutture di fondo della società, la sua divisione in classi, le forme della rappresentanza da lì derivate per decenni, a subire contraccolpi pesanti. La sinistra e i suoi miti quel sommovimento lo hanno subito. Al massimo aprendo un fronte polemico, peraltro sacrosanto, contro le fake news. Messaggi pilotati e talvolta violenti tesi a screditare l’interlocutore. Prima o poi è capitato a molti. Nel mio caso, in sé modesto, con l’accredito su un sito timbrato da un simbolo avversario del possesso di un certo numero di ville e tre villaggi turistici affacciati sulla Costa Smeralda. Cose così e quando capita ti senti sciocco a dover smentire. Perché è uguale a dichiarare di non essere Nembo Kid. Ma su questo vale la chiosa di Remo Bodei sul significato di limite: «Grazie alla diffusa e interessata infantilizzazione del pubblico, specie in campo politico, il tratto fondamentale della menzogna non è quello di nascondere la verità, ma di sostituirla, di distorcere le idee e di uccidere i fatti, che però hanno la testa dura».
Insomma noi, la sinistra, messi così, mentre i circuiti del sapere navigano lungo corsi paralleli, sovrastanti, sottostanti. In ogni caso senza lasciare all’innovazione, di linguaggi e modalità dell’aggregare consenso, lo spazio per incrociare la politica. Mondi via via scissi, sino a rompere l’unità dei singoli tra il rigore del comportamento e la pressione della rete.
Esempi? Quanti ne vuoi. Schernire battaglie ritenute sbagliate pure se attivano milioni di persone. Utilizzare tweet e retweet come arma contundente, magari contro il tuo stesso compagno di partito. Attivare dichiarazioni in batteria, talvolta persino all’insaputa dei dichiaranti.
Ma allora? Come si aggredisce il dramma fotografato ancora da Mezza, l’incredibile rovesciarsi della relazione tipica dell’altro secolo, l’idea di una presenza organizzata della sinistra in corrispondenza a ogni gradino nello sviluppo della tecnologia? Come rifondi il soggetto se quanto di più contemporaneo confligge con la tua cultura, forma, identità?
Sarà scontato, ma a meno di fermare il presente con la forza del pensiero, la via è rivedere la tua cultura, forma, identità. Senza questo saremo obbligati a inseguire. E magari riconoscere il dominio di guru dei big data predisposti a denunciare la fine della politica e l’inutilità della democrazia.
È un capitolo enorme. Incrocia il fenomeno 5Stelle per come si è configurato. Non serve demonizzarlo. Da che pulpito poi? Quello di secondo o forse terzo partito? No, bisogna scavare, comprenderlo. Certo, quel simulacro di democrazia interna pare più fragile del ramo dove stanno seduti. La scelta di un capo, come nessun’altra forza è in grado di produrre. La riduzione del pluralismo a colore, sfumatura di tono in una chiazza uniforme. La pratica dell’espulsione come avvertimento verso il potenziale dissenso. Ma soprattutto la capacità di travestire l’automatismo dei riflessi sulla rete, opportunamente filtrati, in pratica della decisione. «Delibera la rete», formula caustica, in sé definitiva. Ma come decide la rete? E da chi è composta la platea dei decisori? Da chi viene selezionata o depurata, depennata?
Sono questioni legittime credo, non offensive. Anche perché – lo posso testimoniare – quel movimento non si è limitato a questo e sarebbe sciocco crederlo. Hanno elaborato scenari, disturbato saperi, organizzato confronti su scelte di merito. Potrei trovare – lo dico supponendo e senza supponenza – nella biblioteca di un perfetto grillino parecchi doppioni di testi abbondantemente fruiti da noi. E ovviamente l’inverso. Dunque il punto non è legittimare o meno un impianto comunque distante anni luce da quello praticato a sinistra. Il punto è accelerare un modello nostro all’altezza del cambio di scena e di mondo.
★
Allora, un partito a rete, per non finire divorati dalla rete? Traduciamolo: dobbiamo ricostruire la ragione operativa di una militanza estranea ai luoghi dove classicamente si formava: la fabbrica, il filtro associativo o sindacale, scuole o università. Storicamente un’élite consapevole del proprio progetto andava alla ricerca della base sociale capace di proiettare quel disegno nella rappresentanza, e dunque nella sfida del potere. Me lo ripeteva Alfredo Reichlin, «la sinistra un popolo non lo ha trovato, lo ha cercato, scelto e costruito». Era la sintesi di quella cultura.
Oggi non va dismesso l’obiettivo – la costruzione di quel popolo – ma devi adeguare il processo, gli strumenti, il linguaggio. Almeno devi sapere quale peso assumono algoritmi capaci di proiettare il sapere sparso e la volontà della massa dentro filtri in grado di condizionare le decisioni, comprese le deliberazioni di un partito e di un elettorato. Cambia la gerarchia del potere, forse non ancora del comando, nel senso di chi ha la potestà, per dire, di comporre le liste elettorali. Ma del potere sì...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- Premessa
- Primo bagaglio. Speranza
- Secondo bagaglio. Identità
- Terzo bagaglio. Libertà
- Quarto bagaglio. Conoscenza
- Quinto bagaglio. Partito
- Sesto bagaglio. Politica
- Settimo bagaglio. Europa
- Ultimo bagaglio. Sinistra
- Conclusione
- Un paio di cose da scorrere, rivedere o riascoltare