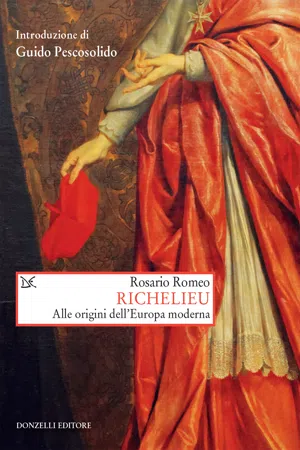
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Anno accademico 1963-64. Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma. Rosario Romeo – giovanissimo professore ordinario e già uno dei più prestigiosi storici italiani – tiene le sue prime lezioni. Il corso ha per oggetto un protagonista della storia europea dell'età moderna: il cardinale Richelieu. Per quel corso Romeo scrive un fascio di dispense, oggi introvabili, ma rimaste memorabili tra gli allievi. Rilette a distanza, quelle pagine offrono un saggio di stupefacente vigore interpretativo dell'ascesa al potere del più grande uomo politico del Seicento. È questa la fase – come sottolinea nell'Introduzione Guido Pescosolido, allora allievo di Romeo – nella quale prendono forma e si consolidano le costanti della storia degli ordinamenti politici e degli equilibri di potenza in Europa, destinate a proiettarsi nei secoli successivi. Ancora in pieno Ottocento, il movimento nazionale per l'unificazione italiana e il suo maggiore artefice, Cavour, dovranno fare i conti con le onde lunghe di quelle vicende: l'assolutismo monarchico come forma di regime politico-istituzionale e gli equilibri di potenza incarnati dalla lotta tra Francia e Impero asburgico, in un quadro di frammentazione politico-militare delle altre due componenti decisive dello spazio europeo, l'Italia e la Germania. Si spiega così l'attenzione che Romeo dedica a Richelieu e alla Francia del Seicento, proprio nel momento in cui era ancora immerso nelle roventi polemiche con la storiografia marxista sull'interpretazione gramsciana del Risorgimento e sullo sviluppo capitalistico italiano postunitario, ma stava anche lavorando intensamente alla monumentale biografia su Cavour che vedrà la luce in seguito. Stupisce, in queste pagine, l'ampiezza di visione e la forza dello sguardo prospettico di Romeo. E colpisce la capacità, oggi malauguratamente perduta, di abbracciare contemporaneamente, nella pratica storiografica, ambiti e periodi così diversi, rifuggendo da eccessi di specialismo, pur senza alcuna deroga al rigore e alla serietà dell'indagine.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Richelieu di Rosario Romeo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia mondiale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia mondialeIntroduzione
Il testo che qui si propone è pressoché inedito. Si tratta infatti della ristampa delle dispense litografate delle lezioni universitarie di storia moderna tenute da Rosario Romeo nell’anno accademico 1963-64 nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma1, la cui circolazione fu circoscritta agli studenti di quell’anno e poi a quelli del corso del 1970-712.
Di primo acchito il tema del libro potrebbe destare una qualche sorpresa nei conoscitori delle opere di Rosario Romeo, la cui fama internazionale fu infatti legata sin dagli esordi – e lo resta tutt’ora – soprattutto ai suoi studi su Il Risorgimento in Sicilia3 e sul Risorgimento in generale4, nonché al rovente dibattito suscitato dalla sua confutazione dell’interpretazione del Risorgimento di Antonio Gramsci e di Emilio Sereni, e dalla sua analisi dello sviluppo capitalistico italiano postunitario proposta con Risorgimento e capitalismo e continuata con la Breve storia della grande industria in Italia5. Certo, già prima del 1963 una non trascurabile risonanza aveva avuto, in Italia e all’estero, anche il lavoro su Le scoperte americane nella coscienza italiana del Cinquecento, uscito nella «Rivista storica italiana» nel 1953 e in volume nel 19546; esso però era apprezzato solo nell’ambito degli studiosi del Cinque-Seicento e della colonizzazione delle Americhe. E anche l’originale saggio su La signoria dell’abate di Sant’Ambrogio sul comune rurale di Origgio nel secolo XIII, pubblicato nel 1957 nella stessa rivista, rimane tutt’oggi conosciuto quasi esclusivamente dai cultori di storia del medioevo7. In entrambi i casi, comunque, nulla di paragonabile alla risonanza internazionale ottenuta dagli studi sul Risorgimento e sullo sviluppo economico dell’Italia liberale e dalla monumentale biografia di Cavour, alla quale Romeo cominciò a lavorare sin dalla seconda metà degli anni cinquanta e il cui primo volume vide la luce nel 19698. Resta il fatto che fino al 1963 nessuna opera era stata dedicata da Romeo, né lo è stata dopo, a problematiche strettamente seicentesche e ancor meno alla figura del cardinale di Richelieu.
La sorpresa però viene meno rapidamente se si porta attenzione non solo alle opere storiche più rilevanti, ma anche all’attività didattica di Rosario Romeo9. Facendolo, si constata agevolmente che il maggiore risorgimentista italiano, vincitore nel 1955, a soli 31 anni, di un concorso a cattedra di storia del Risorgimento bandito dall’Università di Palermo, nella sua vita accademica non coprì mai una cattedra di storia del Risorgimento e che nella sua attività didattica di rado gli argomenti strettamente risorgimentali ebbero la priorità su quelli di carattere più generale di storia medievale, moderna e contemporanea. Infatti nell’ateneo di Messina Romeo fu titolare di una cattedra di storia medievale e moderna, e nell’ateneo romano di una di storia moderna, disciplina nella quale aveva conseguito la libera docenza già prima della vincita del concorso di storia del Risorgimento. E questo perché Romeo appartenne a quella categoria di storici, oggi del tutto estinta, in possesso di una cultura e di una metodologia della ricerca storica che permettevano loro di affrontare tematiche economiche, sociali, politiche e ideologiche lungo un arco di tempo esteso dal medioevo all’età moderna e contemporanea e in un orizzonte geografico non solo italiano, ma anche europeo ed extraeuropeo. Nel 1956, quindi, chiamato per volontà e iniziativa di Giorgio Spini a insegnare nel Magistero dell’Università di Messina, vi tenne un corso monografico dedicato a un grande tema di storia medievale: Le origini della signoria viscontea10. Del resto, l’ampiezza e la capacità di penetrazione del suo sguardo storico nel lungo periodo erano emerse con chiara evidenza già nella sua prima opera, Il Risorgimento in Sicilia, dove la riflessione sulla nazione siciliana muoveva dall’età normanno-sveva fino ad approdare allo snodo dell’Unità d’Italia. E ad argomenti di storia medievale Romeo tornò ad anni alterni almeno finché rimase nell’Università di Messina11.
Nel 1962-63, al suo primo e unico anno di insegnamento nella Facoltà di Magistero dell’Università di Roma, egli dedicò invece il suo corso monografico a un tema che più «suo» non poteva essere, ossia quello dell’ambiente familiare e della prima giovinezza di Cavour, alla cui biografia stava allora lavorando alacremente12. E sarebbe stato del tutto normale se nel 1963-64, chiamato alla Facoltà di Lettere e Filosofia dello stesso ateneo sulla seconda cattedra di storia moderna, creata appositamente per lui per iniziativa di Nino Valeri, avesse insistito su quel tema. Invece decise di trattare nuovamente nelle sue lezioni un argomento ortodossamente modernistico – il titolo del corso fu Richelieu e la guerra dei Trent’anni –, basato sulle dispense che qui si ripubblicano e sul volume di Victor-Lucien Tapié, La France de Louis XIII et de Richelieu, nella versione originale francese perché non ne esisteva ancora la traduzione in italiano13. Solo in aggiunta gli studenti erano obbligati a leggere la sua Breve storia della grande industria in Italia, ristampata nel 1963, e a partecipare a un seminario a scelta fra quelli tenuti dagli assistenti Mario Signorino e Claudio Signorile14, oltre ovviamente a dover studiare la storia generale dalla fine del Quattrocento fino all’età contemporanea inclusa, usando i volumi II e III di un «buon manuale per i licei»15.
Fu quindi una scelta coerente con la titolatura della cattedra ricoperta, una scelta che relegava in secondo piano la parte riguardante la storia dell’industria otto e novecentesca e che fu ripetuta poi quasi sempre da Romeo negli anni successivi. Fu forse dettata anche dalla precauzione di non creare doppioni con la cattedra di storia del Risorgimento coperta da Alberto Maria Ghisalberti; trovava però le sue vere ragioni nei vastissimi orizzonti della cultura storica di Romeo, nella stretta continuità da lui sempre sentita tra storia moderna, storia del Risorgimento e storia contemporanea, e nella convinzione dell’importanza cruciale che lo studio di quella continuità aveva per la formazione culturale e intellettuale delle nuove generazioni. I corsi monografici di Romeo riguardarono sempre momenti e problemi cruciali della storia moderna e contemporanea d’Europa e del mondo, come la nascita della nazione moderna o la Rivoluzione francese o quella inglese o quella industriale, nel cui contesto si poteva comprendere a fondo la portata storica anche del nostro Risorgimento, quale momento fondamentale della storia d’Italia e d’Europa non solo dell’Ottocento, ma dell’intera età moderna. E ciò valeva anche e anzitutto per l’argomento del corso che egli svolse nel 1963-64, in particolare per la storia delle relazioni internazionali e dello sviluppo degli Stati nazionali italiano e tedesco.
D’altronde la tematica scelta nel 1963-64, come si può facilmente riscontrare leggendo sino in fondo il testo che qui si riproduce, era in realtà per Romeo collegata al Risorgimento ben più di quanto lo sarebbe stata una legata, ad esempio, al suo libro sulle scoperte americane, perché la realtà e i meccanismi di formazione degli equilibri di potenza in Europa, con i quali Cavour e l’intero movimento nazionale italiano dovettero fare i conti nell’Ottocento per creare nella penisola un unico grande Stato indipendente, non erano nati col Congresso di Vienna, ma avevano trovato la loro prima sanzione sul piano del diritto internazionale moderno con la pace di Vestfalia del 1648. Da ciò l’interesse primario di esordire con l’analisi dell’opera politica di Richelieu, che nel giudizio della più autorevole storiografia era considerato uno dei maggiori artefici, se non il maggiore, della nascita dello Stato nazionale assoluto in Francia, dell’affermazione dell’egemonia francese in Europa, della pace di Vestfalia e della nascita del diritto internazionale, in un contesto di relazioni imperniate nel vecchio continente sulla contrapposizione franco-asburgica e la frammentazione politico-militare dell’Italia e della Germania.
Come è noto, quando Romeo tenne il suo corso monografico sulla figura di Armand-Jean du Plessis, vescovo di Luchon, cardinale e duca di Richelieu, su di essa si era accumulata ormai da tempo una quantità veramente notevole di materiali non solo in campo storiografico, ma anche in quelli della narrativa, del teatro, del cinema, della televisione, senza dire della diffusione dell’immagine del cardinale attraverso la ritrattistica, la numismatica, la filatelia. Una produzione che aveva dato corpo al mito double face di un Richelieu dipinto da un lato come genio diabolico del male assoluto, cinicamente e insaziabilmente assetato di potere personale, dall’altro come genio politico votato al bene del re e della patria, costruttore in Francia di un apparato istituzionale prima mai tanto stabile e forte, artefice in Europa di un quadro di relazioni internazionali imperniato sulla pace religiosa in Francia e in Germania e sul riconoscimento della piena sovranità degli Stati nazionali, allora identificati con le monarchie assolute basate sulla partecipazione all’esercizio del potere solo di ristretti ceti privilegiati.
In campo strettamente storiografico, che era la dimensione che più interessava Romeo e che quindi ci riguarda in questa sede, si era avuta una produzione imponente dalla quale, al di là dell’eterogeneità e delle contrapposizioni anche durissime dei giudizi, emergeva comunque, nel bene o nel male, una delle personalità più importanti della storia moderna e contemporanea d’Europa; una produzione che per mole e qualità appare tutt’oggi sempre più schiacciante rispetto a quella dedicata al conte-duca di Olivares, il suo grande avversario spagnolo sconfitto16.
Nel Seicento erano prevalse approvazione, ammirazione, deferenza, abilmente alimentate dallo stesso Richelieu, il quale, grazie anche al supporto di una valida schiera di collaboratori, produsse e raccolse una quantità enorme di suoi documenti e scritti politici divenuti poi una formidabile miniera di fonti storiche17. Era stata ovviamente un’operazione per lo più auto-celebrativa, contrastata per quanto possibile, ma con scarso successo, dai suoi nemici politici, pervasi da sentimenti di avversione e odio che sfociarono nella nota sequenza di congiure e attentati protrattasi sin quasi alla fine dei giorni del cardinale18. Un’operazione che però fu sistematicamente smontata nel Settecento dagli intellettuali illuministi all’insegna della disapprovazione, condanna, ripulsa ideologica e politica dell’assolutismo regio di cui Richelieu era stato in Francia il maggiore artefice. Una reazione che il 5 dicembre 1793 sfociò a livello popolare nell’apertura e profanazione della tomba del cardinale nella chiesa della Sorbona ad opera di una folla di rivoluzionari inferociti, che dispersero le sue ossa per sempre. Si salvò solo la testa, che, dopo lunghe vicissitudini, nel Novecento fu ricollocata nel monumento funebre del cardinale.
Nell’Ottocento, soprattutto Alexandre Dumas, Alfred de Vigny, Victor Hugo costruirono il mito romanzesco dell’uomo di Stato cinico e crudele, che aveva operato persino contro il re. Tuttavia nell’ambito del mondo politico francese di destra e di centro la considerazione e l’ammirazione dell’opera politica del cardinale non ebbero la stessa sorte delle sue ossa, né seguirono gli umori della narrativa francese. Sia nel XVIII che nel XIX e anche nel XX secolo a molti uomini politici e statisti, francesi e non, Richelieu continuò ad apparire come un esempio di uomo di Stato dalle capacità ideative e attuative con pochi eguali nella storia del vecchio continente. Non per caso a fine Ottocento, in pieno clima nazionalista, fu un ministro degli Esteri, Gabriel Hanotaux, a porre le basi della consacrazione storiografica del mito del cardinale con un’opera di cui il duca de La Force, morto Hanotaux, scrisse il sesto e ultimo volume e che Rosario Romeo, pur conscio dei suoi risvolti agiografici, ebbe ben presente nelle sue lezioni19. A quell’opera si era affiancato un consistente lavoro di raccolta, riordinamento e analisi critica di vecchie e nuove fonti e di messa a punto interpretativa, che è poi continuato anche dopo il 1963-6420.
Allo sforzo della storiografia internazionale, soprattutto francese, quella italiana non ha portato grandi contributi, né nell’esegesi delle fonti né sul piano della ricostruzione e dell’analisi critica della letteratura su Richelieu, tranne il ricordato recente lavoro della Doni Garfagnini. Dell’opera politica del cardinale gli storici italiani prima del 1963 si erano occupati in via subordinata solo all’interno di opere generali di storia italiana ed europea e nei manuali scolastici, o, sul piano della raccolta e ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- Introduzione
- I. Il Regno di Francia nel 1610: geografia, confini, struttura sociale
- II. La nobiltà e il clero
- III. Il terzo stato
- IV. Venalità delle cariche pubbliche e amministrazione del regno
- V. La monarchia «popolare» di Enrico IV e la reggenza
- VI. Richelieu entra nella scena politica
- VII. Insuccessi diplomatici e guerre tra Maria de’ Medici e Luigi XIII
- VIII. Luigi XIII contro i protestanti. La «Defenestrazione di Praga»
- IX. Il mondo tedesco alla vigilia della guerra dei Trent’anni
- X. Comincia la guerra dei Trent’anni
- XI. La politica imperiale ottiene vistosi successi
- XII. La Francia arranca nei nuovi equilibri europei
- XIII. Consolidare il fronte interno per dominare in Europa: Richelieu cambia rotta
- XIV. Richelieu fallisce ancora, ma non si arrende
- XV. Richelieu riorganizza la struttura dello Stato
- XVI. La nuova politica marittima e La Rochelle
- XVII. La politica delle «porte»
- XVIII. Richelieu punta all’egemonia in Europa
- XIX. Rivolte popolari contro la politica di Richelieu
- XX. Richelieu e la storia dell’Europa moderna