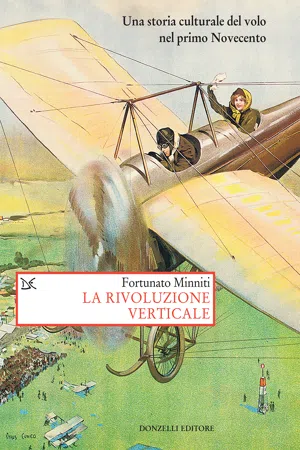
eBook - ePub
La rivoluzione verticale
Una storia culturale del volo nel primo Novecento
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
La «linea verticale è praticabile», esulta nel 1864 Victor Hugo profetizzando la costruzione di quella «nave aerea» che cambierà per sempre la condizione dell'uomo. Quella del volo è una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione verticale, che, dilatando lo spazio percorribile, crea un mondo nuovo. In questo libro Fortunato Minniti racconta la storia del volo dagli inizi del Novecento alla fine della prima guerra mondiale, dalle ascensioni in aerostato e dirigibile ai primi voli dei fratelli Wright, fino alla trasformazione dei velivoli in strumenti di distruzione che muteranno il volto della guerra. Con una sapiente ricostruzione storico-culturale, l'autore delinea il ritratto dei numerosi protagonisti che questa rivoluzione hanno preparato e attuato: i visionari – scrittori, mecenati e politici – che l'hanno immaginata; i «pionieri», che con caparbietà hanno inseguito e realizzato il sogno; gli artigiani che hanno costruito macchine volanti impossibili; e infine, gli imprenditori, che intuirono i potenziali profitti di tale industria. Oltre agli spazi fisici e politici, la conquista dell'aria rivoluziona gli spazi mentali, rendendo possibile un sogno atteso con fiducia da millenni, realizzando un miracolo che prima era tecnicamente e umanamente impossibile. Il ricco apparato iconografico che correda il volume segue l'itinerario di questa rivoluzione, con le immagini dei piloti e dei velivoli, i manifesti pubblicitari, gli aerei da combattimento, passando per le rappresentazioni che del volo hanno lasciato grandi artisti del primo Novecento. Una storia «leggera», che esplora la società, l'arte, la letteratura e la tecnica militare; che si muove in verticale, per seguire il primo accesso di uomini e donne a una terza dimensione dello spazio conquistata grazie a un insaziabile spirito di avventura.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La rivoluzione verticale di Fortunato Minniti in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia mondiale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia mondialeIV. Non ci sono più frontiere
1. Tra politica, diritto e guerra.
L’intraprendenza di una generazione che sta completando il controllo sugli spazi geografici, economici e politici del globo è propria anche di coloro che progettano, costruiscono e pilotano aerei e motori. Mossi da moderne passioni e antiche aspirazioni, sono disponibili a compiere sforzi e a esporsi a rischi mentre partecipano a una ricerca scientifica e tecnica condivisa a livello internazionale. Alla verifica dei risultati conseguiti in numerose gare, nelle quali emulazione e sviluppo tecnico sono egualmente determinanti, si affianca la loro partecipazione a iniziative che puntano ad aumentare le dotazioni di aeroplani migliorati sotto il profilo della navigazione aerea e più utili dal punto di vista militare. Il tutto però in assenza di un quadro normativo interno e internazionale ancora da costruire.
La nascita e la codificazione di un diritto privato e di un diritto pubblico che subordinano la libertà di volo alla difesa della proprietà privata e della sovranità nazionale vanno di pari passo con la diffusione di dirigibili e aeroplani. Già le ascensioni degli aerostati però, soggette a discese incontrollabili e avventurose navigazioni aeree fuori dai confini, pongono le premesse di questo processo di creazione di un diritto aeronautico. Sono ben dieci gli aerostati tedeschi che per cause presentate come fortuite sconfinano in Francia tra l’aprile e il novembre del 1908. Dei venticinque aerostieri che sono a bordo almeno una dozzina sono ufficiali1. Che ci si trovi di fronte a missioni di spionaggio è un’ipotesi fondata. Nello stesso tipo di incidente incorrono del resto anche due ufficiali francesi finiti in territorio tedesco a novembre di quell’anno, dopo un volo in aerostato di ben cinquecento chilometri2. Da Stoccarda proviene l’aerostato, con equipaggio civile di quattro membri, sceso il 4 aprile 1909 nei dintorni del forte di Manonvillers dopo averlo sorvolato. Viene sottoposto a sequestro sino al pagamento di elevatissimi diritti doganali che suscitano le proteste dell’ambasciata tedesca3. Ma i membri dell’equipaggio dopo un interrogatorio sono subito riaccompagnati alla frontiera. E dell’evento tre giorni dopo la stampa non fa più menzione4. Contro l’ipotesi che fa dello spionaggio la ragione degli sconfinamenti si esprime a sorpresa l’anno dopo il capitano Ferber, secondo il quale i tedeschi potrebbero tentarlo senza troppe difficoltà e migliori risultati su rotte che seguano la direzione inversa, dalla Francia alla Germania. Per lui più che la difesa dall’intrusione nel proprio spazio aereo ha valore la garanzia di libera circolazione ovunque5. In Russia prevale una posizione opposta poiché le pur non frequenti intrusioni causano la reazione armata almeno in un caso.
Tra gli studiosi di diritto si contrappongono due teorie, quella della completa libertà e dunque percorribilità dello spazio aereo e quella contraria, che assoggetta tale spazio alla sovranità dello Stato sottostante. Lo spazio e non, come spesso si legge, l’aria, l’impalpabile suo contenuto, suggeriscono alcuni giovani italiani nelle loro tesi di laurea6, deve essere sottoposto a disposizioni di legge che ne regolino l’uso. Un giurista francese, Paul Fauchille, già nel 1901 teorizza la libertà dello spazio aereo poiché la tutela si può esercitare soltanto fin dove giungono in altezza beni privati o pubblici. Nel 1902, quando a volare sono soltanto gli aerostati e in prospettiva i dirigibili, individua i legittimi interessi pubblici da salvaguardare nella repressione dello spionaggio, così come nella tutela doganale e sanitaria e dell’apparato militare, e fissa pertanto al di sotto dei 1500 metri la porzione di spazio sul quale lo Stato esercita la sua sovranità. Nel 1906 l’Institut de Droit international fa propria la visione di Fauchille e ne adotta il concetto, il cui carattere sembra al momento di natura letteraria più che giuridica: «L’aria è libera», bella espressione che tra 1910 e 1911 sostituisce però con la più prosaica ma corretta «la circolazione aerea è libera», relativizzando nel contempo il principio con l’introduzione della tutela obbligatoria degli interessi dello Stato, dei suoi cittadini e dei loro beni7.
In Italia un articolo del codice civile estende la proprietà del suolo a quanto esiste sopra e sotto la superficie, subordinandone così il sorvolo al permesso dei titolari di quel diritto, anche perché non esistono modi per impedirlo. In ambito privatistico il riconoscimento dei diritti dei proprietari dei terreni nei confronti delle attività aeree che si svolgono sopra di essi appare pertanto ben saldo nella dottrina, la quale fissa quote di altezza che garantiscano la non interferenza con le attività sottostanti, mentre la giurisprudenza si esprime sui casi di danneggiamento a seguito di attività aeree non sempre a favore dei danneggiati quando si prospettano casi di forza maggiore8. Quanto all’interesse pubblico prende forma il concetto di «demanialità» dello spazio aereo che sovrasta territorio e acque nazionali9.
Non sorprende che in Francia, dove si vola di più, sorga nel 1909 una Lega contro l’aviazione a difesa dell’integrità di raccolti, fili telegrafici, canne fumarie, tetti e campanili10.
Minori problemi comporta la tutela dell’interesse e della sicurezza dello Stato. Il dibattito in proposito appare più vivo e ricco di implicazioni politiche. Volare diventa presto «una icona» del nazionalismo destinato a produrre con la guerra «infiniti Icari», scrive Piero Boitani11, vittime di una cattiva politica, non della propria hybris. Nazionalizzazione, militarizzazione e controllo dello spazio aereo insieme considerati sono espressi nelle principali lingue europee da parole dallo stesso significato: dominio, maîtrise, command, Herrschaft, la cui valenza si coglie meglio se la si mette in rapporto con un mondo nel quale la forza e il suo impiego politico e militare sono leciti e dunque hanno un valore positivo pienamente riconosciuto tranne che dai pacifisti.
La componente politicamente rivoluzionaria di questo processo di controllo dello spazio sta nel fatto che, pur senza volerne conseguire il dominio, nei movimenti quotidiani dirigibili e aeroplani non incontrano insormontabili ostacoli di tipo geografico né, per il momento, politico nell’attraversare i confini di Stato. I limiti di tipo tecnico, da cercare nelle prestazioni dell’aereo come velocità e quota, autonomia e affidabilità complessiva, sono relativi e ripetutamente superati.
Già Friedrich Nietzsche è sicuro a metà degli anni ottanta dell’Ottocento che «chi un giorno insegnerà agli uomini a volare, avrà abbattuto ogni limite; tutte le pietre di confine voleranno in aria»12. Appena un quarto di secolo dopo a saltare davvero in aria sono i cippi delle frontiere terrestri, a cominciare da quelle che dividono la Francia dalla Germania. Superati allora dagli aerei durante le operazioni di guerra, confermano la profezia di Nietzsche e smentiscono l’auspicio di Zweig al quale, dopo l’impresa di Blériot, i confini di Stato appaiono politicamente ancora più assurdi13 se in quel momento l’aeroplano sembra poter «far diventare astratte le frontiere», poiché da un punto di vista politico esistono ma non segnalano sempre la discontinuità geografica di un territorio14.
Il superamento delle frontiere per via aerea è dunque visto da qualche tempo con sospetto interesse, in Francia per esempio. «L’Assiette au Beurre», giornale satirico, nel numero del novembre 1908 dedica alla condotta impude...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- Premessa
- I. Da lontano
- II. Una rivoluzione culturale
- III. Protagonisti
- IV. Non ci sono più frontiere
- V. La rivoluzione militare
- VI. Questioni d’immagine
- Fonti
- Bibliografia
- Elenco delle illustrazioni