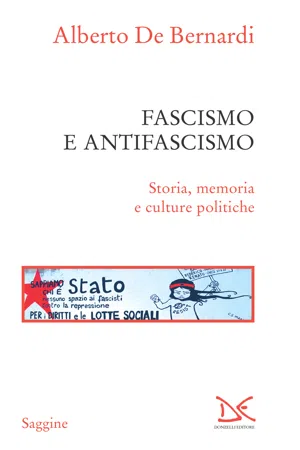
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
«Vi è oggi un uso semplificato e banalizzato, ma fortemente evocativo della storia, come chiave per capire i processi politici in corso, facendo perno sulla categoria di fascismo/antifascismo, dotata di una sua prepotente ricorsività e di una forza simbolica ineguagliabile; anzi di una costante attualità, perché in quella coppia di opposti si riassume tutta la lotta politica dell'Italia novecentesca fino ad oggi. Dietro questa forza però si nascondono molte debolezze: se ogni avversario di oggi non è altro che la reincarnazione di quello del passato, quale strategia si mette in campo per sconfiggerlo?».
La vittoria elettorale della destra populista il 4 marzo 2018 ha sortito, tra gli altri, l'effetto di reintrodurre prepotentemente nel dibattito pubblico la parola «fascismo», attribuendole una nuova attualità come esito possibile della crisi politica italiana e facendo riemergere, soprattutto nella sinistra, la chiamata alle armi sotto la bandiera dell'antifascismo. La contrapposizione fascismo/antifascismo, come non accadeva dagli anni di Tangentopoli, ha riassunto i caratteri di una chiave di lettura per il tempo presente, capace di proiettarsi anche in una dimensione europea. La forza di questo paradigma si traduce in una sovraesposizione dell'uso pubblico della storia, con costanti riferimenti alla Resistenza, alla crisi del 1920-1922, al duce, al razzismo, al neofascismo. La storia torna a essere – come in altre fasi critiche della vicenda repubblicana – uno strumento di lotta politica, con tutto il carico che questo comporta in termini di semplificazioni, strumentalizzazioni, rimozioni e a volte mistificazioni, che rischiano di inficiare la comprensione della realtà. Scopo di questo libro è fare chiarezza cercando di diradare la nebulosa di incrostazioni ideologiche e di false concettualizzazioni che innervano l'uso della storia nel dibattito pubblico e nella lotta politica. Torna no essenziali, a questo fine, i risultati più maturi della ricerca storica, che in questi ultimi anni ha elaborato nuove conoscenze e griglie interpretative del fascismo e dell'antifascismo, in grado di contrastare i forti rischi insiti in quel paradigma. Alberto De Bernardi ricostruisce l'itinerario storico nel quale questa coppia di opposti ha dominato la vita politica e civile dell'Italia, assumendo di volta in volta connotazioni e significati assai diversi. Si parte dalle origini, tra il 1920 e il 1924, in cui le due parole entrano nel lessico della politica italiana ed europea; si prosegue con gli anni trenta, l'epoca dell'egemonia del fascismo in Europa e della sconfitta dell'antifascismo; si passa poi agli anni tra il 1943 e il 1948 con il collasso del fascismo e la nascita della Repubblica fondata sulla Resistenza e sulla Costituzione antifascista; si ricostruisce lo scontro tra fascismo e antifascismo negli anni del terrorismo e dell'«attacco al cuore dello Stato»; per arrivare infine alla crisi della prima Repubblica, da cui prende le mosse una lunga fase dominata dal «post», tra cui anche il post-fascismo e il post-antifascismo, alla ricerca irrisolta di una nuova identità repubblicana. Alla fine del percorso, il lettore avrà acquisito una preziosa «cassetta degli attrezzi», utilissima per leggere il presente fuori dagli stereotipi, dai riflessi condizionati, dalle retoriche.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Fascismo e antifascismo di Alberto De Bernardi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia italiana. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia italianaIV. L’antifascismo alla prova
1. «Non mollare»: ma contro chi e perché?
In effetti il rifiuto del totalitarismo come chiave interpretativa del regime di Mussolini da parte della storiografia italiana era a ben guardare un’eredità dell’antifascismo politico che già alla fine degli anni venti aveva abbandonato questa categoria che pure aveva inventato. Come è noto, infatti, era stato Giovanni Amendola, figura di spicco della liberaldemocrazia, a coniare il termine in due articoli comparsi sulle colonne de «Il Mondo» nel maggio e nel giugno 1923, nei quali accusava il fascismo di aver espresso nella conduzione intimidatoria e violenta della campagna elettorale di quell’anno la volontà di erigere un «potere assoluto», totalitario appunto, sulla vita politica del paese. Due anni dopo fu Ernesto Rossi in un articolo apparso ne «La Rivoluzione liberale» nel gennaio del 1925 a riprendere il concetto e a precisarlo in una chiave più complessiva e organica: «[nel fascismo] tutti gli organi statuali, la corona, il parlamento, la magistratura, che nella teoria tradizionale incarnano i tre poteri e la forza armata che ne attua la volontà, diventano strumenti di un solo partito che si fa interprete dell’unanime volere, del totalitarismo indistinto».
Tre anni dopo fu un intellettuale cattolico esule a Parigi, Francesco Luigi Ferrari, divenuto la figura di maggior rilievo del cattolicesimo democratico nella rete del fuoriuscitismo antifascista, a trasformare una definizione politica in una categoria ermeneutica in un libro comparso nel 1928, che ancora oggi costituisce una delle più originali analisi del fascismo elaborata dall’antifascismo militante tra le due guerre1. Le regime fasciste italien era in realtà la tesi di dottorato in Scienze sociali che Ferrari conseguì con il massimo dei voti presso l’Università di Lovanio, ma ebbe subito un’ampia circolazione nel mondo antifascista dopo la sua pubblicazione a Parigi nello stesso anno, anche se le sue implicazioni politiche si persero nelle fratture tra laici e cattolici che dilaniavano l’antifascismo e il saggio entrò ben presto in un cono d’ombra.
Eppure conteneva un’originalità analitica assente da altri contributi degli antifascisti soprattutto perché ruotava sulla convinzione che il regime, venuto a piena maturazione con la legislazione «fascistissima» del 1926, fosse una dittatura di tipo nuovo, basata su una griglia di principî e di teorie senza precedenti: lo Stato di diritto, seppur nella forma distorta e asfittica che si era affermata in Italia, infatti, era stato soppiantato da un regime «totalitario», interamente posto nelle mani di un «capo», il cui potere si configurava come «totale», perché sciolto da ogni forma di controllo istituzionale e perché dotato di una forza militare volontaria alle sue dirette dipendenze pronta a colpire con la violenza qualsiasi forma di opposizione. Capo carismatico, partito-milizia e autonomia del comando politico sulla società fino a prevedere l’uso sistematico della violenza nella lotta politica venivano individuati da Ferrari come essenza del fascismo, mettendo in evidenza quale fosse la complessità della sfida che Mussolini aveva lanciato contro la democrazia sia sul piano dell’analisi scientifica, sia su quello dell’agire politico.
Una sfida che si manifestò anche nella decisione di Mussolini stesso di appropriarsi del termine coniato da Amendola, utilizzandolo già nel 1924 per sintetizzare l’essenza del progetto politico del nuovo regime fascista in gestazione: una «feroce volontà totalitaria» con l’obbiettivo di integrare la nazione e il nuovo regime in maniera tale che «italiani e fascisti [fossero] la stessa cosa». Il termine dunque si è configurato fin dalle origini come una sorta di autorappresentazione che il fascismo ha voluto dare di sé, enfatizzando l’essenza programmatica della sua «rivoluzione» rivolta a costruire un nuovo regime nel quale lo Stato e il partito unico fossero in grado di esercitare un dominio totale sulla società e una sua costante mobilitazione a sostegno dei «fini ultimi» enunciati dal potere politico e soprattutto dal suo «duce». Un progetto che andava ben oltre la «negazione più assoluta della libertà», secondo la nota definizione del totalitarismo formulata da Hannah Arendt.
Eppure nel giro di pochi anni questo termine svanì dal lessico politico. Per quel riguarda il campo antifascista le ragioni sono molteplici e riguardano soprattutto le rappresentazioni tutt’affatto diverse che si imposero all’interno delle differenti culture politiche alla disperata ricerca di adeguati ancoraggi teorici e politici per comprendere le ragioni e i fattori della loro tragica sconfitta. In realtà per tutti gli anni venti nel composito universo del fuoriuscitismo italiano e soprattutto dei suoi partiti ricostruiti nell’esilio prevalse una valutazione estremamente riduttiva del fascismo: una reazione antidemocratica e antipopolare, capeggiata da un istrione senza idee e foraggiata dalle forze conservatrici e in particolare da quelle capitalistiche, che con la violenza si era impossessata del potere e che teneva sotto il suo tallone un popolo frastornato, ma nella sua stragrande maggioranza avverso al nuovo regime e quindi potenzialmente pronto a insorgere e a rovesciare il potere di questa forza mercenaria, al richiamo di una guida politica autorevole2.
Da questa valutazione emergeva in sostanza una sorprendente sottovalutazione del fascismo che non invocava la necessità impellente di elaborare nuove categorie interpretative, in grado di sostenere un’opposizione politica chiamata a combattere un nemico tutt’affatto nuovo: il nemico era sempre lo stesso rappresentato dalle vecchie élites liberali e il fascismo era un’avventura passeggera, anche se drammatica, che evocava il giudizio su Hitler formulato da Giulio De Benedetti, che lo aveva intervistato sulle colonne della «Gazzetta del popolo» di Torino nel 19233: le invettive antisemite e antidemocratiche del presidente del Partito nazionalsocialista dei lavoratori gli erano apparse bravate di un mitomane, buone per «un pubblico di fanatici nelle grandi birrerie di Monaco» e quel comiziante compulsivo non gli era sembrato «un dittatore troppo pericoloso».
Per queste ragioni la complessità delle categorie messe in campo da Ferrari non servivano: anzi impedivano la creazione di un fronte antifascista, pronto a intervenire in tempi brevi di fronte alle debolezze e alle contraddizioni del nuovo regime che ne rendevano breve e accidentata l’effimera esistenza. Su queste basi si costituì nel marzo del 1927 la Concentrazione antifascista, animata soprattutto da repubblicani e socialisti, cui si aggiunse agli inizi degli anni trenta Giustizia e Libertà, che per poco più di un lustro guidò la lotta antifascista, in un rapporto sempre più labile con la società italiana e di fronte a continue e tragiche smentite della storia.
Mentre il fascismo, soprattutto dopo i Patti Lateranensi e il plebiscito, si era enormemente rafforzato, la Concentrazione, nel rinnovare il patto di unità d’azione tra i partiti affiliati nel settembre 1930 ribadiva la stessa analisi del regime fatta nel Congresso di Nérac, da cui aveva preso le mosse cinque anni prima. «Il fascismo – si legge nel documento che recepiva i nuovi indirizzi della Concentrazione dopo l’uscita dei socialisti massimalisti –, minato dalle sue insopprimibili contraddizioni interne, roso dalla diffusa corruzione affaristica, inetto a dare allo Stato una qualsiasi normalità, isolato dall’odio popolare e non presidiato che dalla forza bruta ed incerta delle camicie nere mercenarie e delle leggi e dei tribunali d’eccezione, sospetto e inviso all’estero a cagione di una politica di arrogante nazionalismo […], mostra ormai chiari anche agli occhi dei ciechi e degli illusi, i segni non indubbi del suo rapido quanto fatale sfacelo».
Questo travisamento della realtà era comune anche all’antifascismo che non aderiva alla Concentrazione, come quello cattolico che, per bocca di Sturzo, continuava a definire il fascismo una casualità eccezionale prodotta dalla guerra e avvalorava, in sede storiografica, la convinzione che i propositi politici delle piccole minoranze di esuli e di circoli sempre più ristretti di italiani che non si arrendevano alla dittatura e mantenevano viva una speranza di cambiamento avessero più il carattere di un’aspirazione morale, di una fede incrollabile, che rappresentare le elaborazioni effettive su cui fondare un’effettiva opposizione al regime. I dirigenti antifascisti ne erano del tutto consapevoli: come disse Pietro Nenni al Congresso dell’unità socialista svoltosi nello stesso anno, «contro il fascismo è vano fare esorcismi [e ] il proletariato non può che attenderlo al varco di due pressoché fatali conclusioni: la guerra e lo sfacelo del mito nazionalista; il disastro economico e la dissociazione del blocco nazionale». Erano affermazioni del 1930 e oggi sembrano scritte nel 1943, ma che testimoniavano la presa d’atto delle difficoltà dell’antifascismo a giocare un ruolo attivo in una futura – e forse futuribile – crisi del regime.
In questo contesto nell’articolata pubblicistica antifascista mancava o era del tutto marginale un’esplicita analisi delle ragioni della sconfitta che non fosse quella di attribuire alla monarchia e alla borghesia di aver tradito lo Statuto consegnando il paese a Mussolini con l’unico intento di ostacolare l’emancipazione del lavoro e la democratizzazione della società italiana. Questa considerazione, in larga misura fondata, spiegava però poco del fenomeno fascista che veniva ridotto a un movimento di «guardie bianche», a un «clan politico» di avventurieri, come lo definì Silvio Trentin4, al servizio di vecchi potentati economici e politici, e soprattutto impediva di costruire attorno a questa analisi un’offerta politica nuova che superasse i limiti dell’Aventino. Quella rappresentazione del fascismo di un movimento estraneo alle correnti profonde della società italiana – l’invasione degli Hyksos lo avrebbe definito Benedetto Croce –, costituito di avventurieri manovrati dall’alto e quindi debole perché fondato su un compromesso che la monarchia e la borghesia potevano in ogni momento revocare, ebbe come conseguenza che fino alla fine degli anni venti l’antifascismo non fu in grado di elaborare una effettiva alternativa al fascismo, che non fosse o un ritorno al vecchio Stato liberale fondato sulla dialettica dei partiti sconfitti o la riproposizione della rivoluzione di matrice bolscevica per realizzare il socialismo. Entrambe queste alternative si rivelarono sterili sia per combattere efficacemente il fascismo, sia soprattutto per costruire l’antifascismo, un «partito» plurale che elaborò tra difficoltà e incertezze un progetto di democrazia aperta e socialmente inclusiva nella quale rinsaldare quella frattura tra masse e potere che si era manifestata nell’immediato primo dopoguerra e che il fascismo e il comunismo avevano ricomposto in chiave autoritaria.
2. Classe contro classe.
In effetti, per molti aspetti, la seconda alternativa al fascismo – la Rivoluzione bolscevica e la dittatura del proletariato – sostenuta da comunisti e massimalisti si collocava al di fuori dello stesso campo antifascista, in quanto non coglieva nessuna effettiva differenza tra Stato liberale e fascismo. «Il fascismo, come movimento di reazione armata che si propone lo scopo di disgregare e di disorganizzare la classe lavoratrice per immobilizzarla – cominciava così la quindicesima tesi approvata al III Congresso del Pcd’I a Lione nel 1926 – rientra nel quadro della politica tradizionale delle classi dirigenti italiane, e nella lotta del capitalismo contro la classe operaia». Il nuovo regime era dunque identico a quello vecchio, tanto da non richiedere non solo nessun cambiamento di strategia politica, ma anche nessuna politica di alleanze con le forze liberaldemocratiche o riformiste, perché come ebbe a sostenere Togliatti la discriminante era la rivoluzione proletaria e non la difesa delle libertà costituzionali e del pluralismo politico. Nella lotta «classe contro classe» che contrapponeva borghesia e proletariato a livello mondiale tutte le forme di esercizio del potere borghese si equivalevano e non implicavano la difesa di spazi di agibilità politica, perché «soltanto sulla propria violenza – è Togliatti che scrive – calcola per ricacciare quella dei suoi nemici»5.
Il processo di bolscevizzazione del Partito comunista italiano andò di pari passo alla progressiva scomparsa della lotta al fascismo come obbiettivo primario della sua azione politica. Sempre nel Congresso di Lione infatti i compiti fondamentali del partito, che si trovava «nella fase della preparazione politica della rivoluzione», erano quelli di «organizzare e unificare il proletariato industriale e agricolo per la rivoluzione» e «porre al proletariato e ai suoi alleati il problema dell’insurrezione contro lo stato borghese».
Anzi fu proprio in questi anni che venne elaborata la categoria del «socialfascismo», cioè della inevitabile contiguità tra il fascismo e le forze liberali, democratiche e soprattutto socialiste, diventando un asse specifico della politica comunista, fondata sul presupposto che queste forze in quanto non rivoluzionarie e spesso dichiaratamente anticomuniste fossero «oggettivamente» alleate del fascismo. Già nel 1921 la risposta di Gramsci sull’«Ordine Nuovo» a un quesito riguardante le differenze tra fascisti e socialisti era esemplare: tra quei due movimenti, apparentemente antagonisti, non vi era in realtà nessuna differenza e ciascuno era la controfigura dell’altro, avendo entrambi come unico obbiettivo quello di disgregare il fronte operaio e di impedire la rivoluzione proletaria. E ancora durante il Congresso di Lione il gruppo dirigente comunista interpretò il quadro politico nel quale si inseriva l’azione comunista, in un momento cruciale del processo di consolidamento del regime, come una «catena delle forze reazionarie»: da Mussolini a Nenni si dipanava un intreccio di collusioni e di omogeneità ideologiche, che trasformava le opposizioni democratiche e socialiste in pericolosi «nemici interni» della lotta antifascista in quanto ostacoli della prospettiva bolscevica.
Al di là dell’incoerenza politica di questa posizione alla luce degli esiti tragici che comportò per il Pcd’I e gli altri partiti che la condivisero – spazzati via dalla violenza e dalla repressione del regime tra il 1925 e il 1927 e poi costretti a una clandestinità sempre meno incisiva e sempre più isolata –, quello che qui preme notare riguarda il travisamento su cui si fondava. Prigionieri del mito del fascismo come regime borghese nell’età della rivoluzione proletaria vincitrice, i bolscevichi e i massimalisti italiani non si avvidero del fatto che il regime creato da Mussolini aveva catalizzato i bisogni e le aspirazioni di un’ampia galassia di ceti medi urbani e rurali, di piccola borghesia impiegatizia e di giovani lavoratori reduci dalle trincee dando loro per la prima volta una forma politica autonoma e dotata di confuse spinte rivoluzionarie originate dalle stesse trasformazioni storiche nelle quali affondava le sue radici la Rivoluzione bolscevica; e che proprio per questa sua fluida identità era in grado di aprire brecce consistenti in quello stesso proletariato di fabbrica che per comunisti e socialisti era omogeneamente schierato in un’opposizione irriducibile al fascismo.
Il fallimento ben dentro gli anni trenta di ogni ipotesi di sollevazione rivoluzionaria delle masse lavoratrici contro il regime in nome del comunismo, su cui si frantumò il Centro interno comunista e le altre scarse forze clandestine operanti in Italia, costituì la più tragica delle conferme della pervasività del consenso fascista anche tra le masse lavoratrici e del progressivo assottigliarsi del mito dell’Urss come forza propulsiva di un progetto politico alternativo capace di mobilitare ampi strati popolari contro il regime. Eppure nel IV Congresso del Pcd’I che si tenne nel 1931 in Germania non c’è traccia di una presa di coscienza della forza del nemico e dell’assoluta debolezza delle analisi e delle proposte elaborate dal Partito, che vennero integralmente ribadite, compresa la teoria del socialfascismo e l’impraticabilità di ogni politica di alleanze in vista di una rivoluzione democratico-borghese. Anzi, come disse Grieco chiudendo i lavori congressuali, il compito del Pcd’I era dimostrare che esso fosse il solo partito antifascista italiano, proiettato verso l’insurrezione e la guerra civile.
Volutamente il gruppo dirigente, reduce dalla lotta interna contro i veri o presunti trockisti e ormai totalmente stalinizzato, cancellò nelle conclusioni ogni riferimento al lungo dibattitto che aveva innescato Gramsci dal carcere proponendo la Costituente democratica come strumento di transizione dal fascismo al socialismo. «La “Costituente” – scriveva – rappresenta la forma di organizzazione nel seno della quale possono essere poste le rivendicazioni più sentite della classe lavoratrice, nel seno della quale può e deve svolgersi […] l’azione del partito […] dimostrando alla classe lavoratrice italiana come la sola soluzione possibile […] risieda nella rivoluzione proletaria»6. Ma questa proposta, che pur Togliatti aveva condiviso, rimase lettera morta e non venne ripresa nel suo «Corso sugli avversari»7, nel quale il segret...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- I. Il ritorno dell’Ur-fascismo
- II. Un richiamo alla storia: due crisi della democrazia a confronto
- III. Il fascismo che non c’è
- IV. L’antifascismo alla prova
- V. Fascismo e antifascismo nell’epilogo della guerra civile europea
- VI. Fascismo e antifascismo nella memoria pubblica repubblicana
- VII. Oltre il Novecento