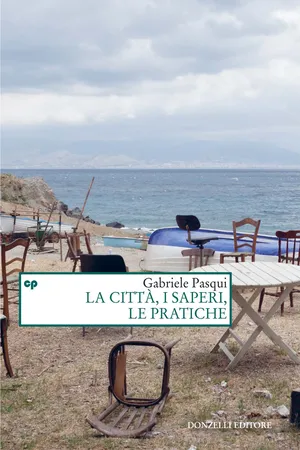
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La città, i saperi, le pratiche
Informazioni su questo libro
La città è sempre stata luogo delle differenze. Luogo in cui i diversi coabitano, mettendo in comune regole di convivenza e dispositivi di controllo. Vivere insieme non è una scelta, ma un destino. Oggi tuttavia la città europea appare incapace di governare il pluralismo, che pure è stato tanta parte della sua storia e del suo destino, schiacciata tra il fallimento della tecno-burocrazia dell'Unione europea e i localismi populisti e regressivi, diffusi ormai in ogni angolo del continente. Come possiamo dunque pensare la città plurale nell'epoca contemporanea? In assenza di fondamenti ideologici, di una visione del mondo condivisa, di uno sfondo comune, come possono gli individui vivere e fare insieme nello spazio urbano? Il libro prende le mosse dall'urgenza di rispondere a queste domande, suggerendo di pensare prima l'essere-insieme, la relazione, poi l'individuo. Si tratta di un esercizio difficile; tuttavia, solo un approccio che sia in grado di descrivere l'individuo come effetto, e non come fondamento, ci permette di comprendere la natura profonda dello stare insieme nello spazio urbano non in chiave comunitaria, ma come disposizione e comparizione, essere-in-comune senza condivisione. Il testo guarda al tema entro tre differenti angolazioni. La prima è tesa a comprendere le condizioni di possibilità di un pensiero della con-vivenza e della con-divisione e le sue conseguenze per le culture urbanistiche e del progetto urbano. La seconda propone una riflessione critica sul progetto urbanistico a partire dalle forme di produzione e trasmissione dei nostri saperi. La terza guarda alle implicazioni di questa lettura della città e dei saperi sul senso e il destino dell'insegnamento e della ricerca universitaria. Scopo del libro è mostrare come sia possibile cercare di convivere nello spazio urbano in condizioni di pluralismo radicale e insieme di ripensare radicalmente strumenti e atteggiamenti del fare urbanistica.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La città, i saperi, le pratiche di Gabriele Pasqui in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Architecture e Architecture General. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
ArchitectureCategoria
Architecture GeneralParte seconda
Guarda ciò che fai
I. Le scritture e i discorsi
1. Linguaggi in transito.
Come possiamo costruire discorsi disciplinari che assumano la città plurale sia come contesto di senso, sia come occasione di progetto? Per rispondere a questa domanda penso sia indispensabile mettere in campo un esercizio autoriflessivo e auto-bio-grafico. Un esercizio che ci metta in condizione di abitare le nostre pratiche esponendoci anche ai linguaggi degli altri, a un campo di discorsi, dispositivi, tecniche e scritture che nella città compongono lo sfondo brulicante delle nostre azioni e nel campo dei saperi definiscono e delimitano i nostri saper dire e saper fare.
Ciascuno di noi può incarnare diversamente questa istanza: per me l’occasione di esercizio è stato un percorso fatto nell’ambito delle attività di Mechrí, Laboratorio di filosofia e cultura1, per il quale ho coordinato tre momenti di discussione, durante i quali ho cercato di dar conto del mio mestiere, riflettendo insieme sulle attività di governo del territorio come pratiche di regolazione dello spazio urbano e sul modo in cui tali pratiche sono concretamente agite, all’intersezione tra saperi diversi, tecnologie, poteri istituzionali, forme di interazione sociale, conflitti, interessi e passioni.
L’esercizio autoriflessivo che ho compiuto si collocava nel contesto di una serie di dialoghi trans-disciplinari denominato «Linguaggi in transito»2, nei quali saperi e discipline provavano a esibire le proprie pratiche a partire da una più generale discussione sul senso e sul destino della nostra cultura e delle nostre conoscenze.
Che significa «linguaggi in transito»? In primo luogo, sono in transito nel senso che si tratta di linguaggi specialistici, non necessariamente disciplinari, che transitano nel mondo, secondo le loro proprie traiettorie e lungo i loro propri vettori peculiari. Guidate da istanze, ingiunzioni, regole e vincoli, volontà di verità e di potere, che non è il caso di obliare, ma piuttosto di esibire.
Non occorre dunque spiegare quel che si crede di sapere, quel che nel sapere si è istituito e istituzionalizzato, definendone i contenuti e i confini, anche se naturalmente una prima comprensione del contenuto dei saperi è assolutamente doverosa, pena una discussione velleitaria, approssimativa, priva di qualsiasi rigore, giocata su assonanze e metafore.
Questo è il primo problema: come dar conto del mio lavoro senza assumere l’esistenza di un common ground, di un sapere condiviso e non superficiale a partire dal quale l’esercizio svolto può davvero dare dei frutti, attraverso cui i saperi possono transitare per quel che sono, e non attraverso una loro rappresentazione semplificata. Il problema, che si pone per qualsiasi linguaggio in transito, è a maggior ragione vero per quei linguaggi dove la scrittura della verità è particolarmente lontana dal linguaggio comune (la matematica, ma anche le scienze naturali fisiche e biologiche e, più in generale, tutti i saperi che utilizzano intensivamente la scrittura matematica). Ma poi è vero per qualunque linguaggio tecnico, per qualunque sapere costituito che si sia dato un suo idioma, se non un suo gergo. Sapendo bene che anche la filosofia ha il suo idioma, spesso molto arduo, ha le sue gergalità, ponendo problemi non dissimili.
D’altra parte, tenendo bene in mente questi problemi, appare evidente che per i linguaggi che transitano non si tratta in alcun modo di costruire una riflessione meta-disciplinare. Non sono qui in gioco una filosofia del diritto, della biologia, della matematica, e ancor meno una filosofia del governo del territorio.
Né divulgazione scientifica, né chiacchiera pseudo-filosofica. Ma allora, cosa transita, e come si transita? In prima istanza transita, o dovrebbe transitare, il sapere in azione. Dovremmo cioè essere in grado di esibire i nostri «sapere» (saper dire, saper fare, saper scrivere, direbbe Carlo Sini) nel loro fare operativo, nel loro esercizio. Da questa prospettiva il tema della regolazione e della pianificazione di modi d’uso e funzioni dello spazio urbano può essere affrontato attraverso una riflessione sulle pratiche operative e sui saperi in azione, cercando di osservarne ed esibirne il concreto funzionamento entro il campo d’azione del governo del territorio e mettendosi così in cammino per un possibile crocevia dei linguaggi3.
Ecco emergere allora la natura del transito: il linguaggio è in transito perché lo è ogni linguaggio, perché l’esperienza della verità, nella sua natura assoluta e proprio in ragione della sua natura assoluta, transita costituendo insieme i propri oggetti e il proprio soggetto.
Questo tema è al centro dell’Enciclopedia filosofica di Carlo Sini, il cui titolo generale è appunto Transito verità4. Nell’Avvertenza generale, proprio all’inizio dell’Enciclopedia, dopo aver presentato le nove figure fondamentali, che scandiscono il transito attraverso i sei saperi esemplari scelti da Sini5, così vengono descritte le tre figure della seconda sequenza (l’origine, la differenza, la trascendenza o negazione): «Le tre figure […] descrivono il transito del soggetto nella verità: verità della sua duplicità costitutiva; vale a dire, soglia del suo evento, in cui lo stacco retroflesso e anteflesso della figura si riassume sempre di nuovo nella unicità dileguante di una trascendenza. Transito e trascendenza sono infatti il medesimo»6.
Transitare la (propria) verità in figura, abitando l’evento della «unicità dileguante» della propria trascendenza: questo dunque viene chiesto ai linguaggi in transito. Per far ciò, è necessario mettere in questione il proprio abitare le nostre pratiche di sapere.
Si transita anche perché il soggetto (del sapere, nel doppio senso del genitivo, come soggetto al sapere prima ancora che come soggetto del sapere) viene messo in gioco nella sua stessa postura, nel suo modo di abitare le proprie discipline, che si chiamano così anche perché regolano i comportamenti, vincolando le possibilità e definiscono normativamente ciò che può e non può essere detto, fatto e scritto. Come insegnava Michel Foucault, e come la filosofia della scienza più accorta non ha mancato di rilevare, non tutto può essere detto in qualsiasi momento: alle spalle dei discorsi si trova il loro punto cieco, il non detto dei loro presupposti impliciti.
Nel transito è dunque in gioco il soggetto, sono in gioco io. Per questo transitare richiede innanzitutto una diversa postura, un diverso modo di stare nelle proprie pratiche, di osservarle e abitarle. Come scrive ancora Sini nell’Avvertenza:
Le rimanenti quattro figure [l’analogia, l’incontro, l’occasione, la verità] articolano l’orizzonte del farsi mondo del soggetto (o di farsi soggetto del mondo), sino alla culminante esperienza del transito/verità. Il soggetto, spoglio di ogni superstizione, coincide allora con la sua «etica», cioè col suo esercizio di attraversamento della verità nell’evento significativo del suo essere in errore7.
Questo dunque viene sollecitato: attraversare la verità dell’evento, del proprio evento come figura incarnata del sapere, facendo esperienza insieme della natura assoluta di tale evento e della sua catastrofe, del suo essere in errore. E in questo modo, abitare l’evento delle mie pratiche, dei miei saperi, come occasione etica, come possibilità di sperimentare una diversa postura, una sospensione attiva rispetto al contenuto dei miei saperi e del mio agire.
Da questo punto di vista ogni pratica, ogni sapere è equivalente: ogni disciplina può esercitare, nei modi che le sono proprie e secondo le proprie figure incarnate, l’evento del transito/verità. Ogni transito è un esercizio esemplificativo. D’altra parte, non posso dimenticare che il mio specifico linguaggio in transito si è collocato in un anno di attività dedicato al tema della legge, e che io stesso ho voluto intitolare il mio ciclo di incontri La città e la legge.
2. Davanti alla legge.
Nel loro transito specifico, i saperi convocati a Mechrí sono chiamati a dar conto del modo in cui interpretano il tema della legge. In questione non è tanto la dimensione strettamente giuridica del nomos, ma piuttosto, come scriveva Florinda Cambria nella presentazione del programma annuale di attività del Laboratorio8, «l’attenzione ai sensi molteplici in cui si declina la nozione di nomos come mira e ritmo che dà forma al vivente».
Come collocare dunque una riflessione sul linguaggio in transito dedicato al governo del territorio dentro questo percorso che ha a che vedere primariamente con «l’aspetto musicale della conoscenza e della formazione»?
Provo a esibire in prima istanza gli snodi principali dei primi due incontri, che hanno avuto il carattere di comunicazioni orali, accompagnate da immagini mostrate su uno schermo e istruite attraverso una traccia scritta messa a disposizione dei soci.
Primo incontro (6 novembre 2016)
Il transito non è solamente il passaggio di un sapere disciplinare che intende mettersi in gioco, ma è anche il modo attraverso il quale ciascun transitante si esibisce, sperimentando un procedimento auto-bio-grafico sul quale Carlo Sini ha lungamente riflettuto. L’auto-presentazione (la mia peculiare biografia, compreso il mio incontro con il magistero di Sini da studente di filosofia, molti anni fa) non è e non dovrebbe essere una esibizione narcisistica (senza dimenticare che questa dimensione non può essere rimossa, perché abita spesso, in mille forme, la volontà e l’ambizione del sapere). È piuttosto un modo attraverso il quale il linguaggio in transito si áncora al transito del soggetto, quello specifico soggetto in carne e ossa che abita, per un certo periodo, la casa di Mechrí.
Dopo questa auto-presentazione, e dopo aver spiegato che l’ambizione del ciclo di incontri non è quella di proporre una filosofia della città (sebbene il nesso tra città e filosofia resti ancora in larga parte da pensare, e sebbene per molti filosofi il rapporto con le città in cui hanno vissuto sia stato decisivo)9, il primo incontro prova a riflettere sul titolo dato al ciclo di incontri (La città e la legge), iniziando a discutere sul senso della parola «città».
Prendendo slancio dall’osservazione che la città è, anche nelle sue forme fisiche più disordinate e nelle sue relazioni socio-spaziali più amorfe, luogo dell’ordine, ossia campo di sperimentazione di specifici ordinamenti, caratterizzati da ritmi (spaziale e temporali) suoi propri, il primo incontro propone innanzitutto una serie di immagini di città (rappresentazioni zenitali e satellitari, mappe di scala diversa ma anche fotografie di luoghi specifici, di città e aree urbane nel mondo). Attraverso queste immagini, che delineano le diverse modalità attraverso le quali si danno i processi di urbanizzazione a scala planetaria, tanto da portare alcuni studiosi a proporre una rappresentazione del globo come spazio interconnesso e totalmente urbanizzato10, il tentativo è quello di riconoscere alcuni spostamenti, in ragione dei quali chiamiamo città qualcosa per la quale non abbiamo ancora un nome compiuto.
Vengono riconosciuti tre segni del cambiamento:
– il limite della città scompare. La città è stata a lungo un luogo chiuso, delimitato (da barriere naturale e artificiali, dal mare e dal fiume, dalla collina, da mura e fortificazioni ecc.). Oggi questi confini, che tradizionalmente dividevano la città e la campagna, non esistono più o tendono a sfumare;
– le città tendono ad assomigliarsi sempre di più. Il carattere delle città, il loro radicarsi in una storia e in una tradizione, vengono meno. Lo mostrano per esempio gli edifici, sempre più simili nei loro formati (i mall, i palazzi a uffici, le infrastrutture stradali, i grattacieli ecc.) e i monumenti delle archistar, prodotti globalizzati e identici in ogni parte del mondo;
– le città sono sempre più luoghi attraversati dalle popolazioni più diverse. Le città sono abitate dai pendolari, dai city users, dai profughi e dai migranti di passaggio, dagli studenti universitari, dai parenti dei pazienti ospedalieri, da molte altre popolazioni che usano la città senza risiedervi. Il rapporto tradizionale tra sovranità territoriale e cittadinanza viene meno, e con esso le forme tradizionali di regolazione11.
In termini generali si tratta di una deterritorializzazione e pluralizzazione dell’urbano in ragione della quale il piano e le sue regole vengono continuamente sovvertite, riscritte, sovrascritte da processi economici, sociali e culturali che le norme e i codici urbani solo in parte riescono a governare.
La seconda mossa, posta in evidenza questa fenomenologia dell’urbano e delle forme di vita che lo caratterizzano, è il riconoscimento del nesso problematico tra norma e vita, tra forme e forze, fin dentro l’origine dell’urbano12. Per dar corpo a questa mossa vengono presentati, in forma necessariamente allusiva e sintetica, alcuni racconti di fondazione, nei quali mi sembra possibile scavare nel nesso necessario tra misura dello spazio e regola dell’agire umano, definendo in tal modo l’orizzonte della cittadinanza.
Attraverso una pluralità di riferimenti13, e rianimando un passaggio dell’Enciclopedia di Carlo Sini, nel quale il tema della fondazione delle città è affrontato con riferimento a Karoli Kerényi14, vengono proposti tre diversi modi di interpretare l’archi-origine della città, attraverso i suoi miti di fondazione, in connessione con tre relazioni fondamentali:
– tra fondazione della città e misura della relazione tra cielo e terra. Come mostra tra gli altri Mircea Eliade, la città è il luogo sacro per eccellenza, omphalos e axis mundi. In culture diverse, in ogni parte del globo, la localizzazione del palazzo e della città è innanzitutto dettata dall’esigenza di selezionare un luogo che unisca cielo, terra e luoghi ctoni;
– tra fondazione della città e traccia del solco che insieme unisce e separa, del limen, del confine che include ed esclude. Come ha mostrato Michel Serres, un racconto esemplare di questa archi-traccia, primo segno della regolazione spaziale, è la fondazione di Roma, la traccia del solco che definisce il principio costitutivo di inclusione ed esclusione;
– tra fondazione della città e la definizione di una griglia, come possibilità di distribuzione delle popolazioni e delle attività, di divisione del territorio in parti uguali, in porzioni isotrope che ordinano lo spazio, assegnando usi e popolazioni. Il primo urbanista, Ippodamo di Mileto, di cui parla Aristotele nella Politica, produce quello che potremmo chiamare un piano regolatore, ossia una griglia ortogonale regolare che definisce insieme una organizzazione funzionale e una forma di cittadinanza.
In queste storie, in questi racconti di fondazione è possibile, in forma naturalmente mediata e già lar...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- La città, i saperi, le pratiche
- Come vivere insieme: pensare la città plurale