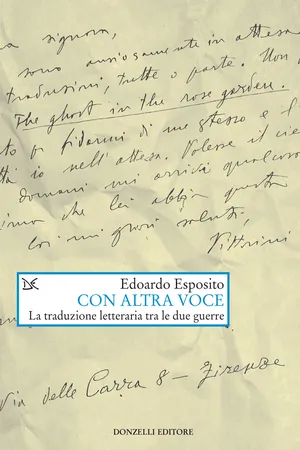
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Dal punto di vista della traduzione letteraria, gli anni del fascismo rappresentano un paradosso. Da un lato, l'editoria italiana va assumendo proporzioni di portata industriale e, per rispondere a una richiesta varia e sempre maggiore di nuovi testi e per contenerne al tempo stesso il costo dei diritti, ricorre al mercato estero e alle facilitazioni che ne derivano; dall'altro, si trova spesso di fronte all'ostilità del purismo e del nazionalismo che reclamano piuttosto la messa al bando degli stranieri e che, tramite l'esercizio della censura, impongono tagli gravosi o impediscono del tutto la traduzione e diffusione di alcune opere. Il volume traccia un quadro complessivo del problema sul piano politico-culturale e su quello strettamente letterario: dal rapporto fra l'editoria periodica e quella propriamente libraria all'impostazione specifica di alcune collane dei grandi editori, al dibattito che si avvia sulle modalità e la possibilità stessa del tradurre sia in ordine ai testi poetici, sia alla narrativa e al suo più largo consumo, fino all'analisi di alcune figure centrali del Novecento italiano, come Elio Vittorini o Eugenio Montale. Nel 1941 quest'ultimo scriveva sconsolato al critico letterario Bobi Bazlen: «Che faccio? Traduco per vivere. In due anni ho tradotto 3 lavori di Shakespeare, 2 romanzi di Stainbecco, 1 libro di Dorothy Parker, il Billy Budd di Melville e altre 10 novelle americane, nonché 3 Intermezzi cervantini e il dialogo dei Dos Perros del medesimo, in più un po' di Bécquer e di Ramon Gomez de la Serna. Presto attaccherò un'antologia di De Foe per Garzanti e forse altro. That's all». Per sbarcare il lunario, Montale fu infatti costretto a una fatica che seppe tuttavia trasformarsi, in molte delle sue pagine, in una felice acquisizione per la nostra letteratura.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Con altra voce di Edoardo Esposito in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Literature e Literary Criticism. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
LiteratureCategoria
Literary CriticismV. Alla ricerca di un linguaggio
Si è accennato alle difficoltà, per la letteratura italiana del primo dopoguerra, di trovare una dimensione espressiva capace di tenere il passo delle mutate condizioni, materiali non meno che intellettuali, che si erano determinate e che in altri paesi stavano per dare luogo alle più significative opere del cosiddetto modernismo. Tempo di edificare, titolava emblematicamente nel 1923 un suo volume di saggi Giuseppe Antonio Borgese, ma in quale senso si dovesse procedere non era chiaro neanche per lui, se è vero che, facendosi sostenitore dell’opera di Federigo Tozzi, ne pregiava tuttavia soprattutto Tre croci, il romanzo più compattamente costruito secondo modalità ancora naturalistiche, e se, facendosi editore del diaristico Ricordi di un impiegato, ne tagliava «deliberatamente tutto quello che, a suo parere, nuoceva all’economia narrativa, alla trazione dinamica del racconto, alla netta delineazione e sagomatura della magra, ma abbastanza drammatica, vicenda»1.
Ho citato parole di Giacomo Debenedetti, che ribaltando l’opinione di Borgese ha creduto di vedere proprio nelle parti «tagliate» e nei fermenti anche acri dell’autobiografismo e dello psicologismo tozziano appunto il segno della modernità che già nutriva la ricerca sia narrativa che drammatica di Pirandello, e che stava per sfociare altrove nella fluviale composizione dell’Ulysses joyciano. Non è qui il luogo per giudicare dell’una e dell’altra posizione, e semplicemente si ricorda il caso a testimonianza degli interrogativi che dovevano porsi allora alla critica e, ancor prima, a chi affidava alla scrittura il racconto del proprio confrontarsi da una parte con la vita e dall’altra con la tradizione letteraria.
Lo stesso Borgese aveva affrontato il problema con le pagine di Rubè (1921), costruendo un personaggio che è parso per molti aspetti, nella sua ansia introspettiva e nell’incapacità di sciogliere le sue tensioni contraddittorie, antesignano di figure che avrebbero avuto di lì a poco, con Zeno Cosini, più decisa rappresentazione. Ma, dal punto di vista espressivo, né Rubè né La coscienza di Zeno avevano saputo intaccare la rigidezza letteraria della nostra prosa, alla quale continuava a mancare il conforto, già attivo altrove, della lingua viva, parlata, o comunque il coraggio della sperimentazione. Si segnala, naturalmente, la scrittura di Palazzeschi; si segnala quella di Bontempelli, ma è solo con Gli indifferenti e con le opere di Alvaro che il panorama della narrativa sembrerà alla fine degli anni venti ravvivarsi.
È stato notato che «Solaria», pur così decisa nel sostenere criticamente l’importanza e il valore della prosa romanzesca, non ne presenti concretamente che scarni esempi nelle sue pagine (la prima puntata del Garofano rosso di Vittorini uscirà solo nel 1933), e proporzionalmente pochi, rispetto ai racconti e alle poesie, nelle sue stesse edizioni2. Si è parlato del resto, a proposito di questo periodo, dell’incapacità della nostra letteratura di «“fare il salto” verso il grande pubblico, diventando mezzo d’espressione dei suoi interessi reali», proprio mentre dall’esterno giungono storie di «un diverso spessore, un sapore di verità e realismo inusuali anche quando si riferiscono a tempi o paesi lontani»3: di una curiosità e di un gusto che trovavano dunque alimento, piuttosto e come abbiamo notato, nel romanzo straniero4.
Sono a lungo i francesi a dominare il campo, e l’orientamento soprattutto ottocentesco della «Biblioteca Romantica» li rende nella collana, ancora negli anni trenta, la presenza più massiccia; ed è un romanziere francese, Alain-Fournier, a inaugurare nel 1933 con Le Grand Meaulnes, tradotto da Enrico Piceni5 come Il grande amico, la nuova collezione «Medusa», intesa a «presentare le opere più singolari dell’alta letteratura mondiale contemporanea»6 e che ospiterà presto Mauriac, Maurois, Colette, Gide.
André Maurois (ancora Piceni risulta fra i suoi maggiori traduttori) è uno dei romanzieri più apprezzati in Italia; ne scriveva Giuseppe Raimondi nel 1928, a proposito del suo Bernard Quesnay:
A lettura finita si ammira la discrezione e la giustizia con cui lo scrittore ha riprodotto un simile ambiente, e ci si ricorda che è propria dei romanzieri di razza francese quell’economia, quella limpidezza e talvolta quella secchezza che fa singolari i loro libri. Né italiani né spagnoli li possono eguagliare. Piuttosto si può avvicinare agli inglesi7.
Con lui, Jacques Chardonne; ha osservato in proposito Anne-Rachel Hermetet che «Maurois impersona però la parte più “facile”, più “per le signore” del romanzo francese e non a caso gli articoli a lui dedicati si possono leggere solamente nelle riviste di informazione letteraria rivolte al grande pubblico come “La Fiera/L’Italia letteraria” o nelle riviste antologiche come “Pègaso”», mentre più interessante appare «il caso di Chardonne, che viene studiato tanto in periodici di larga diffusione […] quanto in riviste sperimentali come “Solaria” o universitarie come “La Cultura”»8.
Si tratta comunque, e ancora, di un’ottica letteraria tradizionale, che si inquadra nel gusto del «ritorno all’ordine» che abbiamo detto tipico della «Ronda» e rispetto al quale già un romanziere come François Mauriac, con la sua prospettiva filosofica e morale, appariva nuovo e non sempre facile da accettare (fra i suoi traduttori, oltre a Piceni, Marise Ferro, Giuseppe Prezzolini, Maria Martone). Più interessante il caso di André Gide, in particolare per la pubblicazione nel 1924 di Corydon, con la sua problematica omosessuale, e nel 1925 con Les Faux-Monnayeurs, che dal punto di vista stilistico e strutturale presenta una decisa evoluzione verso forme narrative più sperimentali e moderne; né l’una né l’altra opera tradotte in italiano, tuttavia, mentre appare nel 1920 Il Prometeo male incatenato (senza indicazione del traduttore), nel 1925 La porta stretta (traduttore Adolfo Franci) e nel 1933 I sotterranei del Vaticano (traduttore Cesare Giardini). Ha comunque osservato Hermetet che:
L’immagine della Francia si rivela piuttosto legata al passato che non iscritta nelle questioni suscitate dal presente. Ne testimonia la sparizione della qualifica «francese» quando le opere vengono definite «moderne», come se queste due nozioni fossero inconciliabili agli occhi dei critici italiani9.
È semmai la scrittura di Proust, destinata a restare fino al 1945 senza traduzione, che sollecita più che i lettori i nostri scrittori e che conserva negli anni venti una posizione di deciso rilievo nel campo letterario alla Francia; ma già alla fine del 1933 vediamo che, dei ventisette volumi pubblicati nella «Medusa», il numero degli otto romanzi francesi è ormai eguagliato da quelli di lingua tedesca. L’osservazione è di Mario Rubino10, che sottolineato come, fino al 1928, «il numero delle traduzioni di narrativa tedesca contemporanea fu davvero esiguo e la scelta delle opere da pubblicare del tutto accidentale», segnala però «il cambiamento radicale» che si ebbe negli anni seguenti, «con ben dieci titoli pubblicati nel solo 1929, che salirono a sedici già nel ’30»11: cosa che era frutto dell’apporto «di una nuova leva di mediatori culturali qualificati» e insieme della «disponibilità di un’editoria in crescita, alla ricerca di nuovi prodotti da immettere sul mercato»12, oltre che, nella drammatica situazione che proprio in Germania si stava configurando, del ricorso a questa «nuova letteratura romanzesca d’oltralpe come di un possibile strumento di conoscenza delle motivazioni più profonde che di quei rivolgimenti erano alla base»13.
Nella sua introduzione al testo emblematico di questa produzione, Berlin-Alexanderplatz di Alfred Döblin, Alberto Spaini parlava della malavita berlinese come di «un nuovo aspetto della grande crisi morale dalla quale la Germania è torturata negli ultimi quindici o venti anni, crisi solo accelerata e spinta a forme mostruose dalla guerra»14; ma accanto a Döblin e ai testi della cosiddetta Asphaltliteratur si pubblicano Thomas e Heinrich Mann, ed è ancora Spaini a presentare nel 1933 Il processo di Franz Kafka, con la raccomandazione di non prenderlo «come un’opera allegorica, da interpretarsi passo passo e parola per parola» se non si vuole perderne «ogni valore poetico e lirico»15.
Fra i protagonisti di questo sviluppo – oltre a Spaini citeremo Enrico Rocca, Ervino Pocar, Leonello Vincenti – un posto precipuo spetta a Lavinia Mazzucchetti, attiva sia sul piano della ricerca universitaria sia su quello dell’editoria e della divulgazione; Anna Antonello indica come due anni chiave del suo lavoro «il 1929, l’anno d’avvio della collana “Narratori Nordici” della Sperling & Kupfer, e il 1933, in cui esordisce la collana “Medusa” con un’importante parte tedesca da lei diretta»16. È infatti per i «Narratori nordici» che «più che mai la Mazzucchetti può scegliere i volumi in base al suo gusto letterario e alle sue simpatie personali: dalla novella Disordine e dolore precoce di Thomas Mann […] a Carlo e Anna di Leonhard Frank, […] poi Zweig, Hesse, Carossa, Wiechert, tutti scrittori amici che pubblica finché non deve piegarsi alle direttive del regime».
Per «Medusa» la situazione è molto simile, e la Mazzucchetti assolve il suo impegno con grande abnegazione17, anche se le vicende politiche erano ormai tali da non consentire l’espansione del settore. Se guardiamo ai dati elaborati da Rundle, il totale delle traduzioni dal tedesco vede nel 1934 e 1935 un calo assai significativo – del trenta per cento circa – rispetto ai dati precedenti e in particolare rispetto a quelli, in costante aumento, dell’inglese e del francese18. Né si avrà più una significativa ripresa, anche per l’adeguarsi successivo, sia pure lento e non senza contraddizioni, al bando già comminato in Germania agli autori dichiarati «decadenti e antitedeschi», nonché, ovviamente, a quelli di origine ebraica.
È ora e piuttosto agli scrittori inglesi e americani che l’editoria comincia a rivolgersi, stimolata dai contatti che si erano andati stabilendo nel tempo e, per quanto riguarda l’America, dalla curiosità anticipatrice di veri e propri personaggi d’eccezione quali Cesare Pavese ed Elio Vittorini19. Si è già accennato a Emilio Cecchi e Carlo Linati, e si devono a loro le prime rassegne organiche di saggi e interventi in materia: di Linati, nel 1932, Scrittori anglo-americani d’oggi, edito da Corticelli, mentre di Cecchi esce presso Carabba nel 1935 Scrittori inglesi e americani20. Sono per entrambi gli autori inglesi a costituire l’interesse primario, sia per le ragioni anagrafiche che li fanno uomini ormai più che maturi al manifestarsi del «mito» americano, sia per quello snobismo culturale che caratterizza soprattutto Cecchi e che gli farà sempre apparire sotto i segni della «barbarie», nonostante singoli apprezzamenti, il lavoro d’oltre oceano21.
Linati traduce da Yeats, da Synge, da Joyce, da Lawrence, e in italiano porta infine anche L’americano di Henry James nel 1934. Cecchi, da Shelley, da Chesterton e, tralasciando le pagine non raccolte in volume, da Shakespeare; ma dall’America porta solo, nel 1936, la saggistica di Berenson, che lo riconduce all’amata arte italiana del Rinascimento.
Non mancò, a dire il vero, un proposito d’altra portata e che avrebbe potuto dare, se realizzato, altra storia alle traduzioni dall’americano; Cecchi aveva infatti accettato l’incarico di Mondadori di tradurre Sanctuary d...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- Con altra voce
- I. Gli stranieri in Italia
- II. La «Romantica»
- III. Il dibattito teorico
- IV. Nei territori della poesia
- V. Alla ricerca di un linguaggio
- VI. Una vicenda emblematica
- VII. Il caso di Montale
- Bibliografia