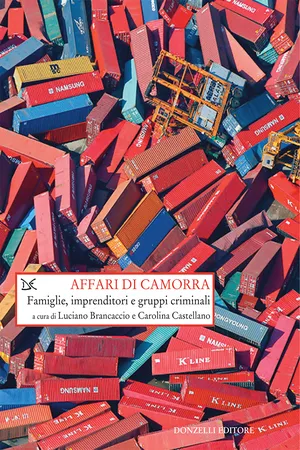![]() Parte prima
Parte prima
Genesi, mercati, espansione![]()
I. Mercati violenti e gruppi di camorra
di Luciano Brancaccio
1. Introduzione.
Il genere saggistico e letterario sulla camorra e sulle altre mafie ha riscosso negli ultimi dieci anni un notevole successo. Sono disponibili in catalogo molti titoli: dalle inchieste giornalistiche alla narrativa, fino alle analisi specialistiche più documentate. Il problema è che spesso, probabilmente proprio per farsi largo in una offerta ormai folta, integrata da una cospicua produzione mediatica (film, documentari, fiction), le rappresentazioni del fenomeno si risolvono in immagini troppo semplificate e in certi casi sensazionalistiche. Al centro di queste ricostruzioni in genere c’è il gruppo organizzato, dotato di leadership, ruoli direttivi, ranghi di affiliati, strategie di azione. Il rimando automatico è a una sorta di centri occulti che operano in direzione contraria alle istituzioni statali e della società civile. Il gruppo mafioso (clan, cosca, ’ndrina a seconda del tipo di mafia) incarna in qualche modo il «male», costituisce la negazione del patto civile che regge la vita associata; agisce, in altri termini, come un corpo «antisociale». Seguendo questa concezione, viene naturale pensare che questi gruppi abbiano confini netti, per quanto frequentemente permeati da rapporti collusivi con pezzi di politica, imprenditoria, pubblica amministrazione. Il concetto stesso di gruppo di criminalità organizzata, nella sua formulazione tradizionale di impianto criminologico, presuppone un tratto di alterità rispetto all’ambiente in cui vive e si riproduce; alterità tanto più convintamente sostenuta se l’ambiente in questione non sono le aree di insediamento tradizionale delle mafie, ma le ricche ed efficienti regioni del Nord Italia e dell’Europa1.
Questo discorso, implicito nelle argomentazioni correnti in tema di mafie, trascura un aspetto di grande importanza, relativo al radicamento sociale e ai processi generativi dei gruppi di criminalità organizzata. Puntando l’attenzione sulle strategie autonome e sull’azione corruttrice delle mafie in quanto corpi distinti, infatti, si dimentica di approfondire le modalità e le circostanze in cui tali gruppi prendono forma dal tessuto sociale ed economico dei territori. Si assume che le mafie siano il frutto di epoche lontane, e che le forme attuali siano pervenute ai nostri giorni per evoluzione storica dalle formazioni originarie, essendo a esse collegate concretamente da nessi di tipo organizzativo, in modo da collocarsi secondo una precisa linea ereditaria. In altre parole, ci si confronta con le mafie considerandole ricomprese entro una struttura sostanzialmente unitaria che agisce nel corso della storia. Per la camorra, in particolare, questa impostazione unilaterale mostra tutta la sua parzialità. Più di altre mafie, infatti, nella camorra gli aspetti di genesi sono altrettanto, se non più importanti di quelli di autoriproduzione. Soprattutto nel contesto urbano è possibile notare l’alta caducità di gruppi e la continua nascita di nuove formazioni, in molti casi non collegate alle precedenti. Certamente ci sono aspetti di continuità nel tempo, che sono principalmente assicurati dal permanere sulla scena di estese famiglie che presidiano alcuni mercati illegali. Ma i gruppi in senso stretto, intesi come clan con al comando un capo, una cassa comune, affiliati, gruppi di fuoco, hanno in genere vita relativamente breve. La condizione di instabilità dei gruppi comporta frequenti fasi di transizione degli equilibri camorristici, leadership più spesso messe in discussione (all’interno delle famiglie o degli stessi gruppi), forme organizzative più complesse e dipendenti da fattori esterni, confini meno netti – ma non un minore potere mafioso.
Da questo punto di vista, una storia della camorra non può che essere storia sociale della camorra, ovvero storia della genesi sociale dei gruppi di camorra. Ciò sposta l’attenzione sugli spazi sociali ed economici entro i quali emergono di volta in volta circuiti criminali e gruppi organizzati e sulle aree di illegalità (che sono anche aree di alimentazione) ad essi contigue2. I gruppi criminali campani del secondo dopoguerra si sviluppano principalmente all’interno di reti commerciali e attorno al ruolo chiave di alcuni mediatori violenti. In questo capitolo prenderemo in considerazione lo sviluppo storico di alcuni circuiti criminali a partire dal mercato della magliareria (prodotti tessili e di abbigliamento). Tratteremo di questo vasto mercato di carattere irregolare/illegale, esteso fin dalle sue origini ben oltre i confini nazionali, all’interno del quale prendono forma alcune configurazioni criminali, che solo in determinate circostanze storiche si consolidano in – o vengono sostituite da – gruppi organizzati più definiti.
2. Mercati e circuiti di autorità.
È noto che a Napoli le attività commerciali abbiano svolto storicamente un ruolo molto rilevante, e ciò non certo in ragione della posizione strategica della città nei circuiti di scambio internazionale. Piuttosto, l’ipertrofia del settore commerciale, e in special modo del commercio irregolare, può essere considerata una conseguenza della cronica deficienza degli altri settori economici. Già nel primo periodo postunitario è chiara la fragile natura dell’economia cittadina, schiacciata dalla concorrenza sui mercati mondiali (in quegli anni in via di consolidamento). I segni di questa debolezza sono molteplici: la carenza di capitale industriale, la dipendenza dalla spesa pubblica, la pressione demografica, la povertà estesa, lo stato fatiscente e incompiuto delle vie di trasporto con le altre aree della regione e del Mezzogiorno. Per questi fattori a Napoli, come del resto in tutte le città commerciali, ma in misura maggiore in ragione delle difficili condizioni sociali ed economiche, i ruoli di mediazione si riproducono in modo pervasivo.
Nei decenni successivi gli elementi di fragilità dell’economia permangono. L’affollamento dei mestieri legati alla vendita, in particolare nella piccola distribuzione e fornitura di servizi, è uno dei tratti tipici della città. La presenza di un porto di notevoli dimensioni assicura canali commerciali con altre regioni e nazioni, ma questi risultano monopolizzati da poche grandi società di import-export, cui fa da contraltare una moltitudine di trafficanti, in molti casi attivi al di fuori della regolamentazione doganale, in quelli che a seconda della normativa in vigore vengono definiti mercati irregolari o illegali. L’economia napoletana «si ramifica nel corpo sociale di un grande mercato di consumo urbano» (Frascani 1995, p. 228). Una netta sproporzione tra le esigue risorse economiche in circolazione e l’ampia disponibilità di forza lavoro conduce alla proliferazione di mestieri improvvisati e di figure che operano, in parte o del tutto, nell’illegalità. Queste attività sono sostanzialmente tollerate dagli organi di controllo e repressione dello Stato, la cui azione si adatta – per impossibilità oggettiva, per ragioni di urgenza sociale o per rapporti collusivi – a una situazione di fatto.
Le attività di mediazione si concentrano attorno alle poche opportunità di guadagno, che si presentano soprattutto nelle catene commerciali e nei tanti mestieri legati al mercato di consumo interno. Sensali, contrabbandieri, ambulanti, faccendieri, usurai, mediatori di ogni genere si ripropongono continuamente nei lavori storiografici sul tessuto economico della città tra Otto e Novecento. La presenza di mercati illegali e il ricorso alla sopraffazione nei mercati ordinari – non diversamente, peraltro, da altre grandi città, se non forse nelle proporzioni – forniscono opportunità di accumulazione per figure dotate di spirito di intraprendenza e spregiudicatezza. Nell’affollarsi delle transazioni economiche la regolazione violenta degli scambi economici e dei rapporti sociali diventa un principio d’ordine. Il ricorso o la minaccia della violenza consolida l’autorità economica di singoli e ditte. Una turbativa delle regole della concorrenza e insieme un fattore di equilibrio del sistema economico, il presupposto per la stabilità delle transazioni. In un contesto endemicamente povero e caratterizzato da basse prospettive di mobilità sociale, questi percorsi individuali, che si avvalgono sovente di leve extralegali, diventano particolarmente ricorrenti3.
È in questo intricato tessuto di transazioni economiche che tipicamente nascono e si affermano i gruppi criminali della città4. I clan di camorra costruiscono circuiti di autorità attraverso la violenza, producendo forme di regolazione e stabilizzazione dei rapporti economici. Questi circuiti si impongono con la forza, ma distribuiscono anche risorse. Talvolta danno vita a configurazioni di attori persistenti negli anni, più spesso a un affollato panorama di regolatori del mercato violenti e individualisti, tra loro in continua e irrisolta concorrenza. I capi, quando sono in grado di creare forme organizzative relativamente durature, rinforzano i vincoli associativi attraverso tratti identitari e «narrazioni» della realtà sociale. In alcuni casi riescono a costituire formazioni più stabili. Producono quindi simbologie, stili comportamentali, forme embrionali di ideologie sociali. Fidelizzano per questa via i componenti dei propri network e si pongono poi come soggetti espansivi, in grado di distinguere un «dentro», definito da un apparato organizzativo e da un insieme di affiliati, e un «fuori»5.
Si tratta in origine di circuiti economici marginali, ma che sono in grado fin da subito di stabilire collegamenti nelle alte sfere della stratificazione sociale, agganciandosi a interessi che non di rado condizionano i percorsi di sviluppo della città. D’altronde la cosa non può stupire: è la stessa funzione ordinatoria dei camorristi, dei guappi o dei semplici regolatori violenti che costituisce una sponda vantaggiosa per chi voglia, dall’alto, realizzare forme di controllo sociale o navigare nei servigi della città bassa. C’è ampia documentazione di come esponenti della politica, dell’impresa, delle professioni, della pubblica amministrazione, già nel primo periodo post-unitario, approfittino di questi punti fermi nei vasti e multiformi strati popolari della città6.
La questione della formazione dei gruppi di camorra e dei loro confini è materia delicata. Ci torneremo in conclusione, qui basti dire che la definizione organizzativa dei gruppi cittadini è assai problematica. La dimensione prevalentemente economica di queste reti comporta sempre una logica negoziale assieme a quella impositiva e dunque un’estrema fluidità di relazioni cui consegue un’incerta definizione dell’appartenenza a gruppi stabili7. A uno sguardo complessivo del panorama criminale della città, in primo piano si stagliano figure individuali di imprenditori violenti, collocate al centro di network familiari e sociali, mentre la dimensione del gruppo è più sfumata. Le gerarchie cambiano continuamente all’interno di vasti fronti parentali, emergono nuove leadership attorno alle quali vanno aggregandosi circuiti di scambio e distribuzione delle risorse. Lo status di boss di camorra, vale a dire il riconoscimento sociale di un’autorità extralegale, si raggiunge attraverso l’attitudine alla violenza, ma anche dentro una dimensione economica d’impresa.
Nel prosieguo di questo capitolo ci occuperemo del mercato dei magliari (il commercio ambulante di lunga distanza di merci varie, principalmente tessuti e capi d’abbigliamento) all’interno del quale, in modi e tempi diversi, hanno preso forma alcuni importanti gruppi camorristi.
3. La magliareria.
L’affollamento dei mestieri nel settore commerciale è dunque una delle caratteristiche specifiche della città. Non è un caso che l’elenco degli antichi mestieri napoletani comprenda in maggioranza ruoli legati alla vendita al dettaglio e ambulante. Le origini del mestiere di magliaro si situano in questo contesto. Probabilmente costituisce un’evoluzione, connessa al miglioramento dei trasporti e all’allargamento dei mercati, della figura dell’ambulante. Nella necessità di trovare nuovi mercati, i venditori napoletani cominciano a spostarsi in altre regioni. Per quanto è possibile saperne la figura del magliaro è presente già alla fine dell’Ottocento, ma vive un vero e proprio boom nel secondo dopoguerra8. Non ha una collocazione specifica in un campo merceologico, piuttosto è un’attività di vendita ambulante che di volta in volta può interessare beni diversi: in origine soprattutto tessuti, biancheria e capi d’abbigliamento, poi nel corso del secondo dopoguerra si aggiungono posateria, stoviglie, orologi, bracciali e altri ornamenti per la persona. I magliari sono venditori esperti, dotati di savoir-faire e destrezza, capaci di piazzare la merce con grande abilità, spesso, ma non necessariamente, oltre i limiti del raggiro. Raggiungono i mercati lontani del Centro e Nord Europa (Scandinavia, Regno Unito, Danimarca, Germania), contesti non toccati dall’inflazione dell’offerta taroccata, dove possono giocare il ruolo di rifugiati politici (durante il fascismo) o di lavoratori migranti con famiglia a carico, elementi che dispongono benevolmente il cliente all’acquisto.
L’affinamento delle abilità legate alla vendita di beni è una delle conseguenze dell’ipertrofia del settore commerciale della città. Le scarse risorse dell’economia e il sovraffollamento dell’offerta di lavoro impongono una dura selezione. Nel corso degli anni settanta, con la nascita delle griffe e della moda giovanile, i magliari si specializzano nella vendita del falso (particolarmente diffuso nel settore dei capi in pelle). La saturazione del mercato cittadino porta i magliari ad allargare la propria rete di vendita, a moltiplicare gli spostamenti in Italia e all’estero, a differenziare la merce: non più solo prodotti tessili e dell’abbigliamento, ma anche, a partire dagli anni ottanta e novanta, utensileria, apparecchi elettrici ed elettronici contraffatti (Tribunale di Napoli 2004).
Nella prima metà del Novecento sono già sparsi su una vasta area, in Europa e oltre Atlantico. Napoli diventa il baricentro di lunghe rotte commerciali percorse dai venditori ambulanti. La merce viene prodotta in laboratori napoletani o acquistata in diverse zone d’Italia e rivenduta all’estero, ma non mancano acquisti e vendite estero su estero. I magliari si spostano in treno, con mezzi di fortuna oppure, a partire dagli anni cinquanta, in auto. Vendono porta a porta oppure si appostano agli incroci delle strade più affollate e nei parcheggi dei grandi magazzini, dove cercano di attirare i clienti promuovendo la merce stipata nei bagagliai. Napoli, comunque, resta un punto di riferimento imprescindibile, la sede logistica dei traffici. Nella città di origine i magliari in genere mantengono la famiglia, tornano periodicamente o durante le feste per ricongiungersi ai propri cari, per rifornirsi di merce, ripagare i fornitori e organizzare nuove spedizioni. Sfruttano il miglioramento della rete di trasporto per raggiungere mercati sempre più lontani. Mercati aperti, assecondati da istituzioni statali liberali, ma anche mercati fortemente controllati, all’interno di confini segnati da re...