
- 272 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La giovane narrativa italiana
Informazioni su questo libro
È tra la fine degli anni settanta, primi ottanta che in Italia, grazie ai brillanti esordi letterari dei vari Palandri, Tondelli, De Carlo, si inizia a parlare del cosiddetto fenomeno della «giovane narrativa». Ripudiati alcuni categorici postulati della neoavanguardia, voltate le spalle al totalizzante impegno politico e ai valori collettivistici dei successivi movimenti studenteschi, questa nouvelle vague di autori – che presto si arricchirà di ulteriori interessanti personalità – si caratterizza al contrario per un gioioso ritorno a raccontare, costruire intrecci, trame; per un recupero di storie private, intimiste; per la creazione di testi multimediali, ovvero carichi di suggestioni mutuate non più solo dalla letteratura ma anche e soprattutto da universi paralleli come cinema, musica, teatro, fumetto, internet, tv. Si restringe, fino quasi ad annullarsi, la forbice tra una presunta arte colta, nobile, e una bassa, popolare. Sulla scia delle assimilate teorie postmoderne si impongono così opere «meticciate», comprensibili appieno solo da chi con disinvoltura si muove entro tali variegati ambiti. Ed è proprio a questo ricco, intrigante panorama culturale di fine millennio (incluso il tanto discusso filone «pulp») che il libro guarda con attenzione, soffermandosi in particolare su tredici significative opere di narrativa date alle stampe tra il 1979 e il 1996.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La giovane narrativa italiana di Maurizio Pistelli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Critica letteraria. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
LetteraturaCategoria
Critica letterariaVII. Tutti a scuola da Tondelli: i casi di Brizzi, Culicchia, Demarchi, Romagnoli
L’inequivocabile, ennesima conferma di come Tondelli abbia lasciato una profonda impronta di sé nella letteratura italiana di fine millennio arriva da un manipolo di scrittori, i quali, dopo aver esordito (a eccezione di Brizzi) nelle antologie under 25 dell’intellettuale emiliano, debuttano in proprio nel decennio 1990-2000, imponendosi di lì a poco come autori cult di un’intera generazione, che infatti si rispecchia nei loro testi pervasi di sentimenti altalenanti tra frustrazione, rabbia, disincanto, speranza. Ciò vale in particolare per scrittori come Culicchia, Brizzi, Demarchi, Ballestra che anche a livello di scelte formali privilegiano un linguaggio colorito, graffiante, multimediale in grado, come vedremo, di richiamarsi costantemente a modi ed espressioni tipici del parlato giovanile, ma nella sua ricchezza e vivacità capace di dimostrare altresì la loro precoce e sorprendente maturità artistica.
Quattro anni dopo la pubblicazione di alcuni racconti nell’antologia tondelliana Papergang, Culicchia dà alle stampe nel 1994, per i tipi della Garzanti (in precedenza rifiutato da Einaudi, Rizzoli e Feltrinelli), il suo primo romanzo dal titolo Tutti giù per terra, vincitore dei premi Grinzane Cavour per esordienti e Montblanc; libro, che come quello coevo di Brizzi, risulta incentrato su esperienze e difficoltà legate al mondo dei ragazzi d’oggi e che, sempre come il testo dell’autore bolognese, avrà poi una versione cinematografica (affidata in questo caso alla regia di Davide Ferrario).
Protagonista della storia narrata dall’allora ventottenne Culicchia è Walter, più giovane di qualche anno rispetto al suo creatore, un ragazzo maldestro e disadattato che vive in una sorta di penoso impasse esistenziale, preoccupato dalla prospettiva di doversi un giorno assoggettare alle regole di una società detestata, di cui rifiuta stupide mode e consumistici feticci. Il nostro personaggio non riesce in effetti a immaginare per sé nessun futuro appagante; anzi già si vede, con terrore, rinchiuso di lì a poco in un alienante lavoro, intrappolato in una mortificante logica piccolo-borghese.
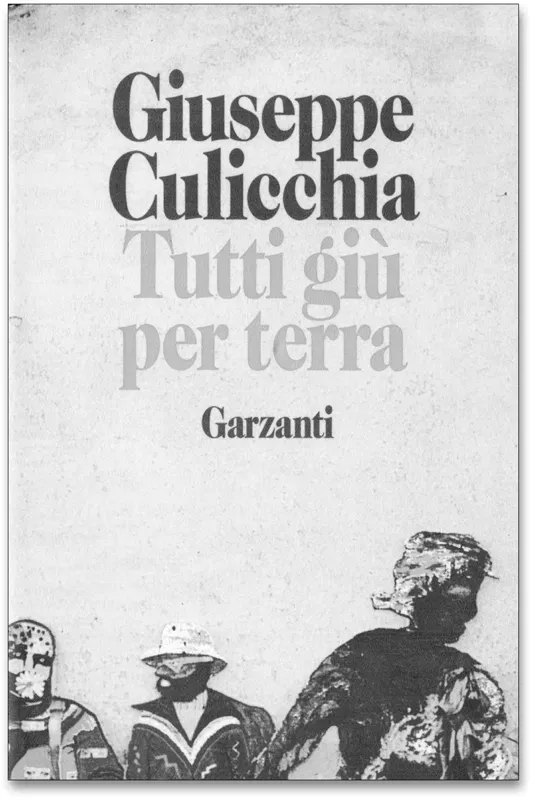
G. Culicchia, Tutti giù per terra, Garzanti, Milano 1994.
Ma andiamolo a conoscere ancor più da vicino questo ventiduenne torinese che fin dall’incipit del romanzo rivela, senza infingimento alcuno, la propria apatica natura. A un mondo insulso che da un momento all’altro gli sembra «sul punto di cascare» egli, ultimo discendente di una stirpe di meditabondi flâneur letterari, riesce infatti a opporre solo il suo ossessivo girovagare «senza meta» tra le vie della città, «chilometro dopo chilometro», ritrovandosi sempre più smarrito «senza un filo a cui aggrappar[si]. Senza più nulla da vedere»1. Pur avvertendo disagio e malessere, pur essendo consapevole del degrado morale che c’è intorno a sé, egli non trova né il coraggio né la forza per reagire, limitandosi a enunciare (sul celebre modello montaliano) unicamente ciò che non desidera e vuole:
Non volevo un lavoro da commesso. Non volevo fare carriera. Non volevo rinchiudermi in una gabbia2.
L’insoddisfazione di Walter (sarebbe una forzatura parlare di vera rivolta) non sfocia mai in nulla di concreto e soprattutto di alternativo, anche se il suo sguardo critico, seppure a volte tragicomico, continua a mostrarci una realtà dai contorni opachi e disgustosi, nella quale non a caso egli si sente costantemente «fuori posto»3.
Terminati gli studi superiori e preso il diploma di geometra, il nostro protagonista dovrebbe essere pronto a entrare in una nuova fase della propria esistenza, caratterizzata da più grandi responsabilità. Ma tale sfida (crescere, passare dall’età della spensieratezza giovanile a quella della ponderata maturità) è vista ora come un impoverimento, un processo penalizzante di resa, di passivo adeguamento alle regole del vivere sociale. È come se, persa la speranza di rivoluzionarlo, il mondo degli adulti si trasformasse da meta agognata a infida gabbia, dalla quale l’individuo vede morire a poco a poco tutte le sue più autentiche aspirazioni. Eccola la paura che attanaglia Walter, deciso comunque a non farsi stritolare dagli infernali meccanismi dell’omologazione, determinato a non barattare la propria libertà con un ripugnante lavoro da servo.
[Temevo che] sarei finito dritto sparato in quel cesso chiamato mondo del lavoro. Prima o dopo avrei venduto me stesso per uno stipendio mensile appena sufficiente a sopravvivere e pagare le rate della macchina, della lavastoviglie, del videoregistratore. Altro che carriera da carrozziere a mago della borsa. Sarei stato stritolato da un meccanismo omicida. Tre settimane di ferie all’anno. Otto ore di lavoro al giorno. Fine settimana libero, certo, giusto per guardare la televisione o andare alla partita. Non avrei più potuto disporre del mio tempo ma renderne conto a qualcun altro, spendendo quel poco che guadagnavo per comprare cose inutili prodotte da schiavi come me. Il cerchio sarebbe quadrato. Avrei lavorato sino alla vecchiaia e il giorno della pensione mi sarei accorto di essere malato di cancro. Ero proprio depresso4.
Questa netta avversione nei confronti del lavoro5, che si lega al timore dell’incombente età adulta, l’io narrante di Culicchia la condivide a veder bene con tanti altri personaggi letterari di quegli anni: dal Rocco di Porci con le ali
a volte mi sento terribilmente e disgustosamente cresciuto6
al Giovanni di Lunario del paradiso
Vedere uno che lavora e basta mi fa venire la malinconia tripla; e i miei sgobbavano, sgobbavano sodo, non hanno mai fatto altro7
dall’Enrico di Boccalone
Non mi lascio prendere! Piuttosto fuggo tutta la vita, ma non lascio che mi rinchiudano in un lavoro, con una moglie e dei figli8
fino allo stesso protagonista del romanzo d’esordio di Demarchi.
Vedo i miei amici, i miei ex compagni di liceo e adesso anche di università, molti di loro si sono sposati, han già dei figli, un lavoro, «una posizione» – termine che a me ha sempre fatto morire dal ridere perché ricorda qualcosa di molto porno, non trovi? Adesso saranno già nel loro bell’hotel a quattro stelle prenotato in febbraio con la piscina e l’aria buona e il golfino alle sei perché appena va giù il sole vien su il fresco, e mica l’hanno rinnegati gli anni della Torino-Stoccolma in autostop, loro o il campeggio libero ad Avignone per il festival, no, per carità, solo che adesso con il bambino come si fa, e poi comunque sì, è stato bello quel periodo, ci siamo emozionati, ce la siamo spassata ma ora basta, siamo diventati adulti, responsabili, abbiamo messo la testa a posto… E qui sta il punto. Cruciale. Perché, vedi, la mia testa è volata via da un pezzo, e ogni volta che cerco di riafferrarla lei scappa da tutte le parti e non vuol saperne di tornarsene a casa sul collo. […] A ventisei anni sono ancora qui a recitare la parte dell’attore girovago che insegue disperatamente il suo sogno9.
Insofferente al clima di conflittualità e noia che respira in famiglia, stanco del ripetersi di rituali, dietro i quali si nascondono meschinità e ipocrisia, il nostro giovane è costretto a prendere atto sempre più della propria solitudine e diversità. Gli stessi rapporti con i genitori sono ridotti a zero. Ci si sopporta a malapena e il rientrare a casa significa quasi sempre andare incontro a un feroce litigio, soprattutto con il padre, detentore di una rigida visione della vita, incentrata sugli abbaglianti miti della carriera e del denaro. Ma lasciamo che sia l’esasperato Walter a raccontarci, tra il serio e il faceto, uno dei tanti insopportabili alterchi, a cui fa da muta spettatrice la madre, frustrata e intenta solo a cucinare, mentre dalla televisione accesa arriva costantemente l’eco di demenziali spettacoli a quiz (proprio come già accaduto in La sconfitta del 1973, primo cortometraggio di Nanni Moretti).
Con mio padre litigavo ogni sera «non hai voglia di fare un cazzo, tu», sbraitava, insieme a TeleMike che dalla televisione dispensava milioni auto e pellicce a tutto volume. […] «Alla tua età la gente pensa a fare carriera e tu non fai altro che leggere». «Credo che i libri siano più importanti dei soldi». «Già, più importanti. La parola carriera a tuo figlio non piace, non è vero moglie?». Mia madre non diceva nulla. A me in realtà la parola carriera spaventava. Sapevo di essere figlio di operai e di dovermi dare da fare, ma non mi interessava fare carriera, stritolato sotto vuoto spinto da un meccanismo costruito su misura fuori misura per me. Non era la fatica a spaventarmi. Avevo paura di scaraventarmi da solo in una prigione per poi gettarne le chiavi con le mie stesse mani, come accadeva nei sogni. Mio padre invece era ossessionato dalla parola carriera. Non poteva permettersi di mandarmi alla Bocconi ma sperava almeno di vedermi diventare uno di quei capireparto che alla Fiat lo avevano frustrato per tutta l’esistenza. Nel frattempo litigavamo ogni sera davanti a TeleMike10.
È davanti al totem catodico, dispensatore di sogni e modelli comportamentali (lo confermerà più avanti Nove) che si consuma dunque lo scontro generazionale tra genitori e figli, tra esigenze e priorità contrapposte, tra due mondi inconciliabili, nei quali l’incomunicabilità regna inevitabilmente sovrana; ciascuno parla un linguaggio incomprensibile per l’altro, ognuno rimane fedele alle proprie granitiche convinzioni, anzi irridendo in modo sfacciato quelle altrui.
Evitare di diventare un giorno come i padri, distinguersi da loro, questo sembrerebbe in maniera significativa il primo obiettivo dei nostri giovani personaggi di carta, che ripetutamente esternano il loro rancore verso l’insopportabile capofamiglia. Ed anche in questo caso Walter si ritrova in buona e numerosa compagnia, ancora una volta insieme ad esempio al Rocco del duo Ravera-Radice,
Peggio di una riunione c’è solo tornare a casa […] mi sta sul cazzo da quando apre la porta con quella pancia da imbecille soddisfatto […]. La conversazione a pranzo ha seguito gli schemi tradizionali […] avverto immediatamente un frenetico prurito all’ano, mentre la fettina mi si ferma in gola all’istante. Vorrei tagliarmi la lingua per averlo provocato, sento che oggi sarà particolarmente insopportabile […] non discute mai con me, in realtà. Discute da solo, una specie di teatrino schizofrenico, in cui lui dice una cosa, poi si immagina la risposta, poi risponde alla risposta che si è immaginato, e così via […] mi fa passare l’appetito, mi fa venire la colite. Rinuncio, mi arrendo, taccio, mugolo, borbotto11.
all’Alex di Brizzi
«Io faccio un salto da Feltrinelli». […] «È chiusa la Feltrinelli», considerò il Cancelliere [il padre] da dentro la poltrona. «Non devo andare in libreria» disse lui. «C’ho solo un appuntamento davanti». «Come sarebbe?» fece la mutter, senza distogliere gli occhi dalle Bologna’s Chronicles. «Sei appena rientrato e già riesci?» «Te l’ho detto, ho un appuntamento». «Con chi, un appuntamento». «Con una mia compagna, mutter». «Una compagna. Sarebbe a dire?» «Non la conosci. Cosa ti cambia se ti dico un nome? Non la conosci comunque». «Come si chiama», insistette lei. «Hai studiato abbastanza per domani?» gli disse. Autocontrollo. Prova della volontà, prova della volontà «Sì, ho studiato. Al massimo stasera ripasso. Si chiama Adelaide, va bene?» «Adelaide. E a che ora torneresti?» Prova della volontà, prova della volontà. «Rientro per cena, d’accordo?» «Cancelliere, ma lo sentite? Il principino vuol rientrare per cena… Ascolta, pensi di vivere in un albergo, è così? […] Tu credi che siamo tutti dei cretinetti, non è vero? Pensi di poter spadroneggiare», disse la mutter. Va bene. «Comunque esci pure». Va bene. «Ma il punto ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- Introduzione
- I. Nomi, date, numeri di un emergente fenomeno culturale
- II. Sul perché del ritorno al piacere di narrare
- III. Cinema, musica, fumetto: un imprescindibile serbatoio culturale dal quale ormai attingere senza più pregiudizi
- IV. Iniziative editoriali a favore della giovane narrativa
- V. Palandri, Tondelli, De Carlo: i padri di una nuova generazione di scrittori
- VI. La «scuola romana» e alcuni suoi protagonisti: Albinati, Lodoli, Veronesi
- VII. Tutti a scuola da Tondelli: i casi di Brizzi, Culicchia, Demarchi, Romagnoli
- VIII. Il pulp italiano: Ammaniti, Scarpa, Nove
- Riferimenti bibliografici