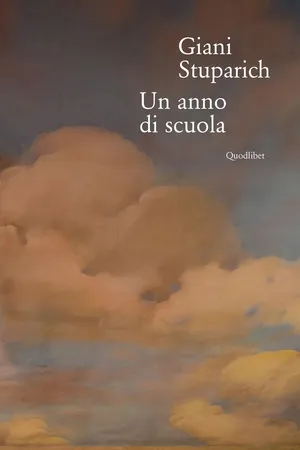Nell’atrio deserto, dall’alto attraverso la vetrata del tetto, pioveva la luce di una mattina calda e sonora di settembre. Di fuori garrivano ancora, come bandiere di festa, le vacanze coi giochi e coi bagni. Dal secondo loggiato provenivano di tanto in tanto squilli di voci ridenti che, ripercotendosi sulle colonne, empivano l’atrio di fragore.
S’era radunato lassù un gruppetto di studenti. Costoro, giovani d’altri tempi, conoscevano da sette anni quell’atrio e vi si muovevano con molta domestichezza; ma i loro atti non erano senza il freno d’un vago senso di rispetto e di timore. Se qualcuno accalorato alzava la voce, subito gli altri si guardavano intorno dubitanti ed egli stesso ne sembrava spaventato. Volgevano a intervalli la loro attenzione verso un uscio, sopra il quale un bianco tondino laccato avvertiva con cifre nere che quella era l’aula della «ottava ginnasio». Vi sarebbero entrati fra pochi giorni e questo pensiero li turbava e li inorgogliva. Ma non per veder la porta della loro classe s’erano dato convegno lassù quella mattina, ancora in piene vacanze, sacrificando uno splendido bagno. La loro curiosità era stata attirata da ben altra cosa. Di là da quell’uscio Edda Marty lottava col tema di latino. Edda Marty era coraggiosa; era la prima donna che tentava la conquista d’un posto in quel ginnasio maschile. Dare l’esame in otto materie, rispondere per cinque anni di greco e sette di latino, non era uno scherzo.
Sarebbe passata? Sarebbe stata loro compagna di classe? Quei giovani avevan sentito dire cose mirabili della sua intelligenza; ma di loro soltanto uno la conosceva un po’ meglio, gli altri l’avevano vista, la prima volta quella mattina, passare per il corridoio accompagnata da due professori, ed entrare in quell’aula. Nessuno sapeva spiegarsi bene che cosa avesse visto: due grandi occhi che ridevano e salutavano e che avevano acceso un po’ il sangue a tutti.
Marzi, un perticone che pronunciava le «r» come fossero «l», colui che diceva di conoscerla bene, ma non si lasciava scappare né come né dove l’avesse conosciuta, era il centro degli assalti di tutti. Chi voleva sapere quanti anni avesse, chi s’informava di che famiglia provenisse, quale scuola avesse frequentato, con chi si fosse preparata; altri piú audaci volevano farsi fare il ritratto fisico e quello morale, e Mitis con gli occhi maligni nella faccia fosca e la bocca cinica chiedeva se la conoscesse davvero «intus et in cute». Al che Marzi arrossiva di rabbia e ammutoliva e gli altri sbottavano a ridere e zittivano e si piegavano in due dalle risa compresse.
Poco prima di mezzogiorno Edda Marty uscì dall’aula. Aveva il viso un po’ congestionato e teneva in mano il cappellino di paglia ornato ai lati da due mazzetti di ciliege. Fu attorniata. Marzi, sorpreso, cercava d’incunearsi per far le presentazioni in regola, ma nessuno gli dava retta.
– Com’è andata?
– Era difficile?
– Che cos’era?
E lei, girando gli occhi su l’uno e sull’altro, rispondeva disinvolta, accompagnando con dei colpettini di testa le parole che le uscivano dritte e un po’ fischianti dai denti. Infine piantò tutti con un «Addio, devo andare» e corse giù per le scale; e Marzi dietro, e gli altri si guardarono.
– Bel tipo, – affermò Neranz, tutto rosso in viso.
– Ci dà già del «tu», – osservò non senza meraviglia Vitelli.
– Oh bella, vuoi che ci dia del «voi», – ribatté ironicamente Pasini.
– Insomma, – sentenziò Mitis che s’era fatto serio e storceva anche più cinicamente la bocca, – io dico che se quella monella viene in classe nostra, ci rovina tutti.
A sentir la Marty, tutto le andava male; voleva ritirarsi dopo ogni esame. Invece passò benissimo. «Ha sempre presagito il disastro, – malignava Mitis, – per ottenere in fine un successo strepitoso».
In realtà la Marty era pessimista, come tutte le intelligenze temerarie. Nella vita faceva lo stesso: si buttava audacemente nelle difficoltà, ma non era mai sicura di poterne uscire.
A quindici anni era scappata a Vienna, per correr dalla sorella che studiava all’università, sorella tanto più grande e più fortunata di lei. Perché non esser nata, come Hedwig, otto anni prima? Perché non vivere anche lei in una vera città come Vienna, dove le donne possono fumare, andare al caffè, rincasare la sera tardi, trattare alla pari coi maschi e discutere con loro? Ricordava sempre i primi anni passati a Vienna – quanti ne aveva allora lei? poco più di sette – quando dalla finestra di casa vedeva tornar dalla scuola Hedwig in compagnia chiassosa di studenti, e qualche volta, davanti al portone, la vedeva abbaruffarsi coi maschi e strappar loro i berretti; e quando le strappavano il suo, com’era bella allora coi capelli corti svolazzanti e con la faccia tutta riscaldata dalla lotta! Ella aveva aspettato con impazienza che passassero gli anni per poter fare lo stesso. Ma invece ecco precipitar la sua sorte, ecco la triste decisione dei suoi genitori. L’avevano portata a Trieste con loro: grande porto di commercio, dicevano; ma in realtà una piccola città di provincia. E qui fu tutt’un’altra vita. Le sue compagne di scuola elementare la guardavano come una bestia rara; eran timide, tutta la loro audacia consisteva nel malignare a bassa voce; si stringevano nelle loro gonnellucce quando lei proponeva qualche tiro birbone alle maestre o un pericoloso ma emozionante sconfinamento nell’ala maschile dello stesso edificio. La lingua la imparò presto. Dopo due anni parlava come un’indigena. Le piaceva anzi la lingua degli italiani, e persino a casa preferiva parlar italiano, col babbo che lo masticava alla meno peggio. Ma più ancora le piaceva il mare: passeggiate lungo le sue rive ogni giorno, gite in barca e bagni, bagni in tutte le stagioni. Ma anche qui ai bagni aveva sperimentato tutto il gretto provincialismo dei cittadini. No, ai costumi casalinghi e borghesi degli abitanti non si sarebbe potuta abituare mai.
La misero poi in un liceo femminile. Non ci si poteva vedere. Più cresceva e più sentiva che non era fatta per quella vita. Quando incontrava qualche ragazzo della sua età, lo invidiava, si sentiva presa da una smania di mettersi anche lei i calzoni e di tagliarsi i capelli. Almeno egli poteva girar da solo per le strade, mettersi a correre se gli piaceva, saltar sui colonnini dei moli e fare al bagno la ginnastica più pazza e i tuffi più agili e vigorosi che sapesse. E di questa mancanza di libertà, di questo soffocamento del suo estro vitale si doleva piangente e disperata con la sorella, quando questa veniva per le vacanze a passare una settimana in famiglia. Hedwig l’accarezzava, Hedwig la lasciava sfogare, la confortava: «Quando sarai grande sarai padrona di te», le diceva e le dava libri da leggere, che divorava la notte. Sì, se non fosse stata ogni tanto questa sorella…
Ma la sorella un anno non venne e allora Edda, non potendone più, scappò un bel giorno a Vienna. Trovò Hedwig nella sua stanza dentro una nuvola di fumo, e coi piedi intrecciati ai piedi d’un signore che, fumando come lei, stava come lei sprofondato nell’altro angolo del canapè; aveva il cranio lucido pelato e una faccia più lucida ancora, con due occhi penetranti dietro due tonde lenti. Restò perplessa sull’uscio e quell’uomo le fu subito molto antipatico; gli avrebbe scaraventato addosso la valigetta, se non fossero state quelle sue scarpe giallouovo, intrecciate con le scarpette nere appuntite di Hedwig, a metterle tanta soggezione. Hedwig, senza muoversi, mostrò la sua meraviglia, ebbe un lampo di disappunto nello sguardo, ma fu un attimo. – Vien qua, mia piccola, mia giuggiola, – la chiamò con la sua voce carezzevole e col suo bel sorriso disinvolto, – oh che bella sorpresa, come stai? – E Edda, dimenticando quell’intruso, corse nelle braccia della sorella, e pianse e rise e si sfogò.
– Ti presento il mio amico dottor Wieselberg, – fu la risposta di Hedwig.
Vada il fumo, vada l’amico dottor Wieselberg, ma quelle quattro scarpe incrociate non andavano bene a Edda, che da quella visita a Vienna ebbe più disillusioni che piacere.
Contuttociò la sua volontà di liberarsi dall’ambiente gretto delle femmine, come lo chiamava lei, era rimasta ben ferma. E prima di tutto decise di prepararsi in due anni per l’esame d’ammissione all’ottava classe del ginnasio maschile, che le apriva la strada dell’Università. La legge era recente; tutte le altre sue compagne temevano; lei avrebbe dato l’esame. E la sua volontà vinse.
I primi giorni la classe fu come uno strumento a cui avessero messo una corda di troppo: prova e riprova non s’accordava mai. Negli anni passati quei venti giovani che si conoscevano come le formiche, al tasto, riprendevano con molta facilità la vita scolastica; in poche ore si richiudeva d’incanto la parentesi delle vacanze; si rifacevano i gruppetti dei simpatizzanti e le cricche dei fannulloni; già il primo, o al più tardi il secondo giorno, un coro generale risaldava la colleganza e al professore, accorso al baccano, non restava altra consolazione se non una sfuriata platonica a una classe mimicamente ricomposta in un religioso silenzio. S’allontanava il professore; dopo un multiplo incrocio d’occhiate d’intelligenza, il coro riprincipiava. Ricomparsa del professore adirato, sbatacchiamento dell’uscio, e la lezione, per castigo, cominciava qualche minuto prima del campanello. Quasi ogni anno la stessa storia: era la battuta d’attacco, e dopo, ritrovato il tono, o bene o male l’orchestra filava per conto suo.
Ma quell’anno non fu così. Niente coro. Tutti si sentivano stonati. Ognuno penava a riconoscere nell’altro l’antico compagno. C’era in tutti una grande volontà d’indifferenza e di disinvoltura, ma nei fatti l’imbarazzo era evidente. L’unica persona veramente disinvolta là dentro era la nuova venuta. Edda Marty parlava vivacemente con tutti, si muoveva fra i suoi nuovi compagni come se li avesse conosciuti da anni, e li trasformava. Saletti da muto e solitario ch’era stato fino allora, si fece conversatore audace, sempre tra i più esposti nel circolo intorno a lei; Turez invece, che dal suo banco di fondo era solito lanciare dei frizzi che sollevavano le risa della classe intera, se ne stava ora quasi sempre con un grugno malinconico e duro. A Mitis la venuta della Marty aveva acceso un inesauribile fuoco d’artificio nel cervello, egli non era mai stato tanto vario e colorito nell’inventar barzellette, paradossi, doppisensi, come ora, e ne trovava di taglienti e fini alle volte, ma altre volte grossolani e sboccati sino alla trivialità. La Marty non solo non sembrava offendersene, ma lo ascoltava sorridendo con aria superiore. E intorno facevano canea, aizzando e sghignazzando, tutti i cialtroni e i corrotti, per i quali quella «donna» capitata là in mezzo era come un insperato lievito alla loro precoce depravazione.
Antero s’era staccato da Mitis e da Pasini appunto per questo. Erano stati sempre sin dai primi anni in domestichezza fra di loro, che, sviluppandosi essi in età, era diventata amicizia. Stavano bene insieme: l’aristocratico riserbo di Antero si fondeva con la rude e plebea franchezza di Mitis e con la generosità loquace di Pasini.
Tutti e tre erano giovani che non limitavano la loro vita intellettuale dentro la scuola. Si ritrovavano fuori di scuola in lunghe e libere discussioni letterarie. S’erano divisi i tre poeti dell’epoca: Mitis era un infocato carducciano, Antero, appassionato del Leopardi, era pascoliano, e Pasini poneva D’Annunzio sopra gli altri due. Quando gli animi si accendevano troppo e le parole cominciavano a frustare, allora Mitis si metteva improvvisamente a recitare Saluto italico; i versi fischiavano dalle sue labbra grosse, fra i denti radi, come lanciati fuori da una rabbiosa passione; e questa era tutta una fiamma rossa nei suoi piccoli occhi. Antero e Pasini tacevano fremendo, e quando era finito scattavano: «Sì, magnifico!» Perché più in alto di ogni criterio estetico stava per loro il sentimento della patria; la rivendicazione di Trieste all’Italia era lo scopo delle loro vite. Essi organizzavano le manifestazioni irredentistiche in classe, scrivevano un giornaletto di cui ogni parola era una promessa di vincere per l’Italia, e dove anche la retorica patriottica aveva una sua spontaneità.
Ma Edda Marty venne d’un tratto a porsi fra i tre amici. Antero al suo contatto s’affinò, la compagnia chiassosa e volgare gli divenne insopportabile. Per Mitis invece fu il contrario; scettico com’era, pensava che la donna andasse trattata coi modi più realistici e triviali. Pasini non si ritirò; non li usava lui quei modi triviali, ma ci rideva con la sua bocca grande e coi suoi begli occhi nerissimi, e in fondo approvava Mitis.
Ad Antero dispiaceva d’aver rotto coi compagni ogni rapporto di cordialità, ma preferiva star solo e appartato. E mentre tutti davano del «tu» alla Marty, egli continuava a darle del «lei».
La prima volta che A...