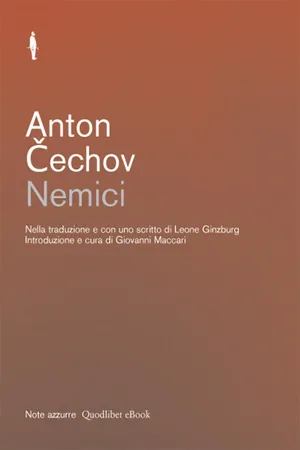![]()
![]()
Dopo le nove, in una buia serata di settembre, al medico condotto Kirilov era morto di difterite il suo unico figlio Andrej, di sei anni. Quando la moglie del dottore s’inginocchiò davanti al lettino del bimbo morto e le prese il primo accesso di disperazione, nell’anticamera risuonò bruscamente una scampanellata.
Per via della difterite tutta la servitù era stata mandata via di casa, fin dal mattino. Kirilov, così com’era, senza giubba, col panciotto sbottonato, senza asciugarsi il viso bagnato e le mani bruciate dall’acido fenico, andò lui ad aprire la porta. Nell’anticamera era buio, e dell’uomo ch’era entrato non si poteva distinguere altro che la sua statura media, una sciarpa bianca e una gran faccia straordinariamente pallida, tanto pallida che, con l’apparire di questa faccia, in anticamera sembrava facesse più chiaro…
– C’è il dottore? – domandò rapidamente colui che era entrato.
– Sono in casa, – rispose Kirilov. – Che cosa desiderate?
– Ah, siete voi? Molto lieto! – fece, rallegrandosi, colui era entrato, e nell’oscurità si mise a cercare la mano del dottore, la trovò e la strinse fortemente fra le sue. – Molto... molto lieto! Noi ci conosciamo!... Io sono Abogin… Ho avuto il piacere di vedervi quest’estate da Gnučev. Sono molto lieto di avervi trovato… Per l’amor di Dio, non rifiutatevi di venir subito con me… Mi s’è ammalata gravemente mia moglie… Ho anche la carrozza qui con me…
Dalla voce e dai movimenti di colui che era entrato ci si accorgeva ch’egli era in uno stato di forte eccitazione. Come se l’avesse spaventato un incendio o un cane arrabbiato, tratteneva a fatica il respiro frequente e parlava in fretta, con un tremito nella voce, e qualcosa d’inconfondibilmente sincero, d’infantilmente timoroso risonava nel suo discorso. Come tutte le persone spaventate e stupefatte, parlava a frasi brevi e rotte, e diceva molte parole superflue, che non c’entravano per niente.
– Temevo di non trovarvi, – egli seguitò. – Mentre la carrozza mi portava da voi, ho sofferto molto dentro di me… Vestitevi e andiamo, in nome di Dio… La cosa è avvenuta così. Viene da me Papčinskij, Aleksandr Semenovič, che voi conoscete… Abbiamo chiacchierato un po’… poi ci siamo messi a bere il tè; a un tratto mia moglie dà un grido, si porta le mani al cuore e cade sulla spalliera della sedia. L’abbiamo portata sul letto e… le ho stropicciato le tempie con l’ammoniaca e le ho spruzzato addosso dell’acqua… lei stava lì come una morta… Ho paura che sia un aneurisma… Andiamo… Anche suo padre è morto di aneurisma…
Kirilov ascoltava e taceva, come se non capisse il russo.
Quando Albogin ebbe ricordato ancora una volta Papčinskij e il padre di sua moglie e si fu messo ancora una volta a cercare la sua mano nell’oscurità, il dottore scosse il capo e disse, strascicando apaticamente ogni parola:
– Perdonatemi, non posso venire… Cinque minuti fa mi è… morto mio figlio…
– Possibile? – sussurrò Albogin, facendo un passo indietro. – Dio mio, in che brutto momento son capitato! È una giornata straordinariamente disgraziata… straordinariamente! Che coincidenza… e come a farlo apposta!
Abogin afferrò la maniglia della porta e chinò il capo, pensieroso. Evidentemente esitava e non sapeva cosa fare: se doveva andarsene o seguitare a pregare il dottore.
– Ascoltate, – egli disse con calore, prendendo Kirilov per una manica. – Capisco benissimo la vostra condizione! Dio mi è testimone che mi vergogno di cercare, in un momento come questo, di attirare la vostra attenzione; ma che cosa posso fare? Ditelo voi, da chi potrei andare? Perché qui, all’infuori di voi, non c’è nessun altro dottore. Andiamo, in nome di Dio! Non è per me che lo chiedo… Non sono malato, io!
Sopravvenne un silenzio. Kirilov voltò le spalle ad Abogin, stette un po’ fermo e passò lentamente dall’anticamera in salotto. A giudicare dal suo passo malsicuro e macchinale, dall’attenzione con cui in salotto accomodò il paralume peloso sopra una lampada, che non era accesa, e diede un’occhiata in un grosso libro che stava sulla tavola, in quel momento egli non aveva né intenzione, né desideri, non pensava a nulla e, probabilmente, non ricordava più di avere nell’anticamera una persona estranea. La luce crepuscolare e il silenzio del salotto avevano evidentemente accresciuto il suo stordimento. Andando dal salotto nel suo studio, sollevava la gamba destra più del necessario, tendeva le mani a cercare gli stipiti della porta, e intanto in tutta la sua persona si sentiva come una perplessità, quasi ch’egli fosse capitato in un alloggio altrui, oppure si fosse ubriacato per la prima volta in vita sua e ora si abbandonasse perplesso a quella sua nuova sensazione. Su uno dei due muri dello studio, passando per gli armadi dei libri, si stendeva una larga striscia di luce; insieme con un odore pesante e rappreso di acido fenico e di etere, quella luce veniva dalla porta lievemente aperta che dallo studio conduceva in camera da letto… Il dottore si lasciò cadere nella poltrona ch’era davanti alla tavola; per un minuto guardò con aria sonnolenta i suoi libri illuminati, poi si tirò su e andò in camera.
Lì, in camera, regnava una calma sepolcrale. Tutto, anche la più piccola cosa, rivelava eloquentemente la tempesta appena attraversata e la stanchezza, e tutto era in riposo. La candela ritta su uno sgabello, in mezzo a un fitto gruppo di boccette, di scatole e di vasetti, e una gran lampada sul cassettone illuminavano tutta la stanza di una luce viva. Sul letto, proprio accanto alla finestra, giaceva il bambino con gli occhi aperti e un’espressione di stupore sul viso. Non si moveva, ma i suoi occhi aperti sembravano diventare sempre più scuri, a ogni attimo che passava, e affondare sempre più dentro il cranio. Con le mani sul suo corpo e il viso nascosto nelle pieghe delle coltri, davanti al letto stava inginocchiata la madre. Come il bambino, ella era immota; ma che vivacità di movimento si sentiva nelle sinuosità del suo corpo e nelle sue mani! Si stringeva al letto con tutto il suo essere, con forza e con avidità, come se temesse di turbare la calma e comoda posizione che aveva finalmente trovata per il suo corpo stanco. Le coperte, i cenci, le catinelle, le pozze che c’erano in terra, i pennelli e i cucchiai sparsi dappertutto, il bottiglione bianco con l’acqua di calce, anche l’aria, soffocante e pesa, tutto era fermo e sembrava immerso nella calma.
Il dottore si fermò accanto alla moglie, ficcò le mani nelle tasche dei calzoni e, piegando la testa da un lato, fissò il suo sguardo sul figlio. Il suo viso esprimeva indifferenza; solamente dalle goccioline che gli scintillavano nella barba si poteva vedere che da poco aveva pianto.
In camera non c’era quel ripugnante orrore al quale si pensa, quando si parla della morte. Nell’irrigidimento generale, nella posa della madre, nell’indifferenza del viso del dottore era racchiuso qualcosa che attraeva, che inteneriva il cuore, cioè quella sottile e appena percettibile bellezza dell’umano dolore, che non s’imparerà tanto presto a capire e a descrivere e che soltanto la musica sembra saper esprimere. Si sentiva la bellezza anche in quel cupo silenzio. Kirilov e sua moglie tacevano, non piangevano, come se, oltre alla gravità di quella perdita, avessero coscienza anche di tutto quel che c’era di lirico nella loro condizione: come una volta, a suo tempo, era finita la loro giovinezza, così adesso con quel bambino scompariva per sempre anche il loro di...