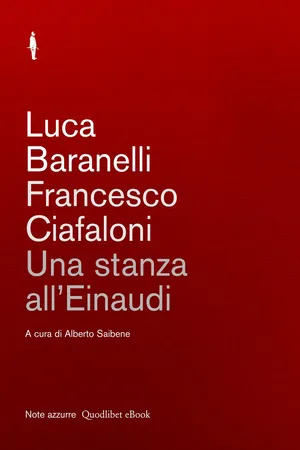La Serie politica Einaudi
Intervista di Luca Zanette a Luca Baranelli
Le chiedo innanzitutto di presentarsi.
Sono nato a Siena nel 1936 e a Siena mi sono laureato in legge nel 1961 con una tesi sul pensiero politico di Carlo Cattaneo. Dopo avere lavorato trentadue anni a Torino nelle redazioni di Einaudi e Loescher, sono andato in pensione nel 1994, ma continuo a svolgere attività editoriali di vario tipo, talora gratis talora con partita Iva.
Come è avvenuto il suo ingresso in casa editrice? E da quali esperienze di vita, anche politiche, è stato motivato?
Dopo la laurea volevo lasciare Siena e trasferirmi al Nord, in una città più grande e più stimolante dal punto di vista sia culturale sia politico. Ero abbastanza ottimista, dato che in quel periodo non era difficile trovare lavoro. Fui comunque molto fortunato, anche perché mio padre conosceva Sergio Solmi – poeta, scrittore e critico insigne nonché dirigente della Banca Commerciale – il quale suggerì di prendere contatto con suo figlio Renato, redattore della casa editrice Einaudi, che forse aveva bisogno di un aiuto. Feci una prova di traduzione dall’inglese e un colloquio preliminare. Quando seppi che potevo partire fui davvero contento: lavorare a Torino, e per di più da Einaudi, mi sembrava, e forse era, il massimo a cui aspirare.
A quell’epoca Torino era molto diversa da oggi, soprattutto perché ci lavoravano decine e decine di migliaia di operai. Molte fabbriche, anche di grandi dimensioni, erano in zone della città vicine al centro e la presenza operaia caratterizzava anche la struttura e la vita dei quartieri: a Borgo San Paolo, ad esempio (io abitavo nei pressi), c’erano stabilimenti della Fiat, della Lancia e della Michelin. Nella primavera del ’62 ci furono grandi scioperi alla Fiat e in altre fabbriche, e il mio ingresso in casa editrice coincise con queste lotte.
Il 1° giugno del 1962 presi servizio nella redazione dell’Einaudi. Era il mio primo lavoro vero, anche se non potevo prevederne la durata. Sapevo solo che avrei fatto un periodo di prova di almeno tre mesi. In realtà la prova durò sette mesi: fui infatti assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 1963 (e rimasi all’Einaudi fino al 30 settembre 1985). Ebbi insomma un intenso apprendistato, anche perché nel ’62 si lavorava otto ore al giorno per cinque giorni, più quattro ore la mattina del sabato. All’inizio, il mio compito era di aiutare in redazione Renato Solmi, che in quel periodo si occupava prevalentemente di libri di attualità politica, sociale ed economica: curava la collana dei Libri bianchi che, dopo una serie con la copertina bianca durata cinque anni, proprio nel 1962 cambiarono aspetto, mettendo una foto in copertina. Il mio tavolo di lavoro era nel suo stesso ufficio.
Da Einaudi cominciai a rivedere la traduzione di Out of Apathy (Uscire dall’apatia), un bel libro a più voci della nuova sinistra britannica, più o meno legata alla «New Left Review». Gli autori erano universitari fra i trenta e i quarant’anni, soprattutto di Oxford: fra loro c’erano l’antropologo Peter Worsley, Ralph Samuel e Stuart Hall, distintosi in seguito nei cultural studies. Principale coautore, e curatore del libro, era lo storico Edward P. Thompson. Si trattava di una raccolta di saggi e interventi sulla crisi del Labour Party, le prospettive e i compiti di una sinistra laburista e post-comunista in una società industriale avanzata. Sia Thompson sia altri del gruppo avevano militato nel partito comunista inglese, e ne erano usciti dopo la crisi del ’56 e i fatti d’Ungheria.
Nel giugno del ’62 ero ancora iscritto al Partito socialista italiano, ma non mi ci riconoscevo quasi più. All’inizio ebbi qualche contatto con i compagni torinesi della sinistra socialista: mi pare di avere rinnovato la tessera del Psi per un paio d’anni, ma era un’adesione puramente formale. Nel 1964 mi iscrissi al Psiup, ma l’anno successivo non rinnovai la tessera e da allora non ho più militato in alcun partito. Il fatto che a Torino fosse in pieno svolgimento l’attività dei Quaderni rossi, e che da Einaudi lavorasse Raniero Panzieri, conosciuto nel 1959 quando era ancora un dirigente del Psi, mi fece avvicinare a quel gruppo. Nel 1961, l’anno prima del mio arrivo a Torino, insieme con altri giovani socialisti, avevo invitato Panzieri a presentare i «Quaderni rossi» a Siena: un’iniziativa molto riuscita, che ci dette entusiasmo. A Torino, quindi, il mio rapporto con la politica aveva come riferimento non tanto la Federazione socialista di corso Palestro quanto Panzieri e i giovani che lavoravano con lui e si riunivano allora al Centro studi Piero Gobetti di via Fabro: fra loro Liliana e Dario Lanzardo, Giovannino Mottura, Vittorio Rieser, e vari altri. Forse alcuni avevano ancora, come me, la tessera del Psi, ma nemmeno loro facevano più attività di partito.
Arrivando a Torino – una città che mi piacque subito molto, in cui sono vissuto volentieri per più di trent’anni, e di cui ho spesso nostalgia – ebbi anche un’altra fortuna. Vi trovai Goffredo Fofi, un amico conosciuto alcuni anni prima. Discepolo di Aldo Capitini, dopo essere stato a lungo in Sicilia a lavorare con Danilo Dolci, Goffredo si era trasferito da qualche anno a Torino: gravitava anche lui intorno al gruppo dei Quaderni rossi, lavorava al Centro Gobetti e aiutava Paolo Gobetti a fare il «Nuovo spettatore cinematografico», un’utilissima rivistina di schede di film. Goffredo fu una delle persone che più mi accolse e m’introdusse in vari ambienti della città; fu lui a farmi conoscere, fra gli altri, Carla e Paolo Gobetti, Bianca Guidetti Serra, Emilio e Gianna Jona, persone carissime con le quali l’amicizia dura da 45 anni. Mi presentò anche Sandro Sarti, un suo amico che aveva dieci anni almeno più di noi e che purtroppo, come Paolo Gobetti, è morto da molto tempo. Sandro era un personaggio singolarissimo: non so esattamente se fosse valdese di origine o si fosse convertito. Giovanissimo, aveva partecipato alla Resistenza in una delle valli valdesi. Era una persona straordinaria in tutti i sensi: aveva una profonda conoscenza dell’inglese e dell’americano e traduceva benissimo, soprattutto per le Edizioni di Comunità (tradusse dei grossi libri per la collana di sociologia diretta da Pietro Rossi). Per Einaudi tradusse anche quel capolavoro della sociologia americana sulla classe media che è Colletti bianchi di C.W. Mills. Vissi con Sandro Sarti, in una mansarda di via Sant’Anselmo 1, a un passo da Porta Nuova, i primi mesi che ero a Torino (la mansarda era sotto il tetto del grande palazzo dei conti Cavalli d’Olìvola, uno dei quali era dirigente della Juventus). La conoscenza e la frequentazione quotidiana di Sandro Sarti furono per me fondamentali. Pur avendo una conoscenza approssimativa dell’inglese, dovevo fare questo lavoro impegnativo di rivedere dei testi, tradotti tra l’altro abbastanza bene. Ma se avevo un dubbio, mi rivolgevo a Sandro e lui mi trovava subito la soluzione più elegante, più brillante. Oppure capiva qualcosa che io non avevo capito. Faccio questo esempio banale del lavoro editoriale, ma la sua conoscenza e amicizia è stata per me importantissima anche per altre ragioni.
Un’estate andò in vacanza in Iugoslavia e non tornava più… Aveva un tipo di vita piuttosto irregolare. Campava di niente, facendo queste traduzioni. Quando poi, dopo alcuni mesi di assenza, dovette lasciare la mansarda, io andai a stare per un periodo più lungo in corso Peschiera, in pieno quartiere della Crocetta, in una mansarda molto più signorile della famiglia Carrara, insieme con il giovane Mario Carrara che allora studiava ingegneria al Politecnico e che divenne mio amico. Abitai lì finché mi sposai, nel settembre ’64. Da allora fino al mio ritorno a Siena nel 1994 ho abitato con mia moglie Fiamma in via Torricelli, a pochi passi dalla ferrovia e da largo Orbassano.
Lei collaborò anche ai «Quaderni rossi»?
Feci solo una breve recensione. Più che altro, quando potevo, andavo alle riunioni, soprattutto per imparare: venivo infatti da una realtà sociale molto diversa, più arretrata, essendo sempre vissuto a Siena fino alla metà del ’62. A Torino si erano già avuti gli scioperi alla Lancia, mi pare all’inizio del ’62. Proprio mentre io ero lì da poco, ci furono i grandi scioperi alla Fiat e in altre fabbriche, e poi i fatti di piazza Statuto. Quindi questo mio incontro iniziale con la città e con la politica – mediato in parte dal gruppo dei Quaderni rossi – fu molto forte e contò molto per la mia formazione non solo politica, ma anche culturale.
Subito dopo i fatti di piazza Statuto, nel luglio del 1962, conobbi Grazia Cherchi e Piergiorgio Bellocchio, che erano venuti a Torino per informarsi, per sentire Panzieri e Solmi su quanto era successo. Con Piergiorgio e Grazia si stabilì un solido rapporto di amicizia, che con Grazia è durato fino al ’95, quando lei è morta, e che con Piergiorgio dura tuttora.
Questo interesse per la politica era molto forte. Però io dovevo anche e soprattutto lavorare in casa editrice. Cinque giorni e mezzo, perché nel ’62, come ho detto, si lavorava anche il sabato mattina.
In che cosa consisteva il suo lavoro all’Einaudi?
All’inizio consisteva prevalentemente nel rivedere traduzioni e nel fare editing di testi (anche se allora non si usava il termine inglese). Come ho già detto, cominciai con Out of Apathy, che poi uscì nella seconda serie dei Libri bianchi, quella con la fotografia in copertina, col titolo Uscire dall’apatia. All’inizio del ’63, se non mi sbaglio, Solmi ottenne di lavorare a metà tempo: si occupava già allora dei problemi della pace e della guerra, soprattutto della bomba atomica e del disarmo nucleare, e voleva studiarli più a fondo. Aveva bisogno di molto tempo per leggere e fare ricerche in biblioteca perché aveva in mente di scrivere un libro su questi argomenti. Solmi veniva in ufficio per quattro ore, non ricordo se la mattina o il pomeriggio, e quindi io per quattro ore lavoravo da solo.
Quello stesso anno il redattore capo Daniele Ponchiroli, una persona davvero rara, pensò di farmi acquisire una formazione più completa a contatto e sotto la guida di Luciano Lovèra, presente in casa editrice da alcuni anni e molto competente su tutti gli aspetti di tecnica editoriale: preparazione di un originale per la tipografia, composizione, impaginazione, correzione di bozze nelle sue varie fasi e modalità, stampa. Lavorai sulle bozze di un grosso libro, Lettere della Rivoluzione algerina, curato dal compianto Giovanni Pirelli, e uscito nei Saggi nel 1963; e di esso scrissi anche una recensione, destinata a una serie di giornali locali del Nord (era questa una pratica dell’ufficio stampa Einaudi). Appresi in tal modo un’altra parte del mestiere che è molto importante nel lavoro editoriale.
Rividi anche la traduzione, che ricordo piuttosto scadente, di un grosso libro, Le travail en Sicile, che non fu pubblicato da Einaudi e che è uscito in anni recenti da Sellerio col titolo Sicilia anni Cinquanta. L’aveva scritto una geografa francese, Renée Rochefort, che in Sicilia aveva conosciuto Danilo Dolci e Goffredo Fofi e che, dopo una lunga ricerca, aveva scritto un saggio di geografia umana e sociale. Passai molto tempo a rivederne a fondo la traduzione. Poi, come a volte succedeva da Einaudi, il libro non vide la luce. Fu un lavoro che servì a me, non alla casa editrice. Fui messo alla prova anche su un testo molto più difficile, di economia dei paesi sottosviluppati, per la quale avevo scarsa competenza concettuale e terminologica. La traduzione fu infatti rivista ulteriormente da Giorgio La Malfa e dall’economista Sergio Steve, allora consulente di Einaudi. In questa fase di apprendistato, quella fu sicuramente la mia prova peggiore. Ma anche dalle cose mal riuscite s’impara sempre qualche cosa.
Oltre al lavoro di revisione, Solmi mi faceva anche leggere qualche libro sul quale lui avrebbe dovuto riferire nella riunione settimanale del mercoledì. Naturalmente, essendo io un novellino, quando Solmi mi dava un libro da leggere ne parlavo prima con lui, e poi eventualmente – quando fui ammesso alle riunioni – ne riferivo se era il caso. La conoscenza stessa di chi partecipava attivamente alle riunioni del mercoledì – fra gli altri Bobbio, Calvino, Fortini, Mila, Panzieri, Ponchiroli, Venturi, Vittorini (mentre li nomino mi accorgo che sono tutti morti) – mi arricchì molto. Insomma, anche su quest’aspetto di lettura e consulenza feci un po’ di apprendistato. Purtroppo la mia collaborazione con Solmi durò soltanto dal giugno del ’62 al novembre del ’63, quando lui e Panzieri furono licenziati in tronco dalla casa editrice in seguito alla grave crisi interna e alla bocciatura del libro di Goffredo Fofi su L’immigrazione meridionale a Torino.
La collaborazione era anche con Panzieri?
Panzieri a quell’epoca aveva con la casa editrice un contratto di collaborazione che non comportava la sua presenza quotidiana in casa editrice. Doveva fare certe cose, e le faceva. Era molto propositivo, leggeva molto, però non faceva il lavoro redazionale in senso stretto, come aveva fatto negli anni precedenti, quando era un redattore. Posso quindi dire che il mio riferimento principale era Solmi, anche se l’amicizia e l’ammirazione per Panzieri contavano molto. Politicamente mi consideravo un suo seguace già dalla fine degli anni Cinquanta.
Anche Panzieri e Solmi si conoscevano e si stimavano da tempo, ma si conobbero più a fondo negli anni einaudiani a partire dal ’59, quando Panzieri fu assunto in casa editrice. Ma direi che il loro ...