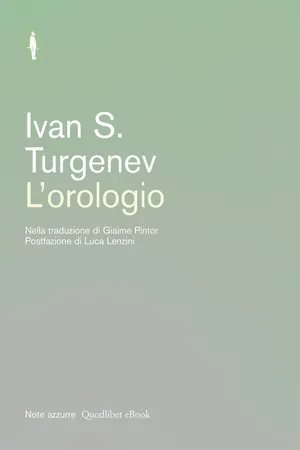![]()
![]()
I
Vi racconterò la storia del mio orologio… Strana storia! La cosa risale al principio di questo secolo: al 1801. Io avevo appena compiuto i sedici anni. Abitavo a Rjazan, in una casetta di legno, non lontano dalla riva dell’Okà, con mio padre, una zia ed un cugino. Mia madre non la ricordo: era morta dopo tre anni di matrimonio; e io ero l’unico figlio. Mio padre si chiamava Porfirij Petrovic. Era un uomo quieto, di poca apparenza, malaticcio; si occupava di affari legali, e d’altro ancora. Un tempo quelli che, come lui, bazzicavano per i tribunali, erano chiamati legulei, azzeccagarbugli, seme d’ortica; ma mio padre denominava se stesso «avvocato». Dell’andamento di casa nostra si occupava sua sorella, cioè mia zia, una zitellona cinquantenne; anche mio padre aveva ormai sorpassato la quarantina. Lei era molto devota o, meglio, una pinzochera; ed era anche pettegola, e cacciava il naso dappertutto. Poi, non aveva il cuore di mio padre. Noi non si viveva poveramente, bensì in una ristretta agiatezza, ma appena appena. Mio padre aveva inoltre un fratello, di nome Jegor; ma, per «mene sovversive e mentalità giacobina» (erano le parole della sentenza) l’autorità l’aveva relegato in Siberia sin dal 1797.
II figlio di Jegor, Davyd, era rimasto sulle spalle di mio padre e viveva con noi. Era maggiore di me solo di un anno; ma io lo rispettavo e gli ubbidivo come ad un adulto. Era un ragazzo intelligente, di carattere, largo di spalle, ben piantato, dalla faccia quadrata, tutta sparsa di lentiggini, i capelli rossicci, gli occhi grigi, piccoli, le labbra larghe, il naso corto, le dita pure corte, e una forza!… una forza da non credersi. La zia non poteva sopportarlo; e mio padre addirittura lo temeva, o, forse, si sentiva colpevole davanti a lui. Correva la voce che se mio padre non avesse parlato troppo, non avrebbe compromesso suo fratello: e allora il padre di Davyd non sarebbe stato relegato in Siberia. Io e Davyd studiavamo nel ginnasio, nella medesima classe, entrambi con buoni risultati; io, anzi, superavo Davyd. Avevo una memoria più tenace; ma i ragazzi, si sa, non apprezzano questa dote e non se ne vantano, e così Davyd restava sempre la mia guida.
![]()
II
Io mi chiamo, come sapete, Aleksjej. Nacqui un sette di marzo, e il mio onomastico ricorre il diciassette. Secondo una vecchia usanza, mi fu dato il nome di uno di quei santi, la festa dei quali ricorreva nel decimo giorno dalla mia nascita. Mio padrino era stato un certo Anastassij Anastassjevic Puc’kov o, propriamente, Nastassjej Nastassjejc: nessuno lo chiamava in altro modo. Costui era un mestatore, un intrigante, uno scroccone patentato: insomma, un brutto tipo: era stato scacciato dagli uffici del governatore, e più di una volta si era trovato sotto processo: eppure si rendeva necessario a mio padre. Loro due «lavoravano» insieme. D’aspetto era grasso e tondo; aveva una faccia volpina e un naso aguzzo; anche gli occhi grigi somigliavano a quelli di una volpe. E li girava sempre, a destra e a sinistra, e moveva anche il naso, proprio come se fiutasse 1’aria. Portava scarpe senza tacchi; e s’incipriava i capelli ogni giorno; ciò che allora in provincia si riteneva cosa assai rara. Lui assicurava che non poteva vivere senza cipria, perché aveva da fare con generali e «dame dell’ alta società».
Così giunse il mio giorno onomastico. Nastassjej Nastassjejc venne a casa nostra e mi disse:
– Finora, mio caro figlioccio, non ti ho regalato mai nulla; ma guarda un po’ che cosa ti ho portato questa volta! – e si levò da una tasca un orologio – un cipollone d’argento – con una rosa disegnata sul quadrante e la catena di bronzo. Io venni meno dalla gioia, e la zia, Pelagheja Petrovna, si mise a gridare:
– Su dunque, baciagli la mano, pidocchioso!
Baciai la mano al mio padrino, e intanto la zia protestava:
– Come lo viziate, Nastassjej Nastassjejc! Cosa ne fa di un orologio? Vedrete, lo lascerà cadere e finirà per rovinarlo.
Entrò mio padre, diede un’occhiata all’orologio, ringraziò Nastassjejc, ma con una cert’aria indifferente, e lo chiamò nel suo studio. Udii mio padre dire, come fra di sé:
– Se credi, caro mio, di cavartela così…
Ma io non potei resistere, mi misi l’orologio in un taschino e corsi da Davyd a mostrargli il regalo.
![]()
III
Davyd prese l’orologio, l’aprì e l’esaminò con attenzione. Aveva molta attitudine alla meccanica; gli piaceva maneggiare il ferro, il rame, ogni sorta di metalli; si era procurato varii strumenti, ed era per lui un affare da nulla riparare o addirittura rifare una vite, una chiave o cose del genere. Davyd fece passare l’orologio da una mano all’altra e borbottò fra i denti (era poco loquace per natura):
– Vecchio… cattivo… – e aggiunse: – Come fai ad averlo?
Gli dissi che me l’aveva regalato il mio padrino.
Davyd mi fissò coi suoi occhietti grigi:
– Nastassjej?
– Sì. Nastassjej Nastassjejc.
Davyd mise l’orologio sul tavolo e si scostò in silenzio.
– Non ti piace? – gli chiesi.
– No, non è questo… Ma io, al tuo posto, non accetterei regali da Nastassjej Nastassjejc.
– Perché?
– Perché è un tipaccio; e a gente simile è meglio non dover nulla. E poi bisogna ringraziarli. Magari, gli hai anche baciato la mano?
– Sì. È stata la zia a costringermi.
Davyd rise in un certo modo, nel naso. Era la sua maniera. Non rideva mai forte: l’avrebbe ritenuto un segno di debolezza.
Le parole di Davyd, il suo sorriso silenzioso mi amareggiarono profondamente. Dunque, pensai, lui mi condannava! Lui non si sarebbe mai umiliato ad accettare un dono da Nastassjejc! Ma ormai che cosa avrei potuto fare? Restituire l’orologio? Impossibile!
Provai a parlare con Davyd, a chiedergli un consiglio. Mi rispose che lui consigli non ne dava e che facessi pure quel che volevo. Quel che volevo? Mi ricordo, non dormii tutta la notte: l’incertezza mi tormentava. Mi dispiaceva rinunciare all’orologio: l’avevo messo vicino al letto, sul tavolino da notte, e faceva un tic-tac così piacevole e divertente… Ma il pensiero che Davyd mi disprezzava… (sì, inutile ingannarsi, lui mi disprezzava!) mi appariva intollerabile. Verso il mattino presi una decisione. Confesso, piansi, ma poi mi addormentai e, svegliatomi, subito mi vestii in fretta e corsi fuori in istrada. Avevo deciso di dare l’orologio al primo poveretto che avrei incontrato per la via.
![]()
IV
Non dovetti andare molto lontano per trovare la persona che cercavo. Mi ero imbattuto in un ragazzo di circa dieci anni, lacero e scalzo, che si aggirava spesso intorno a casa nostra. Andai subito da lui e, senza dar tempo di riflettere né a me né al ragazzo, gli offrii l’orologio. Il poveretto spalancò gli occhi, si mise una mano davanti alla bocca, come per difendersi, e stese l’altra.
– To’, prendi, – mormorai: – è mio, te lo regalo: puoi venderlo e comprarti qualche cosa di utile… Addio!
Gli misi in mano l’orologio e corsi a casa. Dopo esser rimasto un poco dietro la porta della nostra stanza e aver ripreso fiato, mi avvicinai a Davyd, che aveva appena finito di vestirsi e si spazzolava i capelli.
– Sai, Davyd? – cominciai con la voce più tranquilla che potevo. – Ho regalato l’orologio di Nastassjej.
Davyd mi guardò e si passò la spazzola sulle tempie.
– Sì, – aggiunsi sempre con quel tono importante, – l’ho regalato. Vicino a noi abita un ragazzo: è tanto povero, e l’ho dato a lui.
Davyd pose la spazzola sul tavolo che sosteneva il catino.
– Potrà venderlo e comprarsi qualcosa di utile, – continuai. – Gli daranno pure un po’ di soldi, se lo vende.
Tacqui, in attesa.
– Ebbene? é una buona cosa! – disse infine Davyd e andò nella stanza di studio. Io lo seguii. – E se ti domanderanno dove hai messo l’orologio? – mi chiese.
– Dirò che mi è caduto e si è rotto, – risposi, con noncuranza.
Non scambiammo più una parola sull’ orologio, quel giorno; eppure mi pareva che Davyd non solo mi approvasse, ma, sino a un certo punto, persino mi ammirasse. Davvero!
![]()
V
Passarono ancora due giorni. Nessuno in casa pensava più all’orologio. Mio padre aveva gravi pensieri a causa d’un cliente: aveva altro per la testa che me e il mio orologio. Invece io ci pensavo giorno e notte. Persino l’approvazione, la supposta approvazione di Davyd non mi consolava troppo. Egli non l’aveva espressa in un modo chiaro e convincente: solo una volta disse, così di passaggio, che non si sarebbe aspettato tanto coraggio da me. Dunque, il mio sacrificio si risolveva in una perdita per me, e non era compensato dalla soddisfazione che l’amor proprio mi aveva procurato.
Per di più, come a farlo apposta, era venuto da noi un nostro compagno di ginnasio, figlio di un dottore, a far mostra del suo orologio nuovo, e non d’argento, ma di similoro, regalo di sua nonna.
Non resistetti, e pian piano uscii di casa e mi misi alla ricerca del ragazzo a cui avevo dato l’orologio
Presto lo rintracciai: insieme ad altri ragazzi giocava agli aliossi sul sagrato della chiesa. Lo chiamai da parte e, ansando e, balbettando, gli dissi che i miei genitori erano in collera con me, perché non avevo più l’orologio, e che se lui me l’avesse restituito, gli avrei dato dei soldi. Per ogni caso m’ero provvisto di un vecchio rublo del tempo di Elisabetta, ch’era tutto il mio capitale.
– Ma io non l’ho più, il vostro orologio, – rispose imbronciato il ragazzo; – il babbo l’ha visto e me l’ha preso; e voleva picchiarmi. Tu certo l’hai rubato: chi è quell’imbecille che va a regalare gli orologi?
– Ma chi è tuo padre?
– Mio padre? Trofimyc.
– Ma che mestiere fa?
– È un soldato in congedo, un sergente. Non fa nessun mestiere. Ripara le scarpe rotte, e rimette le suole. Ecco il suo mestiere: tutto lì.
– Ma dove abitate? Conducimi da lui.
– Va bene. Ma voi gli direte, al babbo, che siete stato voi a regalarmi l’orologio. Lui adesso dice che sono un ladro. E anche mia madre…
Andai col ragazzo a casa sua. Abitavano in una stamberga affumicata, situata in un cortile, dietro ai resti di una fabbrica distrutta dall’incendio. Trofimyc e sua moglie erano in casa. Il sergente in congedo era un vecchio alto, diritto, nerboruto, dai favoriti di un grigio giallognolo, dal mento peloso e una fitta rete di rughe sulle guance e la fronte. Sua moglie pareva più vecchia di lui: i suoi occhietti arrossati ammiccavano tristemente e si socchiudevano sul volto gonfio e pallido. Entrambi erano coperti da indefinibili stracci scuri.
Spiegai a Trofimyc perché ero venuto. Egli mi ascoltò in silenzio, ad occhi spalancati e immobili, e senza staccare da me il suo sguardo fisso e rigido, un vero sguardo di soldato sull’atte...