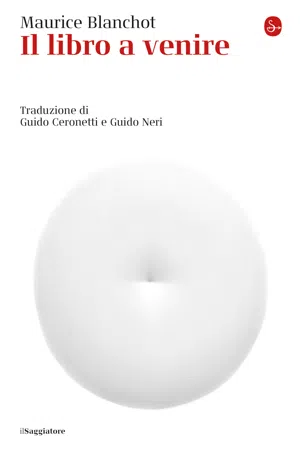![]()
PARTE TERZA
Un’arte senza avvenire
![]()
12. Al punto estremo
L’arte sta per finire? La poesia perisce, per essersi guardata in faccia, allo stesso modo che chi ha veduto Dio muore? Il critico che esamini il nostro tempo, paragonandolo al passato, non può che esprimere un dubbio e, verso gli artisti che nonostante tutto ancora producono, un’ammirazione disperata. Ma quando si è provato, come Wladimir Weidlé in un libro ricco di cultura, di ragione e di rimpianti, che l’arte moderna è impossibile – e questa prova è persuasiva, forse fin troppo lusingatrice – non si è messa in valore l’esigenza segreta dell’arte che sempre, in ogni artista, è lo stupore di ciò che è senza essere possibile, di ciò che deve cominciare al limite estremo, opera della fine del mondo, arte che muove i primi passi solo dal punto in cui l’arte non è più, dove le sue condizioni mancano? Nel dubbio, non si va mai troppo lontano. È il modo, uno dei modi, di andare più lontano nella meraviglia dell’indubitabile.
W. Weidlé scrive: «L’errore di Mallarmé», e Gabriel Marcel: «L’errore mallarmeano…». Errore evidente. Ma non è altrettanto evidente che dobbiamo, a quell’errore, Mallarmé? Ogni artista è legato ad un errore col quale ha uno speciale rapporto d’intimità. C’è un errore di Omero, di Shakespeare – che è forse, per entrambi, il fatto di non esistere. Ogni arte trae origine da un difetto eccezionale, ogni opera è quel difetto d’origine in azione, da cui ci vengono il minaccioso appressarsi della pienezza e una luce nuova. È questa una concezione propria del nostro tempo, di questo tempo in cui l’arte ha cessato di essere un’affermazione comune, una tranquilla meraviglia collettiva, ed è tanto più importante quanto meno probabile? Forse. Ma, una volta, che altro era?
E che cos’è quel vago «una volta» in cui tutto ci sembra così facile e sicuro? È l’oggi che ci tocca invece, e, rispetto all’oggi, lo si può affermare con risolutezza: un artista non sbaglia mai troppo, non si lega mai troppo al suo errore, in un grave, solitario, arrischiato, insostituibile contatto, perché qui urta, con terrore e delizia, contro quell’eccesso che, dentro di lui, lo spinge fuori di sé e fuori, forse, di tutto.
(Discepoli, imitatori sono coloro che, come i critici, fanno di un errore ragione, lo stabilizzano, lo calmano, e così lo fanno valere e diventare palese; e allora è facile per i critici denunciare l’errore, mostrare in che vicolo cieco conduca, con quale fallimento si paghi la riuscita, e addirittura che fallimento è stato l’essere riusciti.)
Il legame con l’errore, questo rapporto difficile da raggiungere, più difficile da sostenere, che si scontra, proprio in colui che è sotto la fascinazione dell’errore, con un dubbio e una sconfessione, questa passione, questa pratica paradossale, riguarda anche il romanzo, il genere più fortunato, del quale tuttavia abbiamo sempre sentito dire che era arrivata la fine. Si diceva questo non perché il romanzo non producesse più opere grandi, ma ogni volta che grandi scrittori scrivevano grandi romanzi, unanimemente riconosciuti come libri letterariamente importanti. Perché, ogni volta, i loro autori sembravano aver infranto qualche cosa: non esaurivano il genere, come Omero l’epopea, ma lo alteravano con tanta autorità e con una energia così sconcertante, così sconcertata a volte, che sembrava divenuto impossibile fare ritorno alla forma tradizionale, come pure portare più avanti l’uso della forma aberrante, o anche soltanto ripeterla. Lo si disse in Inghilterra a proposito di Virginia Woolf o di Joyce; in Germania a proposito di Broch, di Musil e anche della Montagna incantata. In Francia, la situazione è un po’ diversa. La scossa prodotta da Proust fu immediatamente ricoperta da una tale ondata di ammirazione universale che questo fenomeno unico, del resto uno dei primi, parve soltanto provare il genio di Proust, lasciando intatto l’orizzonte tradizionale del romanzo. Les Faux-Monnayeurs fa dubitare del genio romanzesco di Gide, piuttosto che del romanzo stesso e, più tardi, La Nausée rivelerà i doni di Sartre senza mettere in causa le certezze del romanzo, poiché (a torto) si riduce il suo libro ora alle forme del racconto ideologico, ora di quello naturalistico. E poi, all’epoca di Sartre, il male è già fatto. Il romanzo che assorbe e concentra quasi tutte le forze di tutti gli scrittori, sembra anch’esso ormai un’arte senza avvenire.
L’eccezione e la regola In questa visione estremamente affrettata delle cose, dev’esserci qualcosa di vero. Certo anche Balzac, creando un’opera mostruosa, deforma potentemente il genere che introduce nella letteratura. Ma Balzac ha una posterità. Esiste un romanzo balzacchiano. Tutti gli autori che abbiamo nominato non generano. Né Proust né Joyce fanno nascere altri libri che gli somiglino: sembra non abbiano altro potere che d’impedire gli imitatori e scoraggiare i tentativi analoghi. Essi chiudono uno sbocco.
Ma non si tratta di un risultato puramente negativo. Se è vero che Joyce spezza la forma romanzesca rendendola aberrante, fa anche intendere che essa non vive, forse, che delle sue alterazioni. Essa si svilupperebbe non generando mostri, opere informi, senza legge e senza rigore, ma provocando unicamente delle eccezioni a se stessa, che danno forma alla legge e ad un tempo la sopprimono.
Situazione tanto più inestricabile, in quanto il romanzo così inteso si afferma, in silenziosa solitudine, in margine all’enorme massa di libri scritti con talento, ingegnosità e generosità, nei quali il lettore è invitato a riconoscere la vitalità di un genere inesauribile. Come non credere allora che tutti quei buoni libri, tra cui talvolta emergono opere brillanti, rappresentino la regola, e che gli altri se ne discostino per un’originalità priva di conseguenze? In questa prospettiva, Jules Romains sarebbe la regola, Joyce l’eccezione. Ma le cose non stanno probabilmente così. C’è da ritenere piuttosto che, ogni volta, in quelle opere eccezionali che toccano un limite, proprio l’eccezione si fa rivelatrice di quella «legge» di cui essa costituisce anche l’insolita e necessaria deviazione. Tutto avverrebbe quindi come se, nella letteratura romanzesca, e forse in ogni letteratura, l’unico modo per noi d’individuare la regola fosse l’eccezione che l’abolisce: la regola o più esattamente quel centro di cui l’opera certa è l’incerta affermazione, la manifestazione già demolitrice, la presenza momentanea e subito negativa.
Non si tratta di novità ad ogni costo: novità tecnica, di forma o di visione. Non si tratta neanche sempre di opere importanti e riuscite, rivelatrici di grandi individualità, di cui il nome ammirato di Balzac, il nome amato di Stendhal, ci fanno invano desiderare il ritorno. Naturalmente, il talento è cosa assai utile; la potenza creatrice, sconcertante talvolta, è un aiuto di cui non si può fare a meno, fosse pure per superarla. Ma altro è in gioco, un’esigenza eccessiva, un’affermazione rigorosa ed esclusiva rivolta in un’unica direzione, con la passione che rende necessario il tentativo impossibile. Nathalie Sarraute, come Virginia Woolf, parla di «realtà», e dice che il romanziere «cerca di portare alla luce la particella di realtà che gli è propria». Diciamo dunque realtà. Ma questa realtà non è data in anticipo, né in altri libri, anche qualificati come capolavori, né in quel mondo che dal nostro sguardo d’ogni giorno ci è aperto; essa ci sfugge senza posa, inafferrabile e come velata da ciò che la manifesta: è una realtà altrettanto semplice, ma anche altrettanto eccezionale, quanto il libro che per un istante la farà brillare davanti ai nostri occhi.
Quando, di un tentativo romanzesco, pensiamo e vediamo che sbocca in un vicolo cieco, questo non basta probabilmente a renderlo valido, ma ogni volta che in un libro nuovo ritroviamo l’affermazione solitaria e silenziosa del romanzo inteso come l’eccezione, anche male espressa, di una legge incessantemente compromessa, momento già dileguante di un più largo movimento in divenire, abbiamo il senso di una promessa e l’impressione esaltante che uno scrittore nuovo, toccato un limite, è riuscito a spostarlo, forse a fissarlo più oltre. Questo innanzitutto conta. Ogni scrittore si sente solidale con questa nuova affermazione, anche se non lo scarica da quella che a lui spetta (sarebbe troppo bello), anche se gli è avversa. Non si tratta di un progresso di cui possa godere, neppure di una comprensione più sicura e più pura della forma romanzesca: anzi, tutto si fa più difficile e più incerto. E tali opere sono rare, fuggevoli. Non sempre le scrive un Proust; sono tormentate, «maldestre», impigliate in convenzioni alle quali non hanno il coraggio di rinunciare; talvolta, esageratamente coscienziose. Alcune sono modeste. Ma tutte, anche quelle che scompaiono, hanno la forza che viene da un contatto nuovo con la «realtà».
![]()
13. Broch
1. «I Sonnambuli»: la vertigine logica
La sua opera comprende poche cose. Non è uno scrittore come Thomas Mann, la cui generosità di creatore si dispiega su piani molteplici, e infaticabilmente rinnova a suo uso la gioia del narrare. Pochi libri, ma ampi e, per la loro mole, imponenti. In questo, già vicino a Joyce, che fu il suo modello. Prima della guerra, la trilogia dei Sonnambuli (1928-1931). Nel 1946, La Morte di Virgilio. Poi Gli Innocenti, una raccolta di racconti che segnano, pare, il limite estremo della sua ricerca e forse il tramonto delle sue possibilità. La pubblicazione delle sue opere complete comprende però otto volumi, perché, oltre ad un romanzo postumo, Il Tentatore, e ad un volume di poesie, tre libri di saggi critici e filosofici testimoniano della problematica cui si è applicato il pensiero di Hermann Broch. Eppure, parlando della ricchezza delle sue disposizioni e della vastità dei suoi interessi, non gli renderemmo giustizia. Egli non fu un romanziere da una parte, un poeta dall’altra, e in altri momenti uno scrittore di riflessioni. Fu tutto questo insieme e, spesso, nello stesso libro. Ha dunque subìto come molti altri scrittori del nostro tempo, la pressione impetuosa di una letteratura ormai insofferente della distinzione dei generi, tesa a romperne i limiti.
L’uomo disperso, frammentario Diventa scrittore solo tardi, e a poco a poco, forse controvoglia, cede alla scompostezza di un’opera che avrebbe desiderato controllare perfettamente. Fino ai quarant’anni, si occupa di un’impresa d’industria tessile, eredità di famiglia, poi rinuncia d’improvviso a questa attività per studiare la filosofia e soprattutto la matematica. Qualche commentatore tedesco l’ha paragonato a Valéry. Come Valéry, è portato alla matematica da una specie di passione, e tende a cercarvi la parte più segreta – la più pericolosa – dell’uomo. Non è però uno scrittore che crede soprattutto all’intelletto, come Valéry. Si sente interpellato dal suo tempo, su cui incombe la minaccia della catastrofe prossima. Il tracollo di un sistema unico di valori, quale esisteva nel Medioevo sotto una forma cristiana, invece di liberare l’individuo, lo espone a una disintegrazione inevitabile. Nel sistema cristiano, la fede, e al suo centro Dio, un Dio vivo, era il «punto di plausibilità» che bloccava la forza irreprimibile dei problemi. È la forza che sembra interessare soprattutto Broch, che lo attrae e lo atterrisce a un tempo: l’intolleranza logica, crudeltà che è intrinseca alla nozione di essere. Perché l’essere tende a «dissolversi in funzionalità pura»? Perché l’immagine fisica del mondo deve scomparire? Perché la realtà cede necessariamente al simbolo, e il simbolo al simbolo del simbolo? Che cosa accade, quando bisogna decidersi per l’astrazione? Viviamo in una discordanza prodigiosa. L’uomo è disperso e discontinuo, non momentaneamente, come già è accaduto in altre epoche storiche; oggi la discontinuità è l’essenza stessa del mondo. Quasi che si trattasse per noi di edificare un mondo – l’universo, l’affermazione più totale, più unificata – proprio sul carattere disarticolato, disarmonico, frantumato dell’essere, o sulle carenze dell’uomo.
Broch vede, nel puro razionale, altrettanti pericoli che nell’impuro irrazionale. Entrambi mancano di stile. La natura da una parte, la matematica dall’altra, ci espongono all’esigenza vuota dell’infinità. Certo, ogni sistema di valori cerca di espellere l’elemento irrazionale e di condurre l’esistenza terrestre dalla sua «malvagità» a un più elevato senso razionale, ad un insieme di sensi in cui «diventa possibile per noi assegnare istintivamente alle cose come alle azioni il posto che a ciascuna compete». Trasformare quel che è irrazionale, privo di valore, in razionalità assoluta, tale è il compito, che fallisce però necessariamente. Per due ragioni: quel che chiamiamo irrazionale rimane inaccessibile, e riusciamo appena ad avvicinarci ad esso, tracciando cerchi sempre più stretti, integrandolo nei nostri calcoli, ma alla fine ci sfugge sempre, a tal punto che non sappiamo mai niente del non senso di cui il nostro modo d’agire è impregnato. «L’uomo non sa niente dell’“intrusione dal basso” cui è esposto, e non ne sa niente, perché ad ogni passo, ad ogni istante, egli si trova dentro un sistema di valori il cui solo scopo è di ricoprire e padroneggiare tutto l’irrazionale da cui la nostra vita legata alla terra è portata.» La luce ci impedisce di vedere, la facoltà di dar senso ci abbandona all’azione imprevista di quel che dietro al senso si nasconde e agisce in questa dissimulazione.
Ma c’è qualcosa di più grave. La ragione, deduttiva o dialettica, mossa dalla forza insopprimibile dei problemi, tende all’assoluto. Il razionale vuole farsi superrazionale. Il movimento logico non sopporta né pause né punti di equilibrio, è intollerante di ogni forma, dissolve tutti i contenuti, e organizza il regno freddo, simile a un sogno, dell’astrazione. Momento del male radicale, perché la ragion pura, fattasi autonoma, è ancor più «malvagia» dell’irrazionale: dove essa ha introdotto la sua dissoluzione, tutto si stempra in una nebbia astratta dove non c’è più centro di valori, e l’individuo umano, abbandonato al vuoto gioco delle convenzioni intolleranti, si smarrisce in mezzo a fantasmi di ragioni che continua a ritenere superiori certezze. Ed è allora l’uomo del niente, metafisicamente escluso e fisicamente destituito, un sonnambulo che vaga nel proprio sogno e, scacciato dal sogno, è rigettato nell’angoscia notturna da cui non può destarsi, senza poterci dormire.
Questi pensieri (di cui si potrebbe facilmente ritrovare l’origine) hanno questo di caratteristico, che si sviluppano sotto forma astratta in margine all’intrigo romanzesco che, nei tre libri dei Sonnambuli, ci conduce dalla Germania imperiale, brillante e convenzionale, al tracollo del 1918. Il tema del vasto romanzo non è segreto. Broch ha l’arte di mettere in evidenza i pensieri teorici che diversamente andremmo a cercare dentro le sue storie. I titoli già dicono tutto: Pasenow o il romanticismo, 1888; Esch o l’anarchia, 1903; Huguenau o il realismo, 1918; e, sopra quei tre nomi, la parola notturna che qui non è neppure un’immagine, ma una diagnosi: Sonnambuli.
Romanzo della decadenza, che però non pretende di insegnarcela, come farebbe un romanzo didascalico, e neanche ce la descrive, ma la mima aprendosi, perfino nella forma, alle forze spregiatrici. Quando Broch ci racconta la storia del piccolo nobile pomeranico, il luogotenente Pasenow, non c’è affatto tra lo scrittore e il suo personaggio la simpatia d’immaginazione e anche d’origine che univa Thomas Mann ai Buddenbrook, analogo racconto di un destino sfinito, ma neppure c’è in lui un intento denigratorio. Il disagio che ci dà quel povero giovane, col suo vuoto attaccamento ad un vuoto ideale, la sua impotenza che gli impedisce di aprire gli occhi su se stesso, e che egli si dissimula ingenuamente, anche quando lo espone alle disavventure di una notte di nozze mancata, nasce dalla forma stessa del racconto: forma classica, quasi convenzionale. Broch si compiace di raccontare come avrebbe potuto farlo un romanziere dell’epoca da lui evocata, e si trova perfettamente a suo agio in questo modo di raccontare tra oggettivo e psicologico, dove però è già visibile un’incrinatura tra i comportamenti e i pensieri. Gli uni e gli altri hanno qualcosa di macchinale che si scopre soltanto quando si produce fra loro una leggera sfasatura. Con chi abbiamo a che fare? Che cosa c’è dietro quella pellicola di eventi e di parole? Alla fine, l’autore interviene brutalmente per porre fine alla finzione; lo sentiamo impaziente di salvare se stesso dalla nullità che ha rappresentato, e di salvarne il lettore. Ma i libri sono dei sonnambuli che non bisogna destare.
Diversi scrittori in uno solo Broch è più vicino a Esch, personaggio del secondo libro, tedesco medio, piccolo contabile, che un raffinato miscuglio d’idee astratte sulla giustizia, di desiderio d’ordine e di cattiva coscienza trascina, attraverso uno zig-zag di affari mediocri, di amori loschi e di miserabili intrighi perseguiti sui margini dei movimenti più profondi rappresentati dalle correnti rivoluzionarie, fino ad un posto di grande contabile in un’impresa lussemburghese. Racconto assai convincente. Il movimento è veloce. Le frasi corte, staccate. Azioni, pensieri si susseguono, o meglio si giustappongono, con un’asciutta rapidità, una specie di meccanica febbre, di sterile precipitazione che è la verità del romanzo. Bisogna qui ammirare (e stupirsene) l’estrema varietà di linguaggi, di stili e anche di sintassi di cui Broch è capace. Uno che scoprisse, in fondo a un orcio, la sua opera centrale, La morte di Virgilio, dove pure si riscontra una ricerca di variazioni nel ritmo, ma in cui predomina però una frase immensa, con ripetizioni senza fine e la solenne ampiezza di una sm...