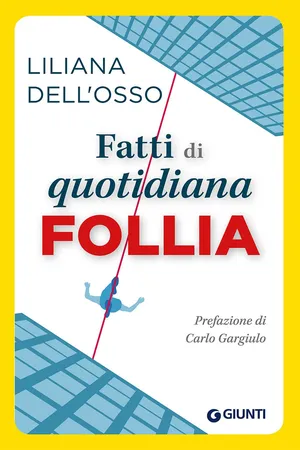![]()
1
Vedere la morte
La follia è molto rara negli individui, ma nei gruppi,
nei partiti, nei popoli, nelle epoche è la regola.
François de La Rochefoucauld
DUST LADY
Il 25 agosto 2015 moriva Marcy Borders, meglio nota come Dust Lady (“Lady Cenere”), la giovane donna diventata uno dei simboli dell’attacco alle Torri Gemelle. Aveva fatto il giro del mondo la foto che la immortalava, completamente coperta di cenere, in fuga dal World Trade Center subito dopo l’attentato dell’11 settembre 2001. Dopo quel trauma, da cui pure era uscita fisicamente illesa, e a causa di esso, la sua vita andò in frantumi: sentendosi continuamente in pericolo, vedeva in chiunque un attentatore. Aveva flashback frequenti (sotto forma di immagini improvvise e vivide dell’attentato) e attacchi di panico ricorrenti. Da impiegata della Bank of America in tailleur e caschetto ordinato, negli anni si era lasciata andare, diventando dipendente da alcol e droghe, ed era stata privata della custodia dei figli. Pur dicendosi migliorata dopo aver appreso della morte di Bin Laden, alla fine ha sviluppato un tumore allo stomaco che l’ha stroncata prematuramente, all’età di 42 anni, 14 dopo quel terribile giorno.
Da simbolo dell’attentato a prototipo della patologia del sopravvissuto: il Disturbo da Stress Post-Traumatico (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD), che fa seguito all’esposizione a traumi estremi, quali eventi di massa (catastrofi naturali, terremoti, alluvioni o incidenti) o individuali (rapine, violenze fisiche e sessuali, aggressioni) che mettono in pericolo di vita, oppure producono gravi lesioni al soggetto stesso o a terze persone. I sintomi tipici sono quelli della rievocazione sotto forma di incubi, immagini, ricordi terrificanti dell’evento, con evitamento di persone, luoghi e persino pensieri che lo ricordano. Concomitano sentimenti inappropriati di colpa, perdita della capacità di provare emozioni positive e fiducia nel futuro, ipervigilanza, con reazioni di allarme per stimoli minimi, disturbi del ritmo sonno-veglia, difficoltà di concentrazione, comportamenti spericolati e autodistruttivi, come abuso di alcol e droghe, fino al suicidio. Anche quando non raggiunge un’espressività così marcata, la patologia ha comunque un decorso cronico e invalidante.
Recenti ricerche (tra cui proprio quelle svolte sugli abitanti di Manhattan e sui sopravvissuti al terremoto dell’Aquila del 2009) hanno permesso di tracciare l’identikit del soggetto a rischio di sviluppare un PTSD in seguito all’esposizione a un trauma grave: donna, giovane, single. Sebbene l’entità oggettiva del trauma sia importante, la presenza di tratti ossessivi, in particolare la tendenza a rimuginare, rappresenta il fattore predisponente cruciale. Infatti comporta un’esposizione ripetuta al trauma, riattualizzandolo e amplificandone progressivamente l’impatto patogeno. Da qui il decorso tipicamente ingravescente.
In pratica, si cade sotto il fuoco amico dei nostri stessi pensieri. In gioco ci sarebbe un’alterazione del meccanismo dell’oblio: il nostro cervello elimina i ricordi non in maniera passiva, cioè perdendoli come fosse un recipiente bucato, ma attivamente, rimuovendo ciò che non gli serve o lo danneggia (come il ricordo doloroso di un trauma). In questi casi avere una memoria particolarmente efficiente diventa, paradossalmente, uno svantaggio. «Oh memoria, nemica mortale del mio riposo», scriveva Miguel de Cervantes. Per quanto riguarda gli aspetti personologici predisponenti, occorre indicare che i tratti narcisistici, in particolare un senso grandioso di sé, compromettono le capacità di adattamento: «Proprio a me doveva succedere!». L’assenza di supporto psicosociale, in particolare familiare, completa la lista dei fattori di rischio associati alla psicopatologia correlata all’esposizione a un trauma di gravità estrema.
Al polo opposto rispetto alla “vulnerabilità”, nella dimensione della capacità di fronteggiare gli eventi stressanti (coping), c’è la “resilienza”, vale a dire la capacità di affrontare in maniera positiva gli eventi, di dare nuovo slancio alla propria esistenza, ripartendo magari proprio dal trauma.
Infine, come la storia di Dust Lady dimostra, dobbiamo considerare, oltre alla salute mentale, quel connubio inscindibile fra mente e corpo, fra malattia mentale e salute fisica. Molti studi sui veterani di guerra (dal Vietnam al Golfo, all’Afghanistan) hanno mostrato che il PTSD, soprattutto nella sua forma più grave, si associa ad alti tassi di malattie infiammatorie e autoimmuni, e che i soggetti esposti a traumi estremi, come gli attacchi terroristici, vanno incontro a modificazioni permanenti del DNA. Sembra quasi di intravedere l’autodistruzione della specie come meta finale inconsapevole della strategia terroristica e dell’inusitata violenza intraspecifica che la muove. Eccezionale in natura e pressoché assente nelle altre specie animali. Le modificazioni del DNA verrebbero tramandate (per via “epigenetica”) ad alcune generazioni successive, minandone la resilienza agli eventi stressanti e rendendole sempre più vulnerabili ai traumi.
IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI
Fino a non molto tempo fa, chiedendo a un nostro concittadino se il Paese partecipasse a un conflitto armato, questi, tra un messaggio sull’ultimo modello di smartphone e uno sguardo alla partita della squadra del cuore sul tablet, avrebbe probabilmente reagito con un sorriso interrogativo. Il nostro sereno cielo di carta è caduto in frantumi quando la guerra, che nella realtà dei fatti i soldati di molti Paesi europei stanno già da tempo combattendo, è entrata sbattendo la porta nel cuore pulsante della vecchia Europa, turbando la tranquilla mondanità di luci e colori con ondate di inaudito terrore. In un mondo fatto di battute rigorosamente politically correct, di filtri dedicati ai bambini per i film violenti e di dispute sull’eticità del cibarsi di carne, non c’è posto per la morte. Complici i media e la lontananza geografica dal cuore dei conflitti, si dà per scontato che le missioni, a cui i nostri Paesi pure prendono parte, non possano ripercuotersi direttamente sulle nostre vite. E se questo ci ha permesso di vivere in una pace ovattata, ha anche scoperto il fianco agli attacchi terroristici degli ultimi anni.
È stato dimostrato come l’esposizione protratta di una popolazione a situazioni critiche possa portare a una sorta di “tolleranza” (termine mutuato dalla farmacologia, che indica la riduzione della risposta a un farmaco a seguito dell’assunzione cronica). Si assiste a una progressiva diminuzione di risposta, quindi a una riduzione del rischio di sviluppare reazioni post-traumatiche in relazione a successivi traumi. Al contrario, trovarsi impreparati di fronte a un evento traumatico inatteso, provando sentimenti di impotenza e di orrore, è un fattore di rischio per lo sviluppo di reazioni maladattative non solo nelle persone direttamente coinvolte, ma in tutti i membri della stessa comunità.
Bisogna imparare a convivere con il terrorismo, così come con gli altri pericoli a cui siamo esposti e a cui siamo “assuefatti”: pensiamo, per esempio, ai viaggi in automobile, che mietono assai più vittime del terrorismo. Eppure, continuiamo a vedere una gita in macchina come un tranquillo passatempo domenicale per la famiglia, perché è un rischio con il quale siamo abituati a confrontarci. È quindi importante che i genitori informino con chiarezza i figli di quanto sta accadendo, mettendoli in guardia in merito ai rischi che si possono correre, per stimolare comportamenti protettivi (come mantenere un certo grado di vigilanza quando ci si trova in manifestazioni pubbliche o su mezzi pubblici affollati), ma evitando di trasmettere sentimenti di insicurezza e di vulnerabilità eccessivi. Esattamente come quando si istruisce un figlio su come attraversare la strada: atto, anche quello, che fa parte della quotidianità, ma che può avere conseguenze mortali, qualora non sia eseguito nel modo corretto e, talora, anche in quel caso. Sarà necessario metterlo al corrente del fenomeno del terrorismo, dello scenario geopolitico mondiale e della possibilità effettiva (seppur statisticamente improbabile) dell’occorrenza di un attacco verso cui una pronta reazione può fare più differenza di quanto crediamo.
Fondamentale, in questo clima, è non demonizzare la diversità razziale, cedendo alle lusinghe di un’illusoria sensazione di controllo con l’individuazione di un capro espiatorio. Non bisogna dimenticare che, di un’intera popolazione in condizioni di povertà e di guerra civile, solo pochissimi compiono atti terroristici. D’altronde, per definizione, l’atto terroristico può facilmente essere compiuto da chiunque, specialmente oggi. La discriminante non è tanto il gruppo sociale di appartenenza, quanto la combinazione di condizioni sociali critiche, pressioni ambientali ed elementi personologici individuali. Favorire un clima di stabilità e sicurezza è l’arma migliore per combattere, anche a lungo termine, il perpetrarsi di questi eventi.
I DUE MONDI DELLA VIOLENZA
Toronto, lunedì 23 aprile 2018. Alek Minassian lancia un furgone bianco sulla folla all’ora di pranzo, uccidendo 10 persone e ferendone 15. L’irrazionalità del gesto ripropone nell’opinione pubblica, come in altri fatti di cronaca simili, il sospetto di una patologia mentale.
Per quale motivo, infatti, uno studente di 25 anni, incensurato e non affiliato a nessun gruppo radicale – a parte uno strampalato circolo misogino di uomini che si considerano vittime di “celibato forzato” –, avrebbe più volte cercato notizie su una strage simile in California? Un profilo, a suo nome, su LinkedIn contiene un post che fa riferimento a Elliot Rodger, il ventiduenne responsabile, nel 2014, di una sparatoria a Santa Barbara, nella quale furono uccise 7 persone e ferite 14. Ex compagni di scuola riferiscono che Minassian al liceo non avesse amici, rimanesse spesso in disparte, non partecipando alla vita sociale: un “solitario”, un “disadattato”. Tutto concorrerebbe a far ipotizzare un gesto “folle”. Ma al di là dei luoghi comuni, che cosa dice la psichiatria? Si tratta di “follia” omicida?
Occorre fare un po’ di chiarezza. La violenza non è una caratteristica esclusiva della patologia mentale, ma riguarda anche molte altre situazioni che hanno a che fare con le vicende dell’umanità: guerre, occupazioni, rivoluzioni e così via. Anzi, si può affermare che la violenza riguardi la patologia mentale molto meno di quanto solitamente si pensi. Ciò va ribadito fermamente. Che le due dimensioni siano talvolta associate è innegabile: un disturbo psichico spesso può devastare l’assetto identificativo di chi ne è colpito. Fa smarrire il senso di sé, sfuma il confine con l’altro e compromette la capacità di modulare la distanza relazionale. Immette in una dimensione dove la possibilità di recuperare con la violenza quanto si sta smarrendo finisce per divenire un’opzione valida, con tutte le conseguenze del caso.
Ma, probabilmente, lo stesso fattore che porta il malato psichico alla vicinanza con la violenza (l’alterazione dei meccanismi di controllo sulle proprie azioni, la minaccia al suo assetto identificativo) non consente il “salto di qualità criminale” necessario per l’atto terroristico in senso stretto che, al contrario, richiede mente lucida, obiettivi chiari e soprattutto ottime capacità organizzative. Sono requisiti di cui il malato psichiatrico ampiamente difetta.
Recenti studi epidemiologici, condotti negli Stati Uniti, riconducono alla grande patologia mentale non più del 4% degli episodi di violenza arrivati agli “onori” (si fa per dire) delle cronache criminali. A questo dato se ne deve aggiungere un altro che propone un’evidenza ancora più marcata, ma di segno opposto: la popolazione psichiatrica è vittima di violenza in una percentuale tre volte superiore rispetto alla popolazione generale. Sempre secondo questi studi, solo il 3-4% dei pazienti con una storia di patologia mentale commette crimini penalmente rilevanti. L’altro 96-97% trascorre la propria vita senza perpetrare reati. E anche nell’ambito di questa ridotta percentuale di persone, gli episodi di violenza risultano fortemente correlati con il momento dell’acuzie, in particolare psicotica: dell’emergere clinico della patologia. Ma, anche i questi casi, si tratta di una violenza non atta a compiere un crimine di massa.
Ma allora con cosa correlano questi fatti sconvolgenti? Non con le grandi patologie mentali, abbiamo detto. Semmai sono sottesi da disturbi psichici “minori”, o meglio non caratterizzati dall’acuzie (con cronicizzazione o meno) ma dalla pervasività, quali i disturbi di personalità e, in particolare, il disturbo antisociale di personalità. Ma non basta, non siamo ancora al cuore epidemiologico del problema. Se volessimo dire cosa correla maggiormente con la possibilità di perpetrare un crimine di massa dovremmo porre in evidenza, anzitutto, dati sociodemografici: in particolare, essere maschi e giovani. Una miscela che diventa esplosiva quando si coniuga con un facile accesso a mezzi tecnici di distruzione, le armi in particolare, ma anche gli esplosivi e i veleni. Gli Stati Uniti, in questo ambito, fanno decisamente scuola e il rischio aumenta in contesti dove le armi circolano e si usano: l’ambiente venatorio, quello militare o dei frequentatori di sport che prevedono l’uso di armi. Ovvero, se si vive in un ambiente in cui la violenza è parte integrante della vita quotidiana – zone di guerra, mondo criminale, contesti sociali degradati dove la sopraffazione è una comune “risorsa” regolatrice dei conflitti interpersonali – o, ancora, se si è stati oggetto di violenza o comunque se la si è già frequentata. È come se in ciascuno di noi ci fosse una soglia a freno della violenza che, quando superata, diventa stabilmente più bassa.
Solo a questo punto entra in gioco il disturbo mentale inteso non come patologia conclamata, ma piuttosto come “fragilità” personologica, spesso non emersa precedentemente, come condizione di precaria definizione dei propri confini, in cui la possibilità dell’uso della violenza nel rapporto con la realtà si dispone stabilmente all’orizzonte esistenziale. Fatti intercorrenti, infine, possono agire da fattori scatenanti: una violenza subita, la perdita di legami fondamentali (rottura di relazioni sentimentali, di reti sociali di supporto, a cominciare dalla famiglia e dal contesto sociale di riferimento), l’instabilità abitativa, l’uso di sostanze.
VITTIME E CARNEFICI
Il meccanismo psicopatogenetico del terrorismo, ovvero il modo in cui esso danneggia sul piano psichico le vittime, non risiede tanto nella sua efferatezza, quanto nel fatto che sia sganciato da un luogo o da un tempo specifico. L’intento del terrorista è quello di mostrare che si può colpire chiunque, ovunque, in qualsiasi momento. Un attacco terroristico può ripetersi con una facilità sconvolgente, è perpetrato da uomini e donne con una precisa intenzione. È questo ad aumentare la sua presa sulle popolazioni colpite, rispetto a eventi “accidentali” come le catastrofi naturali. Siamo letteralmente bombardati da immagini e notizie allarmanti, in un pericoloso oscillare tra divulgazione e disinformazione.
Ferma restando la necessità di divulgare tutti gli aggiornamenti e i chiarimenti volti a garantire la sicurezza dei cittadini, è stato osservato che l’esposizione continua a un determinato modo di presentare le immagini riguardanti eventi che abbiano comportato morte, oppure minaccia di morte, aumenti il rischio dello sviluppo di PTSD o di sintomi da stress post-traumatico in soggetti vulnerabili, per esempio per genere o età, anche se non direttamente esposti all’evento. Potranno esserci anche solo sintomi isolati, quali ipervigilanza, perdita di speranza, senso di insicurezza e instabilità e preoccupazione per il futuro proprio e dei propri figli. Con la probabilità che, passata la corsa alla notizia – mossa anche dall’interesse di vendere quel giornale o aumentare l’audience di quel programma –, si spengano i riflettori, affinché salgano gli ascolti della nuova serie che passa in televisione. Riconducendoci alla nostra condizione di tranquilla indifferenza.
Ma le popolazioni esposte a eventi traumatici sono maggiormente a rischio anche di sviluppo di sintomi depressivi, di abuso di alcol e sostanze e di disturbi bipolari e psicotici. Sono possibili anche ripercussioni sul piano politico e sociale: è nota infatti, nella letteratura scientifica, una correlazione tra la percezione di una potenziale minaccia per la propria vita a causa di atti terroristici – anche in casi di basso pericolo effettivo – e la tendenza ad abbracciare ideologie politiche radicali, oltre all’incremento del pregiudizio verso le minoranze etniche. Qual è l’atteggiamento che ci espone di meno a rischi? Consapevolezza e valutazione attenta, senza alimentare inutili allarmismi e senza scadere in un’irrealistica convinzione di invulnerabilità.
Un’altra sfida, forse la più difficile, è quella con cui ci dobbiamo confrontare quando siamo chiamati a interrogarci sulle cause ambientali. Comunemente si parla di fondamentalismo religioso; ma la religione, a ben vedere, c’entra assai poco. Più utile come criterio di interpretazione può essere considerare lo studio delle cause economiche, politiche e sociali dei conflitti. Un nutrito numero di articoli scientifici esprime la difficoltà di considerare il terrorismo un comportamento ascrivibile a una psicopatologia in atto, evidenziando la capacità, da parte di questi individui, di portare avanti progetti con pianificazioni sofisticate e la convinzione di compiere un “sacrificio” in favore della propria comunità e non un “suicidio”: sono due categorie, queste, non sempre sovrapponibili. D’altra parte, è stato anche messo in luce come alcuni tratti personologici, in specifici contesti sociali, possano predisporre a tali comportamenti. Sensitività interpersonale, instabilità emotiva, esposizione come vittime a traumi e violenze, deficit di empatia (come nei disturbi antisociale e narcisistico) possono essere un elemento chiave per l’aderenza a un gruppo e per la suscettibilità alle pressioni da parte della comunità di appartenenza, magari sotto la guida di un leader carismatico.
Tratti paranoidi completano l’identikit del terrorista, come tendenza alla sospettosità in relazione a minacce ai danni del proprio nucleo. Se incentivati dall’ambiente esterno, magari a seguito di un’opera di condizionamento intenzionale, tali tendenze possono facilmente mutarsi in convinzioni incoercibili. In quest’ottica, atti ai danni di una popolazione considerata nemica in ogni suo singolo individuo possono apparire a chi li intraprende come l’unica via d’uscita, anche a costo della propria vita. In una simile interpretazione, comunque non esaustiva, che prevede una complessa interazione tra aspetti personologici e fattori ambientali, queste azioni diventano più comprensibili, pur rimanendo ovviamente inaccettabili sul piano etico. Dal punto di vista clinico, oltre ai punti sopradescritti, anche il venir meno dell’istinto di autoconservazione alimenta il sospetto di possibili fattori psicopatologici in gioco, sebbene il sacrificio del singolo per la salvezza del gruppo resti un comportamento evolutivamente attestato. In questo contesto, la spinta religiosa può fornire un elemento in più, pesando sul piatto della bilancia, attraverso la falsa credenza che la morte a cui si va incontro non sia definitiva.
ANATOMIA DEL TERRORE
Conclusi i cosiddetti “anni di piombo” (anni Settanta del secolo scorso), il terrorismo sembrava riguardare marginalmente la nostra società. Recentemente, il progressivo aumento della frequenza degli attacchi terroristici “a casa nostra” ha fatto sì che generazioni che non avevano mai conosciuto questo fenomeno, se non per le notizie provenienti dal Medio Oriente, si siano dovute confrontare con comportamenti tra i più abietti che l’uomo possa porre in essere, ovvero l’uccisione indiscriminata e la tortura di persone innocenti. Nella nebbia e nell’incertezza, l’ultimo attentato effettivamente rivendicato (e confermato) su suolo europeo è quello del mercatino di Strasburgo del dicembre 2018, mentre più di recente si sono inten...