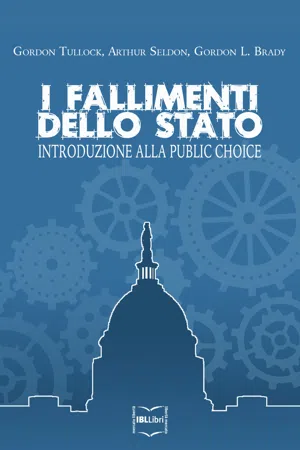![]()
Capitolo 1. Le persone sono persone: i principi della Public choice
L’homo politicus e l’homo economicus sono la stessa cosa. L’implicazione cruciale di questo presupposto d’interesse personale universale è che le differenze che si osservano fra scelte pubbliche e scelte private emergono non perché gli individui adottano diversi obbiettivi comportamentali nei due contesti, quanto piuttosto perché sono diverse le limitazioni sul comportamento. Esiti diversi emergono non perché le scelte pubbliche siano guidate da logiche diverse da quelle che guidano le scelte private, quanto piuttosto perché nei mercati privati elettori e politici che perseguono entrambi i propri interessi operano delle scelte che ricadono principalmente su loro stessi, mentre nei mercati politici, elettori e politici che perseguono il proprio interesse operano delle scelte che ricadono principalmente su altri.
Fred S. McChesney - William F. Shughart II, The Causes and Consequences of Antitrust: The Public choice Perspective
Attori politici e interesse pubblico
La Public choice si propone di analizzare scientificamente la condotta dello Stato e, in particolare, la condotta degli individui che ricoprono posizioni pubbliche “di governo”. Per essere precisi, non ha alcuna implicazione per quanto riguarda il merito delle politiche, se non che in alcuni casi può dimostrare l’impossibilità o l’improbabilità che una politica specifica raggiunga gli obbiettivi dichiarati. Per esempio, chi ha familiarità con la Public choice non rimarrà particolarmente impressionato da una politica di “massimizzazione dell’interesse pubblico” e riconoscerà la difficoltà di ottenere libero scambio o un bilancio in pareggio in un periodo di alcuni anni. Capirà subito che porsi questi obbiettivi è un po’ come dire al pilota di un Boeing 747 di arrivare a Londra prima di un Concorde.
Fino all’epoca di Adam Smith (1723-1790){1} la gran parte del dibattito “politico” era essenzialmente di natura morale. Agli individui – che fossero uomini d’affari, funzionari pubblici, politici o monarchi ereditari – veniva detto quale era la cosa moralmente corretta da fare e venivano esortati a farla. Si presupponeva che tutte queste persone fossero dedite, e forse lo erano davvero, alla massimizzazione dell’interesse pubblico. Machiavelli (1469-1527){2} e Hobbes (1588-1679){3} furono delle grandi eccezioni a questa regola; ciò nonostante, in entrambi i casi la loro influenza fu molto minore di quanto possa far pensare il loro seguito di lettori. La gran parte dei loro lettori ritenne che stessero peccaminosamente argomentando contro la moralità e non che stessero proponendo un sistema scientifico essenzialmente amorale.
David Hume (1711-1776){4} fu il primo a produrre delle crepe significative in questo approccio monolitico. Egli sostenne l’idea piuttosto ovvia per cui la maggior parte delle persone nelle proprie azioni persegue il proprio interesse e non un interesse pubblico generale, e in numerosi saggi applicò questa linea di ragionamento all’economia. Dei precursori di questo approccio si possono ritrovare sia nel pensiero europeo che extra-europeo. Eppure, fino all’epoca di Hume e del suo amico Adam Smith, la visione prevalente della natura umana e del governo mostrava come predominante l’approccio moralistico, o dell’interesse pubblico. Adam Smith diede il via all’economia moderna presupponendo che gli individui fossero in grandissima misura mossi dall’interesse personale e calcolando le conseguenze di questo presupposto in campo economico. Nel suo La ricchezza delle nazioni, pur mantenendo il modello moralistico o legato all’interesse pubblico, dedicò tre capitoli alla questione del governo.
A partire dall’epoca di Platone (428-347 a. C.){5} e Aristotele (384-322 a. C.){6} la scienza della politica era stata considerata semplicemente una questione di formulazione di misure politiche moralmente corrette. L’affermazione di Leo Strauss (1899-1973){7} per cui la scienza politica era «la scienza del giusto agire» era estrema, ma non atipica. Non esisteva alcuna teoria formale sulle modalità di funzionamento del governo al di fuori di tali fondamenti morali ed etici.
Per tutto il XIX secolo e per molta parte del XX, però, gli economisti supposero che gli individui fossero concentrati principalmente sul proprio interesse e analizzarono le conseguenze di tale presupposto. Diversamente, in questo stesso periodo la scienza politica partiva principalmente dal presupposto contrario, cioè che gli attori politici avessero come proprio motore principale l’interesse pubblico. Così, si presume che, quando entrano in un supermercato, gli individui acquistano prodotti di loro scelta, mentre quando entrano nella cabina elettorale non votano per quei politici o per le leggi che possono beneficiarli, ma per politici e leggi che beneficiano la nazione nel suo complesso. Al supermercato la gente compra principalmente gli alimenti e gli altri prodotti che, a un dato prezzo, ritiene utili per sé e per la propria famiglia.{8} Eppure, quando questi individui diventano dei politici, si ritiene avvenga una trasformazione: sarebbe una prospettiva più ampia a guidarli nel prendere delle decisioni moralmente corrette, e questa prospettiva non farebbe a loro imboccare la strada che compiace i gruppi d’interesse che li hanno sostenuti, né perseguire le politiche che possano favorire la loro rielezione.
La duplice visione del comportamento umano
Gli economisti hanno corretto questa duplice visione del comportamento umano sviluppando la teoria della Public choice, la quale, sostanzialmente, equivale a trapiantare la struttura analitica generale dell’economia nel campo delle scienze politiche. Affermare che l’elettore nella cabina elettorale è la stessa persona che agisce da consumatore nel supermercato non sembra qualcosa di radicale, ciò nonostante rappresenta un cambiamento enorme nella letteratura delle scienze politiche. Anzi, l’autore stesso di questa parte spesso è stato condannato pubblicamente e con gran vigore da studiosi di scienze politiche per aver espresso questa visione nei vari convegni scientifici.
Questa scissione della psiche individuale è particolarmente impressionante quando ci si ricorda che si può dimostrare come il sistema economico, che si basa su presupposti di interesse personale, possa produrre dei risultati non del tutto in disaccordo con le idee classiche sull’interesse pubblico. Fino a pochissimo tempo fa, comunque, non esisteva alcuna prova del fatto che lo Stato potesse generare un risultato in accordo con le idee classiche dell’interesse pubblico. Anzi, la prima dimostrazione del fatto che il governo potesse tendere a generare un risultato in un certo senso ottimale venne da persone che applicarono dei presupposti economici al comportamento politico. Posto che le persone intraprendono sia attività di mercato sia attività politiche, il presupporre che il loro comportamento segua le stesse logiche motivazionali in entrambi i settori sembra cosa semplice. In effetti, è piuttosto difficile comprendere come la duplice visione del comportamento individuale possa essersi protratta così a lungo. Eppure, è stata, e resta, la visione dominante. Ovviamente, la conferma empirica di qualsiasi ipotesi teorica è più importante dell’eleganza analitica. Quando si esamina il comportamento di un singolo individuo, la gran parte delle persone capisce che il politico agisce in modo interessato; allo stesso modo, quando si esaminano i fattori che condizionano il voto, la gran parte delle persone dà per scontato che il beneficio personale sia un aspetto sicuramente significativo.
In una società democratica, il politico si guadagna da vivere vincendo le elezioni. Questa osservazione piuttosto semplice e ovvia sembra essere sfuggita ai primi studiosi di questioni riguardanti il governo di un paese. Per citare un aforisma americano: «Per essere un grande senatore, per prima cosa uno deve essere un senatore». In altre parole, le persone che eleggiamo a una determinata carica sono lì perché sono state brave a farsi eleggere. Il fatto che debbano sottoporsi a una valutazione periodica rende, sotto molti punti di vista, i politici simili alle persone che si occupano d’affari. Proprio come una persona che opera in ambito economico progetta, per fare un esempio, una nuova automobile che possa attrarre i consumatori, così il politico sceglie delle misure con l’idea che il consumatore, che è l’elettore, lo possa premiare nella successiva tornata elettorale. Non c’è nessuno che consideri quest’attività come una questione di assoluto tornaconto personale, ma resta comunque vero che, in generale, la politica non è affatto l’esercizio di un qualche elevato principio morale. I politici, come gli uomini e le donne che operano nel mondo degli affari, si troveranno a volte a dover pagare un prezzo (la perdita di consenso elettorale) per fare ciò che ritengono giusto, ma nel complesso ci si può attendere che agiscano in modo da massimizzare il proprio interesse personale in termini di prospettive di rielezione. Per dirla in modo diverso, i politici, come gli imprenditori, perseguono quelle politiche che ritengono la gente voglia, perché sperano che la gente li ripaghi con il voto. Non è una cattiva approssimazione dire che in questo sistema sono gli elettori che effettivamente governano. Né, dal punto di vista della democrazia, si tratta di un qualcosa di particolarmente indesiderabile.
La politica e il problema dell’informazione
Nell’esaminare le conseguenze di questa visione della “cosa pubblica” ci si imbatte in un problema specifico: gli economisti hanno basato le loro previsioni sul concetto che i consumatori e gli operatori di un mercato siano perfettamente informati.{9} Purtroppo, nel caso della politica, il problema dell’informazione è molto più grave che all’interno di singoli mercati. Si prenda in considerazione il seguente esempio sugli incentivi comportamentali privati che intervengono in una scelta di mercato. Nell’acquistare un’automobile, io investo una certa quantità di tempo e risorse nell’apprendere determinate cose sulle novità automobilistiche, per la semplice ragione che so che un mio errore condizionerà in maniera diretta me e il mio portafoglio, la mia convenienza e la mia comodità.
Ma quando voto per scegliere il presidente degli Stati Uniti, so che il mio voto è uno su diverse decine di milioni, e che è altamente improbabile che influenzi il risultato finale dell’elezione. Ci si può aspettare che questa consapevolezza condizioni il valore che do al mio voto, e le risorse che investirò nel raccogliere le informazioni necessarie a compiere una scelta “giusta”. Questo insieme di incentivi implica che i politici, che cercano di scegliere delle politiche che attraggano gli elettori, sono consapevoli del fatto che gli elettori dedicheranno molte meno energie al cercare di fare la scelta giusta rispetto a quante ne impiegherebbero per acquistare un’automobile o un qualche altro prodotto i cui difetti e pregi ricadono solo su di loro. Quindi, è probabile che gli elettori siano mal informati, e che possano favorire un politico o delle misure direttamente contrarie ai loro interessi. Dal punto di vista del singolo candidato, ciò che è importante è quello che vuole la gente, data questa percezione del valore del proprio voto rispetto al risultato e dato il costo dell’informazione, e non quello che la gente vorrebbe se fosse meglio informata.
Lo stesso è vero anche per chi progetta un’automobile, ma costui sa che i propri clienti saranno informati, se non perfettamente, per lo meno meglio di un elettore. Per dirla brevemente, quando compro una macchina, ottengo un ritorno positivo sull’informazione supplementare, perché essa migliorerà la mia scelta. È nel mio interesse cercare di evitare frequenti e costose riparazioni, o l’inconveniente di rimanere bloccati in un’autostrada fredda e solitaria in attesa di un carro attrezzi. Chi progetta un’automobile lo sa, e quindi crea delle auto con l’intenzione di attrarre dei consumatori ragionevolmente informati. Quando voto sono invece consapevole del fatto che il mio voto non avrà praticamente nessun effetto sul tipo di politiche scelte. Questo avviene perché le politiche e i politici scelti saranno determinati in misura molto maggiore dai voti di altri. I politici lo sanno e di conseguenza tentano di elaborare delle politiche che attraggano elettori male informati.
Questa limitata informazione su argomenti generali, però, contrasta con la migliore informazione che la gran parte delle persone ha in merito a misure politiche specifiche. Si prendano in considerazione i seguenti esempi: gli agricoltori sanno molte cose sui sussidi all’agricoltura e sulle limitazioni all’estensione delle aziende (negli Stati Uniti e in Europa); operai e manager sono ben informati sulle restrizioni alle importazioni di merci in diretta concorrenza con quelle da loro prodotte. Questa tendenza all’informazione asimmetrica porta all’emergere di specifici gruppi d’interesse e incoraggia i politici a prestare loro attenzione.
Governo democratico contro governo non democratico
A questo punto è importante dare un avvertimento. In questo libro discuteremo in forma estesa dei difetti del governo della “cosa pubblica” in un sistema democratico, tuttavia questa discussione non implica che si conosca una maniera migliore per affrontare i problemi. L’inquinamento dell’aria è un problema che di solito viene affrontato in modo inefficace dallo Stato, ma qualsiasi cosa si possa dire sulle misure di controllo e tutela della qualità dell’aria che esistono oggi, potrebbero essere una soluzione migliore del lasciare la questione dell’inquinamento atmosferico al mercato. L’esperienza di forme di governo non democratiche indica che, rispetto alla democrazia, esse generano risultati meno desiderabili. Come conseguenza, abbiamo una forma di governo che è lontana dall’essere ciò che vorremmo davvero, ma fino a quando non se ne inventerà una nuova e migliore, faremmo meglio a tenercela, malgrado i suoi difetti. Ciò nonostante, dovremmo essere pienamente consapevoli delle difficoltà e delle inefficienze che ci possiamo aspettare dallo Stato. Lo scopo di questo libro, però, è più limitato: noi ci chiediamo cos’è la Public choice e che differenza fa per la comprensione dei processi democratici l’applicazione delle sue teorie.
Lasciare tutto al mercato?
Chi studia la Public choice è diverso dagli altri? Se sì, perché? Per cominciare, dovremmo chiederci perché abbiamo uno Stato che ci governa. Il mercato produce molte cose con notevole efficienza, e allora perché non lasciare che sia il mercato a occuparsi di tutto, come raccomandano economisti quali Murray Rothbard (1926-1995)? La risposta standard a questa osservazione rimanda a Hume, ma in epoca moderna è associata a nomi di economisti come A. C. Pigou (1877-1959) e Paul A. Samuelson (1915-2009). Il problema è essenzialmente tecnologico. Il mercato richiede un qualche sistema di diritti di proprietà in virtù del quale agli individui viene allocato il potere su vari aspetti del mondo reale. Gli individui che detengono delle “proprietà” colgono l’opportunità di migliorare il proprio benessere entrando in diversi tipi di accordi con gli altri (come, ovviamente, tramite il proprio lavoro individuale), ottenendo così dei miglioramenti della propria condizione socio-economica. Purtroppo, in qualsiasi allocazione di diritti di proprietà a noi nota, il numero di persone che deve essere d’accordo a volte è molto vasto e per di più (e questa caratteristica è molto importante), all’inizio dell’analisi non si sa quale sia il gruppo speci...