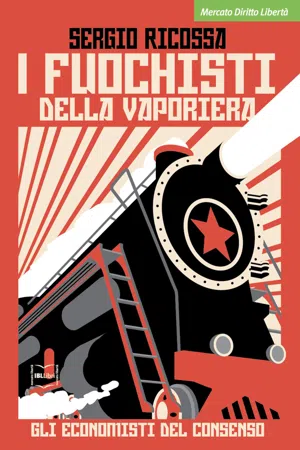![]()
1. La moda liberale
Mode
Gli storici dell’economia dividono la loro materia secondo le scuole: scuola classica, per esempio, o scuola neoclassica. La mia materia, che è il contributo dell’economia all’evoluzione del costume in Italia negli ultimi trent’anni, ammette una divisione più frivola, una divisione secondo le mode.
Il succedersi delle mode scientifiche segue forme regolari, che William James{57} studiò tempo fa. La “legge di James” sostiene che ogni nuova dottrina scientifica di una certa importanza attraversa tre fasi. Nella prima, subisce gli attacchi dei benpensanti, che la dichiarano assurda. Nella seconda, è riconosciuta vera, ma banale. Nella terza, trova tutti d’accordo sulla sua importanza, e ciascuno convinto di averla presagita e promossa. Spesso si manifesta una quarta fase. La dottrina passa di moda, è ripudiata, e si citano la prima e la seconda fase per dimostrare che fin dal principio si era capito tutto.
Questo non riguarda solo gli scienziati. Il grosso pubblico avverte i contraccolpi, e li avverte di più se si tratta di una scienza sociale come l’economia. Non per niente, il nostro tempo è imbevuto di economicismo. Ma il collegamento tra le teorie economiche e gli umori popolari è ovviamente bizzarro. Il messaggio parte dall’inventore delle teorie, passa attraverso l’economista alla moda, il conferenziere, il professore di scuola, il giornalista, il politico, il sindacalista, il predicatore, l’amico col quale si chiacchiera al caffè, il collega d’ufficio, e giunge distorto, talvolta irriconoscibile, al consumatore finale.
Di tutti gli intermediari, il più pericoloso è l’economista à la mode. L’economista à la mode è sempre esistito. Durante il fascismo il suo problema era relativamente semplice. Egli doveva essere corporativo. Il corporativismo minimo consisteva nel cambiare copertina ai propri libri scritti in passato. Qualunque fosse il vecchio titolo, il nuovo titolo bisognava che diventasse: Economia corporativa. Tutto il resto poteva permanere come prima. Il regime non esigeva granché: vivendo di facciate, si contentava di copertine. Gli economisti dissidenti ebbero le peggiori persecuzioni sul tardi: ma furono persecuzioni razziali, che poco o nulla riguardarono l’economia. La forma del naso era considerata più importante della forma del pensiero. Raramente l’entusiasmo spingeva oltre il corporativismo minimo; mai pervenne a un’opera di economia corporativa degna di restare nella storia della scienza. Quasi mezzo secolo dopo, l’eredità è una sola: la degenerazione semantica dell’aggettivo “corporativo”, col quale bollare d’infamia tutto quel che non piace ai nuovi economisti à la mode. “Sciopero corporativo”, per esempio: cioè sciopero sospetto di fascismo, o di medievalismo, di fascismo medievale, o di medievalismo fascista; quindi, sciopero promosso da sindacati autonomi irresponsabili, non da Cgil, Cisl e Uil.
Le mode cambiano. Alla moda corporativa succedettero la moda liberale (un revival), la moda keynesiana (importata di seconda mano), la moda della programmazione o della riforma di struttura, la moda sindacale o della variabile indipendente. La moda di oggi{58} è l’economia eurocomunista: può darsi che duri ancora quando queste pagine saranno finite. Le ultime tre, forse le ultime quattro mode sono “di sinistra”, secondo i loro seguaci. In Italia, le mode “di destra” non esistono, da vive. Da morte, sì: sono tutte quelle che “gli avversari cercano inutilmente di resuscitare”.
Intendo dimostrare che le suddette quattro mode “di sinistra” sono popolari e antipopolari al tempo stesso. Più sono popolari e più sono antipopolari (non impopolari). Voglio dire che più piacciono al popolo, e più il popolo rischia di pagarle care, senza accorgersene. Ma prima di vederne gli effetti, cerchiamone le cause. Come è morta la moda liberale? Come e perché è avvenuto il passaggio dalle generazioni degli economisti liberali alle generazioni degli economisti eurocomunisti?
Patriottismo
Dopo la seconda guerra mondiale, il sinistrismo si diffuse come una ruggine rossa su tutta la cultura italiana. Corrose la filosofia, la storia, la sociologia, tutte le discipline umanistiche. Niente più era antiruggine. Venne una linguistica di sinistra, una geografia di sinistra, una fisica di sinistra. La grammatica, la latitudine e la longitudine, il chilowattora e l’elettrone dovettero arrendersi e farsi reinterpretare. Si vedevano solo con gli occhiali marca Marx. Altrimenti si vedeva nulla, la realtà scompariva.
L’economia resistette al sinistrismo più a lungo di quasi tutte le altre scienze. Questo perché da noi l’economia era una retorica, prima che una scienza. Grazie agli economisti liberali, si identificava con l’unica epopea nazionale disponibile, che neppure il fascismo aveva veramente interrotto. Era l’Italia Unita, era il Risorgimento, Cavour, la lotta contro le forche austro-ungariche. Il nostro Ottocento intendeva la libertà economica come libertà politica, e la libertà politica come affrancamento dallo straniero. Francesco Ferrara{59} scriveva libri di economia contro i tiranni. Il suo credo era che il despota transige col demagogo, ma non perdona all’economista (liberale). L’ignaro Adam Smith era per noi un cannone puntato contro Radetzky. La confusione era tale, che i nostri migliori economisti in potenza non fecero affatto gli economisti. Furono traviati dalla politica: Cavour, appunto, e anche Cattaneo, Pellegrino Rossi,{60} Minghetti.
Perciò ancora nel 1950 era difficile incontrare economisti che non fossero liberali, e che non intendessero rimanerlo fino alla morte: per patriottismo. Si aggiunga che costoro, benché retori, erano retori di buon senso, genuini, senza borie intellettuali. Tra la semplicità e la complicazione, sceglievano sempre la semplicità, senza tema di passare per superficiali. In ciò si distinguevano dai crociani, i quali, per dire due più due fa quattro, scrivevano (la malignità è di Soffici{61}): «La metà di sedici previamente diviso per il doppio di una unità è uguale al prodotto della somma di due unità moltiplicate per il totale risultante dall’addizione di quattro mezze unità».
Il massimo economista italiano, Vilfredo Pareto (liberale, ovviamente), uno dei pochissimi che continui a essere citato in tutto il mondo, aveva polemizzato col “marxista” Croce. Infine si era accorto che era inutile: per discutere bisogna già essere d’accordo, mentre Pareto non riusciva nemmeno a capire la lingua di Croce, e viceversa. In una lettera di Pareto a Croce si legge: «Noi siamo a due opposti poli, e parliamo persino lingue diverse. [...] Per me i concetti e i vocaboli sono secondari di fronte alle cose che indicano, per voi sono principali, sono signori delle cose, anzi sono le cose stesse».
Ebbene, il fondamento del marxismo economico, come vedremo, è proprio quello di fare i vocaboli “signori delle cose”. Pareto aveva vaccinato gli economisti italiani contro il marxismo. Tutti erano paretiani, talvolta fino all’imitazione stucchevole (il cosiddetto “paretaio”). Se non proseguivano le tecniche matematiche di Pareto, alquanto difficili, ne proseguivano lo spirito politico e il gusto empirico. È il caso di Luigi Einaudi, il più famoso dei continuatori, ma più grande politico e grande moralista, che grande tecnico scientifico.
Il liberismo e il liberalismo erano un galateo di vecchio stampo. Lo si rispettava per non fare la figura del maleducato. Era lo stesso galateo dei nonni e dei padri, era una cosa di famiglia. Insegnava che, contrariamente al proverbio, è meglio una gallina domani che un uovo oggi. Ma chi preferisce una gallina domani a un uovo oggi è ipso facto capitalista. Fare il capitalista era perciò dovere di tutti. Non fare il capitalista era scialacquare. Il lavoratore virtuoso doveva lavorare per risparmiare e divenire capitalista anche lui. Solo così, diventando proprietario, avrebbe potuto fortificare la sua indipendenza di individuo. Solo così, con la pena di oggi per un futuro migliore, avrebbe fatto il suo dovere verso i figli e i nipoti.
L’orizzonte temporale era lontanissimo. Le incertezze della vita non sconsigliavano di fare calcoli economici con scadenze di trenta, cinquant’anni, un secolo. La moneta abbastanza stabile non aveva ancora trasformato l’economia in un casino da gioco. Si era disposti a piantare adesso la quercia perché i nipoti ne godessero l’ombra due generazioni dopo. Le famiglie erano unite, o si supponeva che dovessero esserlo. Accumulare “per la famiglia” era fare cosa sacrosanta, fino al punto che tutti chiudevano un occhio sulle accumulazioni macchiate da qualche prepotenza. L’importante era non godersela, la ricchezza, ma continuare a investirla e accumularla (un ideale che oggi è rimasto all’Unione Sovietica, benché fuori dalla famiglia).
Le virtù e i vizi erano misurati col metro della civiltà contadina: tutti poveri, ma tutti capitalisti, tutti col proprio pollaio, il proprio aratro, il proprio campicello, la propria cascina. I valori solidi erano quelli agricoli; degli altri, si diffidava. Il borghese avventuratosi nel commercio o nell’industria si affrettava a riversare i guadagni nell’agricoltura, appena possibile. Il suo grado di successo era dato dagli ettari di terra che riusciva a comperare. II proletario rispettabile non ambiva che a diventare borghese egli pure, e a quel modo. Veniva dalla campagna, desiderava ritornarci. Le “lotte del lavoro” erano guardate con simpatia dai borghesi, purché mirassero all’“elevazione”, cioè all’imborghesimento del proletario. Ma l’elevazione era una conquista individuale, non di classe. Non era un diritto, era un dovere. Non poteva venire in regalo dai politici, dagli “avvocati”. Scriveva Einaudi: «Troppi avvocati, troppi politicanti, troppi uomini abili, accomodanti, soluzionisti, hanno rovinato il movimento operaio italiano».
Si aveva una sana diffidenza contadina verso “il dottrinario” loquace: «Egli non ragiona sul fondamento dei dati da lui conosciuti e della tanta o poca capacità di raziocinio ricevuta alla nascita da madre natura e perfezionata collo studio e colla esperienza. No. Prima di studiare egli sa già quel che deve dire». Dove si vede che Einaudi, come tutti, allora, credeva che madre natura ci facesse diversi alla nascita: un fatto non più accettato dai tanti egualitaristi d’oggi. La violenza faceva inorridire: «Chi vide, raccapricciando, nel 1919 e nel 1920, le folle briache di saccheggio e di sangue per le vie delle grandi città italiane, non riconobbe i figli di quegli uomini, che dal 1890 al 1900 nascevano alla vita collettiva, comprendevano la propria dignità di uomini ed erano convinti di dover rendersi degni dell’alta meta umana a cui aspiravano» (Einaudi scrisse e Gobetti{62} pubblicò).
La violenza non era assolutamente necessaria. Lavoratori e borghesi dovevano stare dalla stessa parte. «Dopo un secolo di predicazione sociale rivolta contro il bersaglio sbagliato di una inesistente lotta fra lavoratori e capitalisti, è giunto il momento nel quale i lavoratori e i risparmiatori, falsamente denominati proletari e capitalisti […] comprenderanno la necessità di rivolgere i loro colpi contro i restrizionisti, contro i monopolisti, contro gli uomini delle combinazioni e delle formule». Einaudi scriveva queste parole quando era già presidente della Repubblica. Si illudeva ancora che lavoratori e capitalisti, o risparmiatori, scoprissero quanto «in fondo al loro animo c’era di comune, l’amore al lavoro compiuto, l’orgoglio del capolavoro, il desiderio di metterlo al mondo perfetto».
Migrazioni
Einaudi morì nel 1961, in tempo per non vedere tutto lo sconquasso recato alla sua morale dalla prima vera industrializzazione, dalla prima vera prosperità dell’Italia. La voglia del lavoro ben fatto stava per volatilizzarsi come neve al primo soffio di scirocco. Nel 1947 gli italiani avevano ancora fiducia in lui perché erano magri e laceri, senza riparo dalla tramontana. Poiché avevano creduto in lui, furono guariti (provvisoriamente) dall’inflazione. La politica antinflazionistica di Einaudi fu appena un placebo, ma bastò. Claude Bernard{63} era solito iniziare il suo corso di lezioni dicendo: «Signori, la medicina scientifica, che ho il dovere di insegnarvi, non esiste». Si può dire lo stesso della politica economica. Che scienza è, o che applicazione di scienza è, se gli effetti dipendono dalla credibilità di chi la applica? La lira fu salva perché il salvatore era credibile. Era all’antica, era onesto, era il ritratto della parsimonia. Al Quirinale – si sarebbe poi detto – serviva agli ospiti mezza pera, per timore che una intera fosse troppa.
Le stesse misure antinflazionistiche, adottate da un socialista con la fama di avere le mani bucate, sarebbero fallite. Forse avrebbero accresciuto il male. Talvolta il politico ha il problema di quale economista scegliere, fra i diversi disponibili e che dicono cose diverse. È un problema analogo a quello della scelta del medico. Pio II,{64} quando prese la peste a Basilea, fu informato che sulla piazza c’era un medico sapientissimo, ma sfortunato, e un medico ignorante, ma fortunato. Egli scelse quello fortunato, e guarì. L’economista più adatto, invece, è quello con la faccia più convincente, più intonata alla parte. Nello spiegare il primato economico europeo della Germania federale bisognerà tenere conto indubbiamente del bel faccione di Erhard,{65} aureolato perennemente dal fumo del suo potentissimo sigaro, simbolo di opulenza.
Senonché la faccia di Einaudi andava bene per un paese di poveri contadini, non per un paese di operai toccati dal “miracolo economico”. Uno dei maggiori artefici di quel “miracolo” era destinato dunque all’incomprensione, all’ingratitudine della sua stessa creatura. Molti a quel tempo pensavano che il benessere fosse il nemico del comunismo e l’amico del liberalismo. E invece, no. È vero che il comunismo è il nemico del benessere, ma non è vero il reciproco. Se il benessere segue l’industrializzazione, anche il comunismo segue. Il comunismo si nutre di fumo delle ciminiere. Senza la rivoluzione industriale, tra il Settecento e l’Ottocento, Marx sarebbe stato un pastore senza pecore. Orbene, in un decennio, il decennio del “miracolo economico”, l’Italia si convertì dall’agricoltura all’industria, dalla civiltà agricola alla civiltà industriale. Non fu un salto di qualità, fu un salto di civiltà.
Le campagne si spopolarono, le città si gonfiarono fino a scoppiare. Milioni di meridionali salirono al Nord, verso le fabbriche: il Nord fu “meridionalizzato”. Ancora nel 1950, gli operai dell’industria erano appena la metà dei contadini. Nel 1970 erano il 20 per cento più dei contadini. Alla luce di queste cifre, l’aumento dei voti comunisti non può sorprendere; caso mai, sorprende che sia stato tanto modesto. Infatti, da come l’industrializzazione avvenne, da come fu rapida e selvaggia, i comunisti avrebbero potuto trarre ben altri vantaggi.
Non era la prima volta che si verificava un fenomeno del genere nel mondo. Sempre l’industria nascente suscita ondate di migrazione. Perché l’industria vuol dire le macchine, e le macchine sono le calamite, non le calamità dei lavoratori. Le macchine non creano i disoccupati, come vuole la leggenda. Esse creano i posti di lavoro, e li creano in tale quantità che gli abitanti del luogo non bastano. I lavoratori devono accorrere da dove le macchine non ci sono a dove ci sono. La prima industrializzazione in Gran Bretagna aveva fatto convergere verso le fabbriche tutti i poveri sparsi nelle campagne, fin dall’Irlanda. Gli Stati Uniti, per diventare il massimo paese industriale del mondo, richiesero che milioni e milioni di emigranti traversassero l’Atlantico. Do...