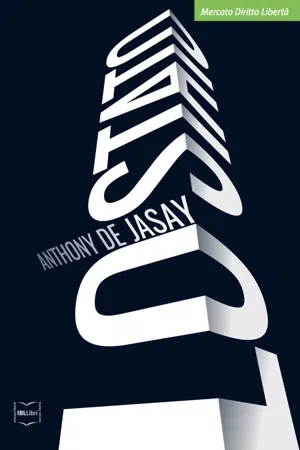![]()
Capitolo 1. Lo Stato capitalista
Violenza, obbedienza, preferenza
La preferenza per un sistema politico dato dipende dalla concezione che gli individui hanno del proprio bene, nonché dal sistema politico che è preferibile.
Gli Stati generalmente hanno inizio con la sconfitta di qualcuno.
“L’origine dello Stato è la conquista” e “l’origine dello Stato è il contratto sociale” non sono due spiegazioni incompatibili. Una tratta delle origini dello Stato nella storia reale, l’altra della sola deduzione logica. Entrambe possono essere contemporaneamente valide. La ricerca storica potrebbe dimostrare che, nella misura in cui possiamo comprendere queste cose, l’albero genealogico della maggior parte degli Stati risale alla sconfitta di un popolo da parte di un altro; più raramente all’influsso di un capo vittorioso e del suo gruppo di guerrieri sul proprio popolo; e quasi sempre in seguito a una migrazione. Nello stesso tempo, assiomi ampiamente condivisi ci aiuteranno a “stabilire” (in un altro senso) il fatto che delle persone razionali, nel perseguire il proprio bene, ritengano vantaggioso sottomettersi a un monarca, a uno Stato. Poiché questi due tipi di spiegazione dello Stato si riferiscono a due categorie non correlate, è inutile tentare di metterle in relazione o dare priorità all’una o all’altra. Né ha senso dedurre che, poiché gli Stati si sono formati e sono prosperati, sottomettersi a essi debba essere stato un atto razionale compiuto da individui che perseguono il proprio bene; altrimenti avrebbero combattuto prima di arrivare a farlo.
Consideriamo da questo punto di vista un ben noto tentativo di riconciliare l’origine (storicamente) violenta dello Stato con la volontà razionale del soggetto che è implicita in ogni analisi del genere del “contratto sociale”.{7} Qualsiasi persona che viva nello stato di natura stima, da un lato, tutti i guadagni futuri che potrebbe avere nello stato di natura e, dall’altro, stima tutti i guadagni futuri che otterrebbe vivendo in una società civile dotata di uno Stato. Si ritiene che il secondo termine di paragone sia più vantaggioso, ma le due stime devono essere rapportate alla situazione presente. Serve tempo per far sì che tutti decidano a favore del contratto sociale, che permette il passaggio dallo stato di natura alla società civile. I guadagni elevati derivanti dalla creazione dello Stato appartengono quindi al futuro e, al momento, il valore presente del fatto che essi superano i guadagni dello stato di natura è ridotto. Questo perciò potrebbe non essere un incentivo sufficiente a convincere tutti ad accettare il contratto sociale.
D’altra parte, si può creare velocemente uno Stato per mezzo della violenza. I grandi guadagni generati dall’esistenza dello Stato iniziano così ad arrivare velocemente (senza diminuire di molto se tradotti nel valore attuale). Il confronto tra il valore attuale dei guadagni in uno Stato formatosi lentamente con la negoziazione pacifica di un contratto sociale e i guadagni di uno Stato entrato a far parte della società attraverso la scorciatoia della violenza, penderà naturalmente a favore della violenza. Così, ci possiamo aspettare che l’individuo razionale che mira a massimizzare i propri guadagni accetti di buon grado la violenza perpetrata da chiunque voglia introdurre lo Stato, o ricorra egli stesso alla violenza per organizzarlo. Il lettore potrebbe credere (pur non essendo intenzione dell’autore) che questa sia la ragione per cui la maggior parte degli Stati non sia nata in conseguenza di una negoziazione pacifica, ma grazie alla violenza, o che, qualsiasi sia la motivazione storica alla base di ogni singolo caso, questa teoria del movente razionale sia quantomeno non del tutto incompatibile con la violenza.
Come le precedenti teorie contrattualistiche, questo tipo di teoria invita all’imprudente conclusione secondo la quale, poiché gli Stati si sono formati mediante la violenza e sono prosperati, e poiché ha senso che le persone si sottomettano serenamente alla violenza che porta alla creazione dello Stato, cosa che desiderano ma che non riescono a raggiungere, esse hanno accettato la violenza alla base della nascita dello Stato a posteriori. Si sottintende l’assunto per cui lo Stato, non importa se creato in modo pacifico o violento, aiuta gli individui a perseguire il loro bene.
Sorprendentemente, tale assunto non viene quasi mai formulato in modo più generale, ad esempio, utilizzando un segno più o meno. In tal caso, si dovrebbe leggere “lo Stato aiuta/ostacola” e l’equilibrio effettivo dell’espressione dipenderebbe dal contenuto empirico dei termini “aiuta” e “ostacola”. L’assunto potrebbe essere riscritto in modo più informativo: ad esempio, “lo Stato aiuta/ostacola alcuni individui, ne ostacola/aiuta altri, e non ha effetti sui restanti”. Gli interessati vengono aiutati e ostacolati in vari modi e in vari gradi. A meno che, per un qualche caso, il gruppo di coloro che vengono ostacolati non sia vuoto (cioè, o tutti vengono aiutati o tutti non sono interessati), la somma algebrica diventa un confronto tra chi viene aiutato e chi viene ostacolato. Il fatto di imbattersi tanto presto nei confronti interpersonali è segno che le nostre riflessioni vanno come minimo nella giusta direzione, verso la questione centrale della teoria politica.
Se mai vi furono persone nello stato di natura e per questioni storiche ricorrenti servì la violenza per imporre loro uno Stato, ci sembra giusto chiedere: come mai la teoria politica tradizionale considera come una verità fondamentale il fatto che preferissero lo Stato? La domanda può in effetti essere suddivisa in due parti, una ex ante e l’altra ex post: (i) gli individui allo stato di natura preferiscono a quello lo Stato? e (ii) una volta entrati a far parte dello Stato, gli individui preferiscono quest’ultimo allo stato di natura? Chiaramente, tali domande permettono di porre in relazione, con maggiore verosimiglianza, le preferenze degli individui rispetto all’ambiente politico in cui vivono.{8}
Tuttavia, una volta analizzati in tal modo, notiamo una caratteristica peculiare. Quando i sociologi dicono di sapere che il Signor Smith preferisce il tè al caffè perché l’ha appena detto, o perché ha rivelato la propria preferenza prendendo un tè quando avrebbe potuto prendere un caffè, analizzano oggetti che si presume siano per Smith familiari e accessibili. Quando Smith parla delle proprie preferenze per cose che potrà conoscere al massimo per sentito dire, sorgono le prime difficoltà; aumentano quando egli non potrebbe tradurre la preferenza dichiarata in una scelta pratica, poiché alcune alternative sono semplicemente irrealizzabili. Gli individui che vivono in uno Stato non hanno mai, di regola, sperimentato lo stato di natura e viceversa, e non hanno alcuna possibilità pratica di passare dall’uno all’altro. Affermare il contrario è un anacronismo storico, nonché un’assurdità antropologica, così come supporre un simile movimento. Su quale base, dunque, gli individui formulano ipotesi sui rispettivi meriti dello Stato e dello stato di natura?{9}
Pare che, presso alcune popolazioni indigene dell’America del Sud (ma plausibilmente anche in altre parti), la crescita della dimensione demografica unitaria venga vista come un fattore atto a favorire la possibilità di creare uno Stato, forse a causa del mutamento delle dimensioni e del tipo di lotte che questo implica. Un capo guerriero sostenuto dai suoi seguaci semi-professionisti può obbligare il resto della popolazione a un’obbedienza duratura. In un libro di Pierre Clastres, che dovrebbe svettare in qualsiasi bibliografia sul contratto sociale,{10} leggiamo che il popolo dei Tupi-Guarani era solito bloccare tale processo mediante la separazione di gruppi di persone, che si dirigevano in terre lontane e terribili, migrando sulla base di profezie, giacché il timore maggiore era quello dell’assoggettamento, dello Stato, identificato col male. I popoli amerindi studiati da Clastres vivono solitamente nello stato di natura, condizione che ha ben poco a che fare col livello di civilizzazione tecnica e molto col potere politico. I loro capi possono persuadere, ma non comandare e, per farsi ascoltare, devono affidarsi all’oratoria, al prestigio e all’ospitalità. Il loro prestigio dipende in parte dalla capacità di non rischiare di interferire in una materia in cui le loro opinioni potrebbero restare inascoltate. Non vi è alcun apparato fra di loro per imporre l’obbedienza e gli indiani non si sognerebbero mai di accordarsi volontariamente per obbedire, sebbene possano decidere di concordare col capo di volta in volta.
Secondo Clastres, queste sono vere e proprie società dell’abbondanza, facilmente in grado di produrre eccedenze, ma che, tuttavia, decidono di non farlo, poiché due ore di lavoro al giorno sono ampiamente sufficienti a provvedere a quella che esse considerano un’adeguata sussistenza. Sebbene la produzione riservata allo scambio sia quasi nulla, esiste la proprietà privata; senza di essa non potrebbero esserci né l’ospitalità privata né gli inviti a eventuali festeggiamenti. Non esiste nessun impedimento specifico alla divisione del lavoro, quindi al capitalismo, ma i beni che possono essere generati dalla divisione del lavoro non sono tenuti in gran conto. Il lavoro viene disprezzato. Al tipo di beni che il lavoro può produrre si preferisce cacciare, pescare, raccontare storie e andare alle feste. La domanda è proprio davanti ai nostri occhi: è a motivo delle loro preferenze che gli indiani aborrono il rapporto comando-obbedienza implicito nello Stato, e scelgono di restare nello stato di natura? O è forse il fatto di vivere nello stato di natura a predisporli ad apprezzare soprattutto i beni tangibili e immateriali che ne derivano?
Certamente Marx si acciglierebbe davanti al ruolo giocato da gusti e preferenze in questo tipo di formulazione della domanda, decidendo presumibilmente che l’agricoltura di sussistenza, la raccolta di piante selvatiche e la caccia sono fenomeni dell’esistenza, della “struttura” (Bau), mentre le istituzioni dello Stato sono fenomeni della coscienza, della “sovrastruttura” (Überbau). Perciò, dovrebbero essere stati i primi a determinare i secondi. Ma Clastres, ad esempio, sostiene il contrario.{11} Da un punto di vista analitico (distinto da quello storico), entrambe le concezioni sono vere nello stesso senso, come pure sono vere “la gallina ha dato origine all’uovo” e “l’uovo ha dato origine alla gallina”. Qui sosteniamo che le preferenze per le istituzioni politiche della società sono in gran parte prodotte proprio da quelle stesse istituzioni, cosicché le istituzioni politiche sono o di un tipo che crea assuefazione, come alcuni farmaci, o di un tipo che provoca allergia, come altri, o di entrambi i tipi, poiché potrebbero fare un effetto ad alcuni e un altro ad altri. In tal caso, è necessario diffidare delle teorie secondo cui “il popolo” in generale (Hobbes, Locke, Rousseau) o la classe dirigente (Marx, Engels) istituiscono il regime politico che va meglio per loro. Al contrario, l’idea (di Max Weber) secondo cui gli esiti storici sono largamente involontari merita un préjugé favorable, in quanto fornisce l’approssimazione più promettente per comprendere molte delle relazioni che collegano Stato e cittadini.
Diritto di proprietà e contratto
Lo Stato può definirsi capitalista se non pretende una giustificazione della proprietà e si astiene da ogni ingerenza “per il loro bene” nei contratti stipulati dalle persone.
L’origine della proprietà capitalista è “il diritto del primo utilizzatore”.
È il riconoscimento di questo principio che permette il passaggio dal bene posseduto alla proprietà legittima, al vero diritto alla proprietà, indipendentemente dalle sue peculiarità, da chi è colui che lo detiene e anche dall’uso che egli può fare o meno della proprietà. Lo Stato che riconosce il diritto di proprietà sulla base di questi fatti (sebbene possa farlo anche sulla base di altri) soddisfa una delle condizioni necessarie per essere uno “Stato capitalista” nel senso inteso qui (un senso che diverrà più chiaro man mano che procederemo). Tale diritto non viene invalidato dalla scarsità, non è dipendente né dal merito, né dalla condizione sociale, e non implica alcun obbligo. Forse è il caso di spiegare meglio il significato di questo riferimento alla scarsità. Con ciò si intende che, se un uomo può possedere un acro, può possederne anche un milione. Se il suo diritto ha valore, ne ha indipendentemente dal fatto che, secondo la nota espressione di Locke, agli altri non rimangano cose sufficienti e altrettanto buone. La proprietà non viene inficiata dalla scarsità del bene posseduto, né dal desiderio da parte di coloro che non lo possiedono, cosicché in uno Stato capitalista l’accesso ai beni che scarseggiano è regolato dal prezzo e dalla sostituzione, non da un’autorità sovrana, comunque essa sia costituita.
Coloro cui sono state insegnate da sempre le nozioni dell’“accumulazione originaria del capitale”, della “divisione del lavoro” e dell’appropriazione del plusvalore come fonte di continua accumulazione, potrebbero esser perplessi davanti a un simile approccio all’origine del capitale e all’essenza dello Stato capitalista. Indubbiamente, il capitale è sempre stato accumulato più che “trovato”. Inoltre, sia per i marxisti sia forse per la maggior parte dei non marxisti, potrebbe sembrare un modo di mettere il carro davanti ai buoi, quello di procedere dai “rapporti di produzione” (che, come ha dimostrato Plamenatz, significano rapporti di proprietà, «se proprio devono avere un’identità»){12} ai “mezzi di produzione”, i beni posseduti. Tuttavia, non è, almeno non generalmente, un’alterazione dei mezzi di produzione o delle tecniche ad essi applicate a trasformarli in proprietà capitalista. Una qualsiasi importante nobile famiglia francese o tedesca, proprietaria di terreni fino alla Guerra dei trent’anni, li avrebbe posseduti in senso molto lato. Erano un mezzo di produzione, ma certamente non una proprietà capitalista alla maniera dei terreni inglesi o italiani. Le terre possedute dall’aristocrazia e dalla gentry inglese, dal sedicesimo secolo in poi, possono essere considerate a buon diritto capitale, e sono infatti servite da trampolino di lancio per il capitalismo inglese. Il commercio marittimo e altri tipi di accumulazione mercantile del capitale esplosero in tarda epoca Tudor e nel periodo Stuart, soprattutto grazie alle partecipazioni azionarie dei proprietari terrieri. Il possesso di terreni di tipo non capitalista (si evita appositamente il termine “feudale”) aveva origine di solito nei servigi e continuava sulla base dell’aspettativa (più o meno fondata e realistica) di servigi futuri. Questo valeva per il proprietario terriero debitore di servigi, direttamente o indirettamente, nei confronti del sovrano, che per i suoi servi a lui debitori di prestazioni.{13} È tipico dell’evoluzione sociale inglese il fatto che il regime della proprietà terriera sia diventato tanto rapidamente incondizionato e che le poche condizioni (insignificanti e non scritte) rimaste riguardassero la giustizia locale e la beneficenza, situazioni in cui il proprietario terriero sostituiva lo Stato invece di servirlo.
Il contadino del villaggio “ripartizionale” della Russia settentrionale e centrale poteva possedere terreni a motivo della sua condizione sociale e del fatto che aveva molti adulti in famiglia. Si potrebbe dire che il suo diritto, in quanto tale, dipendeva dallo status, dalla necessità e dalla capacità di utilizzare la terra. Ogni determinato numero di anni, quando lo richiedeva il cambiamento cumulativo delle necessità della sua e di altre famiglie del villaggio, un’assemblea dei contadini più influenti che dirigevano l’obshchina{14} poteva togliergli i terreni per sostituirli con altri più scadenti. Nessuno, però, poteva acquistare o vendere una parte dei terreni all’interno del villaggio; se ciò fosse stato permesso, la terra sarebbe diventata capitale. La terra che il contadino americano “aveva trovato” alla frontiera, o che “aveva dimostrato di possedere” con l’Homestead Act del 1862, o che aveva ricevuto da qualcun altro, era una proprietà capitalista. Il luogo di lavoro, gli attrezzi e la scorta di materiali dell’artigiano di una corporazione non erano capitale. Il luogo di lavoro materialmente assai simile, gli attrezzi e i materiali del suo successore – il piccolo artigiano-imprenditore del Gewerbefreiheit – erano l’essenza stessa del capitale.{15} Diversamente dal suo predecessore della corporazione, egli poteva essere chiunque e gestire il proprio negozio come meglio credeva. Non sono la grandezza dell’impresa né il fatto di impiegare il lavoro di altri, a r...