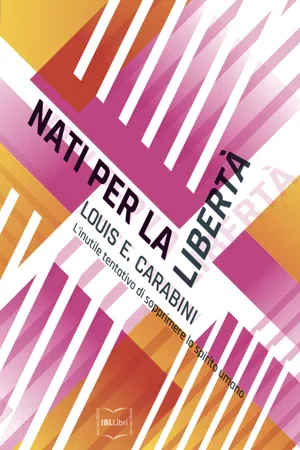![]()
1. Perché scrivere questo libro?
Mentre scrivevo il libro, mi sono spesso chiesto: «Perché poi scriverlo? Verrà fuori qualche insolita spiegazione o idea in base alla quale qualcuno con inclinazioni socialiste, leggendolo, esclamerà d’improvviso: “Ah! Ora capisco”?» Difficile! Scrivere non conquista sostenitori, ma aiuta davvero a chiarificare il proprio pensiero e le proprie convinzioni, e solo per questo ne vale la pena.
Mi sono sempre chiesto perché coloro che hanno opinioni forti sulle questioni sociali sono sempre attratti verso uno di due poli opposti. Ci sono coloro che sono attratti dalla libertà: la libertà dell’individuo di vivere la propria vita in qualunque modo pacifico. E ci sono coloro che sono attratti dal dominio: consentire agli altri di vivere le loro vite solo se qualcun altro lo giudica opportuno. Sembra inoltre che, una volta attratti dall’una o dall’altra di queste filosofie, si è anche attratti dalla vita in un certo modo.
In base alla mia esperienza, è raro che persone che si schierano in un campo o nell’altro, vedendo nuove prove o ascoltando argomentazioni contrarie alle loro credenze, cambino schieramento. Perché alcuni sono portati a essere d’accordo, per esempio, con un passo scritto da Milton Friedman, ma in disaccordo con uno scritto da John Kenneth Galbraith, o il contrario? Forse abbiamo geni che ci predispongono a un’inclinazione e ci rendono immuni dalle prove contrarie.
Allora perché discutere se siamo così fermamente predisposti? Sembra che ci sia uno spirito in noi che vuole convertire gli altri alle nostre convinzioni senza dover valutare il valore reale di queste conversioni. Dopo tutto, le convinzioni di qualcuno non ostacolano le convinzioni degli altri. Se convertiamo un socialista in un libertario o un ateo in un cristiano, o viceversa, cosa si guadagna? Forse il guadagno è semplicemente la consolazione che sentiamo quando qualcun altro conferma che le nostre convinzioni dopo tutto sono “giuste”.
In ogni caso, la cena di quella sera mi ha condotto alla mia personale ricerca di risposte e, in ultima analisi, a scrivere questo libro, un’impresa molto appagante che non avrei mai azzardato se non fosse per le idee espresse dai miei ospiti quella sera. Li ringrazio, e in particolare il mio amico Don De Francisco, per aver reso possibile quell’esperienza.{1}
![]()
2. Le proposte di quella sera
Ecco alcune delle proposte avanzate durante quella vivace serata:
«A nessuno dovrebbe essere permesso di possedere uno yacht».
«I compensi dei manager delle grandi società sono troppo elevati».
«A nessuno dovrebbe esser consentito di ereditare ricchezza».
Ma l’affermazione che ho trovato più intrigante, quella che mi ha condotto inizialmente a scrivere, è stata:
«Non è giusto che le imprese possano licenziare i loro lavoratori solo per aumentare i profitti».
Tuttavia, mentre pensavo a una risposta adeguata, mi sono reso conto che questa proposta non era differente in principio dalle altre. Mentre alcune affermazioni sono più radicali di altre, ognuna fondamentalmente contiene la nozione che qualcosa è ingiusto e che dovremmo fare qualcosa per riparare a quella ingiustizia per mezzo di divieti.
Inserendo questi “è” e questi “dovremmo” nelle proposizioni, le affermazioni allora diventano:
«È ingiusto che qualcuno possa guadagnare molto più di un altro, quindi noi dovremmo impedire alle persone di guadagnare così tanto».
«È ingiusto che qualcuno possa possedere uno yacht, quindi noi dovremmo proibire questo genere di proprietà».
«È ingiusto che qualcuno possa lasciare in eredità la ricchezza a un erede, quindi noi dovremmo impedire questi trasferimenti di ricchezza».
«È ingiusto che qualcuno possa licenziare i lavoratori solo per aumentare i profitti, quindi noi dovremmo impedire ai datori di lavoro di farlo».
Il “noi” in ognuno di questi casi è il plurale maiestatis: cioè lo Stato. Il “noi” denota una giustificazione morale per costringere fisicamente gli altri a vivere le loro vite come l’“io” personale ritiene opportuno. Immaginate quanto suonerebbero allarmanti queste proposte se l’“io” personale venisse usato al posto dell’astratto e giustificabile “noi” maiestatico. Per esempio:
«I compensi dei manager sono troppo elevanti, quindi io minaccerò personalmente di mandare in carcere ogni dirigente che accetti e ogni impresa che paghi un compenso maggiore di quanto io ritengo ragionevole».
«Io manderò in carcere chiunque acquisti, costruisca o venda uno yacht che io considero troppo grande e lussuoso».
Ogni divieto da parte dello Stato implica anche carcere o morte se il rifiuto di adeguarsi viene portato all’estremo. Benché il carcere e la morte si nascondessero dietro ogni proposta avanzata quella sera, la chiara comprensione di queste punizioni fisiche emerge quando sostituiamo “noi” con “io”. Il “noi” maiestatico sembra giustificare moralmente le azioni che l’“io” renderebbe condannabili.
![]()
3. Colpa e risentimento
Sotto questa nozione di ingiustizia e l’obbligo di ripararla stanno le implicazioni di colpa e disprezzo. Vi è un disprezzo non detto ma molto reale per il ricco proprietario di yacht, disprezzo per il proprietario della fabbrica, disprezzo per il manager: in altre parole, un generale disprezzo per le persone facoltose. Oggi, c’è un fiume di disprezzo che corre sui media nei confronti delle case farmaceutiche, delle compagnie petrolifere e dei grandi centri commerciali del mondo. In sintesi, ogni proposta avanzata in occasione di quella cena dipingeva il ritratto di un cattivo, di una vittima e di un liberatore: detto altrimenti, il ricco, il povero e i sostenitori di quelle proposte (con l’aiuto dello Stato) rispettivamente.
Il messaggio implicito in ogni proposta non è semplicemente che i poveri sono troppo poveri e i ricchi sono troppo ricchi. Il cuore di ognuna di quelle proposte è che la causa della povertà dei poveri consiste nel fatto che i ricchi sono troppo ricchi. In un senso, ci viene detto che chi ha è colpevole di impedire a chi non ha di guadagnare ricchezza e, in un altro senso, che se chi ha avesse meno, chi non ha avrebbe di più per definizione. Le prove dimostrano che entrambe queste asserzioni sono sbagliate.
Espressioni come “ricco sfondato”, “ricco egoista” e “ricco avido” mostrano un risentimento profondamente radicato nei confronti dei ricchi. Come spiega Robert Solomon, «attraverso il risentimento facciamo mostra di avere la fortuna di non avere quelle cose che vogliamo ma non abbiamo. Ci sentiamo ipocriti precisamente perché non siamo ricchi».{2} Jean-Paul Sartre diceva che il risentimento può aprire la strada alla Schadenfreude: provare gioia per la sofferenza altrui. Questa forma vendicativa di risentimento si rivela in affermazioni quali «alla fine ha avuto quel che si merita», riferito alla notizia di un ricco che ha subito una battuta d’arresto.
![]()
4. In un mondo di diseguaglianze, ci sono per davvero cattivi e vittime?
In un mondo in cui le diseguaglianze economiche sono universali, perché così tanti immaginano l’esistenza di cattivi e vittime? Questa idea deriva dalla convinzione che esista una quantità statica di ricchezza o di risorse nel mondo, e che quando qualcuno ne ha una quota maggiore di quella eguale, qualcun altro ne deve avere una inferiore? Oppure questa idea deriva dalla convinzione che i ricchi hanno acquisito la loro ricchezza senza merito, per mezzo di un comportamento privo di scrupoli, avido o senza riguardi per gli altri? Oppure deriva dall’invidia, dal risentimento, o semplicemente da un tentativo sfacciato di elevare la propria condizione abbassando quella di un altro?
Per molti, forse per la maggioranza, queste affermazioni basate sulla distinzione cattivi/vittime non derivano da alcun ragionamento profondo. Le idee sono una semplice rimasticatura di cose lette e sentite sui giornali o in tv. Ripetere le parole e le idee degli altri è altamente probabile quando si fa parte di un gruppo politico, sociale, religioso o etnico. I leader di questi gruppi, specialmente quelli politici, appaiono tutti i giorni in tv o sui giornali, imprecando contro i leader dei fronti avversari con accuse senza senso ma che catturano i titoli, pensate per eccitare i propri seguaci e, se le cose vanno per il verso giusto, accalappiare qualche credulone da convertire.
Per coloro che entrano a far parte di un gruppo, il portavoce diventa quasi uno di famiglia, e coloro che stanno su fronti opposti automaticamente diventano nemici; le persone coinvolte assomigliano ai partecipanti a una faida. Non importa cosa dicono i parenti, chi sta nel gruppo lo accetterà e disprezzerà qualunque cosa sostengano i nemici. È più facile diventare un pappagallo quando si è allineati in un gruppo, che sia politico, sociale, religioso o etnico, piuttosto che pensare con la propria testa. Indifferentemente dal tipo di gruppo, il portavoce dirà alla folla ciò che questa vuole sentire.
Le folle si radunano per sostenere i propri simili e magari cogliere un’altra battuta maligna da mettere nel carniere per scagliarla meccanicamente contro il primo nemico che si incontra. A meno che non si abbia spirito critico e si consideri realmente se le affermazioni del portavoce abbiano veramente un senso, si può essere disposti a continuare a sostenere politiche che produrranno l’esatto opposto di quanto veramente desiderato. Le leggi sull’equo canone, il proibizionismo su alcol e droga, e i sussidi pubblici sono solamente pochi esempi di come queste politiche producano il contrario degli obiettivi auspicati.
![]()
5. La sindrome del noi contro loro
Durante la campagna presidenziale del 2004, uno dei candidati denunciava «Due Americhe: una privilegiata, l’altra oppressa. Un’America che fa il suo lavoro, un’altra che raccoglie i frutti. Un’America che paga le tasse, un’altra che ottiene agevolazioni fiscali».{3}
Affermazioni demagogiche come queste consistono semplicemente in suppliche alle masse: «Votate per me e vi darò la vostra giusta parte di ricchezza, prendendo a chi ne ha più di voi. Votate per me e prenderò a Pietro (cioè loro) per dare a Paolo (noi)». Mettere a confronto il ricco e il povero è solo uno dei molti temi da campagna elettorale basati sull’atteggiamento mentale dei “noi contro loro”. Leader autoinvestiti contrappongono bianchi e neri, uomini e donne, industriali e operai, stranieri e americani, nuovi immigrati e discendenti dei vecchi. Accusare un gruppo dei mali di un altro è un modo sicuro per provocare e prolungare l’ostilità tra i gruppi.
Seguire questi pifferai magici della protesta divisiva e i loro sogni irrealizzabili è un buon modo per assicurarsi che non si otterrà mai quello che promettono o quello che desiderate. Incolpare gli altri per quello che non abbiamo distoglie la nostra energia e la nostra ingenuità dall’unica fonte affidabilmente efficace di riuscita nel mondo: la fiducia in se stessi. Una volta che ci rendiamo conto che nessuno ci deve una vita priva di miseria, noi iniziamo realmente a cercare rimedi reali invece di perdere tempo ed energie ad accusare gli altri di essere la causa delle nostre sofferenze e ad attenderci risarcimenti.
Ogni campagna elettorale americana è un tiro alla fune tra diversi Robin Hood, in cui ciascuno accusa l’altro o di dare troppo poco e prendere troppo oppure di prendere troppo poco e dare troppo. La gente si infuria per ogni sua lamentela perché è costantemente bombardata dall’idea di essere vittima delle tr...