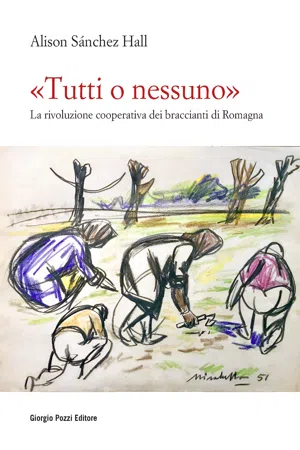![]()
Capitolo 1
L’antropologa Alice nel paese delle meraviglie
Alice rise: «È inutile che ci provi», disse; «non si può credere a una cosa impossibile». «Oserei dire che non ti sei allenata molto», ribatté la Regina. «Quando ero giovane, mi esercitavo sempre mezz’ora al giorno. A volte riuscivo a credere anche a sei cose impossibili prima di colazione».
Condizionata dall’opinione consueta sul fallimento degli esperimenti utopici, nel 1972 sono andata in Italia per studiare le più antiche cooperative non governative di produzione agricola su base volontaria. Ero pronta ad aggiungere un altro caso alle statistiche che prevedono il fallimento delle cooperative agricole di conduzione terreno, e un’altra valida spiegazione del “perché non ce la fanno”.
E invece mi sono imbattuta nell’anomalia di cooperative di produzione, all’epoca quasi centenarie, a guida socialista e comunista pur in un Paese occidentale capitalista. Si tratta di organizzazioni uniche nel loro genere e gestite direttamente dai lavoratori. Situate in provincia di Ravenna (cartina 1), nella “zona rossa” italiana, controllano fra il 20 e il 25% delle ricche e preziose terre alla foce del Po. Hanno attraversato la furia della povertà, l’oppressione violenta, le epidemie, la pressione economica, la cattiva gestione, la depressione, la guerra e il fascismo. Sono state in grado di fare molto più che sopravvivere: hanno costruito, protetto e allargato un patrimonio terriero che è un’eredità per le generazioni future. Mi aspettavo di trovare un fallimento e invece ho scoperto che riescono a offrire benefici economici sostanziali ai soci e alle loro famiglie, e che i soli requisiti per associarsi (in alcune aree queste aziende agricole sono costituite per più del 75% da donne) prevedono la dichiarazione di non essere fascista, di essere un lavoratore agricolo (o di possedere un appezzamento di terreno insufficiente per il proprio mantenimento) e di avere una statura morale adeguata (nessun precedente penale), pagando come quota sociale una cifra poco più che simbolica.
Negli anni successivi al 1974 mi sono spesso chiesta come fossero cambiate le cooperative agricole. Mentre l’economia degli Stati Uniti e quella mondiale si avvicinavano alla crisi del 2008, non potevo fare a meno di ripensare ai miei modesti tentativi di spiegare agli abitanti di quell’Italia rurale perché li stessi studiando. Dato che il mio nome, Alison, non era facilmente traducibile in italiano (ma, ripensandoci, forse anche perché sapevano di avere moltissimo da insegnarmi sulla cooperazione) mi presentavano come «Alice nel paese delle meraviglie» (Fig. 1.1).
Figura 1.1. L’antropologa Alice (1980, foto dell’autrice).
Tutti avevano visto Furore, il film di Ford del 1940 ambientato nella mia nativa California, e allora, nel presentarmi, aggiungevano che ero venuta a imparare le regole della cooperazione per insegnarle agli americani. Cominciai a sentirmi come quell’antropologo i cui soggetti di studio pensavano fosse venuto da una cultura arretrata per studiare le loro forme più avanzate. Nel 2010, alla luce dei cambiamenti in corso nel mio Paese, con i consumatori che cominciavano a mettere in discussione la logica, o addirittura la salubrità, dell’agricoltura di stampo industriale, decisi di tornare in Italia. Questa volta avrei ascoltato con attenzione i consigli dei miei informatori, cercando di capire se e come l’esperienza italiana fosse esportabile negli Stati Uniti.
Il mio intento nel pubblicare questo studio è di fornire al mondo anglosassone un’introduzione alle cooperative di produzione agricola della provincia di Ravenna, una zona sulle rive dell’Adriatico, nella pianura creata dal fiume Po. Da un punto di vista geografico è una versione in piccolo del delta del Mississippi, che è la mia seconda patria dopo la California. A Ravenna lo sforzo di provvedere al bene comune e lo sviluppo di sistemi di agricoltura sostenibile sono andati di pari passo, e per i lettori americani potrebbe essere una sorpresa scoprire che si tratta di un luogo in cui le piccole aziende private e le cooperative sono la base economicamente competitiva di una democrazia partecipativa.
Il corrispondente economico del «Times» di Londra, John Earle, è stato il primo a pubblicare, nel 1987, una ricerca storica dal titolo Viaggio nel movimento cooperativo italiano; ma è stato il politologo di Harvard Robert Putnam (Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy) a introdurre nel 1994 negli Stati Uniti il “modello emiliano”. Un articolo del 1996 apparso su «Nation» a firma di Robert Fitch indicava la regione Emilia-Romagna come dotata di un tipo peculiare di «socialismo municipale», imprenditoriale e ottimamente gestito. Indicava inoltre come, secondo un sondaggio italiano, queste comunità fossero il posto migliore in cui vivere, che la regione vantava il più basso livello di disoccupazione del Paese ed era al decimo posto per il prodotto interno lordo fra le 122 regioni d’Europa (1996).
I canadesi John Restakis e Bob Williams sono stati i co-fondatori del Programma Estivo di Studi Cooperativi di Bologna. In un articolo del 2003 Williams ha descritto il partenariato esistente in Emilia-Romagna tra Regione, Università, associazioni no-profit e imprese, sottolineando come vi fosse un’attività imprenditoriale ogni dodici residenti. Nel 2006 John Logue, professore di scienze politiche alla Kent State University, ha proposto di importare il modello emiliano in Ohio. Il suo Ohio Employee Ownership Centre alla Kent State University si ispirava all’idea di Thomas Jefferson secondo il quale la democrazia avrebbe avuto successo negli Stati Uniti grazie a una larga base proprietaria dei beni produttivi, all’indipendenza economica dei cittadini e all’assenza di una struttura feudale (Logue e Yates 2001, p. 9). Per Logue le cooperative di lavoro sono il moderno e realistico corrispettivo delle aziende agricole e dei negozi gestiti da piccoli proprietari.
Nel 2010, dopo aver trascorso dieci estati in Italia sotto la guida degli economisti Stefano e Vera Zamagni, John Restakis pubblica il suo Humanizing the Economy: Cooperatives in the Age of Capital. Il libro include due capitoli sulle cooperative manifatturiere della regione (maglieria, abbigliamento, piastrelle in ceramica, motociclette, scarpe, attrezzatura), sulle reti di cooperative e piccole aziende, sulle imprese cooperative a valore aggiunto (incluse quelle agroalimentari e le cooperative di vendita e consumo) e su una grande cooperativa di costruzioni con contratti in ogni parte del mondo. Restakis spiega come la forza del movimento cooperativo emiliano-romagnolo sia stata un’ancora di salvezza in un’epoca di difficoltà economiche, e come la collaborazione fra piccole aziende private e cooperative abbia reso possibile la sopravvivenza e la prosperità di entrambe, anche all’interno dell’economia globalizzata (Restakis 2010, p. 86).
Più di recente, nel 2016, i registi americani Melissa Young e Mark Dworkin hanno prodotto WEconomics: Italy, un breve documentario sull’economia cooperativa emiliano-romagnola che include un’intervista a Vera Zamagni. Il film rappresenta «la risposta italiana alla rapacità aziendale e all’indifferenza dello Stato» (Durrenberger 2016) e «descrive molto bene il potere delle cooperative in un mondo che ha disperatamente bisogno di speranza» (Lappé 2016).
Le cooperative agricole ravennati
Il successo delle prime cooperative agricole di braccianti, nate dalle primissime società di mutuo soccorso repubblicane e cattoliche, è un fenomeno ancora sconosciuto al mondo anglosassone e difficile da comprendere, ma è l’elemento fondante di quello spirito cooperativo su cui si basa il cosiddetto “modello emiliano”. Le cooperative agricole di braccianti di Ravenna, collegate storicamente all’ideologia anarchica e ai sindacati di ispirazione socialista e comunista, sono uniche nel loro genere, in quanto proprietarie o affittuarie di 12.407 ettari di terra nella zona agricola a più alto valore d’Europa. La storia dell’acquisizione e dell’utilizzo di quella terra, trasmessa di generazione in generazione senza che fosse proprietà dello Stato o di privati, offre un esempio invidiabile di un’economia e di una società più umane, in forte contrasto con quelle della California o dell’Arkansas, che mi sono così familiari.
Le cooperative ravennati sono un raro esempio superstite di collettivizzazione spontanea, nata dall’azione volontaria di lavoratori che hanno raccolto la sfida di bonificare un’ampia area paludosa per trasformarla ad uso agricolo. Come vedremo, i braccianti che hanno lavorato a giornata, letteralmente con la forza delle loro braccia, non sono rimasti ai margini della storia e non ne sono stati vittime, ma ne hanno fatto parte. Quando sono stati allontanati dalla terra che aveva nutrito i loro avi hanno sviluppato meccanismi di difesa originali per far fronte a cambiamenti negativi quali l’automatizzazione del lavoro, la mancanza di un controllo umano sull’uso delle tecnologie in agricoltura, la sottrazione e privatizzazione della terra da parte dell’élite economica.
Aggrappandosi caparbiamente alle terre romagnole, escogitando ogni sorta di strategia per ottenere più lavoro possibile, rigorosamente condiviso con tutti, in una situazione economica precaria, le cooperative ravennati hanno sviluppato un sistema flessibile di protezione in grado di creare lavoro per i loro soci che, quando sono stati messi alle strette da necessità economiche urgenti, sono ricorsi allo “sciopero a rovescio”, portando i loro macchinari su terreni incolti di proprietà privata, incalzando così i proprietari a venderli alla cooperativa braccianti (Fig. 1.2).
Figura 1.2. Sciopero a rovescio (1972, foto dell’autrice).
Queste imprese, in cui la produttività dipendeva dalla coscienza dei proprietari-lavoratori, erano particolarmente adatte in un’economia caratterizzata da una disoccupazione parziale, diffusa e cronica. Esse hanno inoltre sviluppato piani di semina e di coltivazione basati non soltanto su meri obiettivi di produttività e profitto in denaro, ma anche sulla capacità di fornire occasioni di lavoro in situazioni in cui il lavoro non era disponibile, aggiungendo quindi il valore incalcolabile della sopravvivenza e della dignità umana. Avendo a disposizione soltanto il 10,5% della terra della provincia, le cooperative braccianti degli anni Sessanta sono state in grado di fornire il 50% del reddito da lavoro agricolo (Baldassarri 1971, pp. 10-11). Invece di nascondere la scarsa occupazione, come accadeva nelle aziende agricole a conduzione familiare, e di sostituire i lavoratori con le macchine, come nelle grandi aziende private, le cooperative braccianti ravennati hanno utilizzato la tecnologia per massimizzare le occasioni d’impiego, suddividendole equamente tra i soci, in larga misura donne, che spesso lavoravano soltanto a tempo parziale.
Il mio obiettivo, nel 1972-74, era quello di condurre un’analisi antropologica ed etno-storica di queste aziende agricole collettive, le più antiche al mondo, utilizzando i concetti e le procedure consolidate del metodo antropologico. Lo studio è stato condotto utilizzando un metodo noto come “osservazione partecipata”: vivere effettivamente nel setting, essere adottati dalle famiglie, lavorare nei campi e imparare la lingua (e anche, in questo caso, il dialetto locale). Il partecipante fa esperienza della routine quotidiana del gruppo, registra le storie tramandate oralmente, conduce interviste formali e informali e tenta di valutare questa esperienza globale da un punto di vista antropologico. Tale procedura mi è servita innanzitutto a raggiungere un buon livello di comprensione dall’interno, dopo di che ho messo a confronto le cooperative braccianti secondo il cosiddetto “metodo comparativo”, confrontandole dal punto di vista ideologico, geografico ed economico, e comparandole alle diverse forme di agricoltura privata. Attraverso queste tecniche di ricerca ho cercato di comprendere pienamente quali fossero gli incentivi alla partecipazione per gli individui e per i gruppi, utilizzando ciò che gli studiosi definiscono “approccio olistico”, la ragion d’essere di ogni studio antropologico.
Prima di fornire, nei capitoli che seguiranno, i dettagli della storia e dello sviluppo organizzativo delle cooperative ravennati, passerò in rassegna alcune delle questioni teoriche relative alla cooperazione e ai cambiamenti sociali intenzionali nelle comunità umane.
La cooperazione nelle società complesse
June Nash, citando Clyde Kluckhohn, descrive l’interesse antropologico per le forme cooperative come derivante dal principio secondo cui «l’antropologia cerca di estendere le aree che la ragione può arrivare a comprendere e forse in qualche misura a controllare». È questo «consapevole controllo delle forme sociali» a «rendere i movimenti verso forme cooperative di organizzazione una parte essenziale sia dell’esperienza umana sia dell’antropologia». Nash etichetta lo studio delle forme di cooperazione come «antropologia prospettivista» o «urgente», nella misura in cui «consiste nella comprensione delle forme sociali verso le quali potremmo evolverci». Parafrasando Stanley Diamond, Nash sostiene vi sia «un’attenzione verso un rinnovato senso delle possibilità della natura umana e della cultura attraverso la conoscenza di mondi culturali già formati». La studiosa cita anche Marcel Mauss, dicendo che «i sindacati e le società cooperative sono il fondamento delle società future, generate in seno alla struttura capitalista» (Kluckhohn, Diamond e Mauss, citati in Nash, Dandler e Hopkins 1976, pp. 3-4). David Graeber nel suo Fragments of an Anarchist Anthropology conclude che «un altro mondo è possibile» e che gli antropologi possono «osservare coloro che creano alternative cercando di prevedere le implicazioni di ciò che costoro stanno facendo, offrendole poi non come indicazioni univoche ma come contributo, possibilità, dono» (pp. 10-12).
In Search of the Common Good: Utopian Experiments Past and Future di Charles J. Erasmus, pubblicato per la prima volta nel 1977, è finora l’analisi antropologica più completa sul tema degli esperimenti utopici e dei collettivi. Nella prefazione all’edizione del 1984 Erasmus dice che i suoi studenti degli anni Settanta si occupavano di sviluppo (inclusa chi scrive), erano maoisti delusi dalla corruzione del sistema capitalista, persone che si aspettavano di poter creare un nuovo mondo in cui ciascuno avrebbe lavorato secondo le proprie capacità e avrebbe ricevuto secondo il proprio bisogno. In realtà non eravamo maoisti, ma criticavamo schemi di sviluppo che prevedevano l’insegnamento dell’economia domestica come soluzione alla povertà. Ci sembrava ridicola la possibilità che programmi di «formazione alla leadership laica» potessero produrre veri leader, e confutavamo l’idea che instillare l’etica protestante del lavoro potesse stimolare lo sviluppo, sostenendo invece l’attenzione alle realtà locali per possibili soluzioni, proponendo ricerche che avessero delle applicazioni pratiche. Eravamo animati da buone inte...