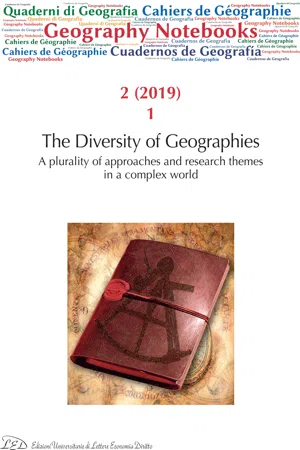![]()
GEOGRAPHICAL APPROACHES
![]()
Politica e deforestazione in Kenya: i risultati della Commissione Ndung’u nella regione del South West Mau
Stefania Albertazzi - Valerio Bini
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Milano
DOI: https://dx.doi.org/10.7358/gn-2019-001-albe
ABSTRACT
The article examines the results of the Commission of Inquiry into the Illegal/ Irregular Allocation of Public Land related to the case study of the Mau forest (Rift Valley region). The Commission’s work (2002-05) has brought to light the close link between land and political patronage, illustrating how land allocation has been used by the political, judicial and military élite to pursue their own political and personal interests. The paper aims to reflect on the effects of the Ndung’u Commission Report in the south-western region of the Mau forest; in particular, it analyses the process of “degazettement” that in the period of democratic transition (1991-2002) led to the conversion of large portions of forest into agricultural land.
Keywords: deforestation; Mau; Kenya; Ndung’u Report; regime change.
Parole chiave: deforestazione; Mau; Kenya; Ndung’u Report; cambiamento di regime.
1. INTRODUZIONE
Il presente contributo analizza da una prospettiva geografica i risultati della Commission of Inquiry into the Illegal/Irregular Allocation of Public Land (la cosiddetta Commissione Ndung’u, dal nome del suo presidente), relativamente al caso della foresta Mau (regione della Rift Valley), un’area in cui gestione neopatrimoniale delle risorse naturali e questioni etniche si sono storicamente sovrapposte, portando alla formazione di configurazioni territoriali conflittuali.
L’articolo è parte di una ricerca più ampia relativa al fenomeno di deforestazione nell’area della foresta Mau (Albertazzi et al. 2018) e in questa sede intende approfondire due ordini di questioni.
La prima riguarda il rapporto tra ambiente e politica. Il caso analizzato mostra infatti come l’ambiente africano contemporaneo, lungi dall’essere quello spazio incontaminato narrato dagli stereotipi sul continente, sia viceversa il prodotto di un’azione politica situata storicamente. In particolare viene qui indagato il processo di degazettement, che proprio nel periodo di ‘transizione democratica’ (1991-2002) ha portato alla conversione di ampie porzioni di foresta protetta in terreno agricolo. Tale approccio si inserisce in un più vasto quadro teorico-metodologico teso a indagare il processo di ‘produzione della natura’ nel contesto politicoeconomico contemporaneo (Smith 1984).
Il secondo ambito di indagine è indirizzato a proporre una specifica interpretazione di matrice geografica rispetto al tema della ‘democratizzazione’ negli stati africani. Se le scienze politiche nella loro analisi dei processi di transizione politica hanno spesso privilegiato un punto di vista istituzionale, centrato sui cambiamenti costituzionali e sul processo elettorale, l’analisi delle trasformazioni territoriali rende più complesso il quadro, evidenziando elementi di continuità che interagiscono dialetticamente con la discontinuità imposta dal cambio di regime.
Dal punto di vista metodologico, l’articolo si basa su un lavoro di indagine, tuttora in corso, che combina l’analisi documentale (documenti ufficiali, cartografia e immagini satellitari) con la ricerca di campo (interviste, analisi territoriale).
Il contributo è strutturato in due parti: nella prima viene analizzato il Rapporto Ndung’u – l’origine, la struttura, i risultati attesi e quelli reali – nella seconda vengono analizzati in modo specifico i casi relativi a una porzione di foresta Mau nella quale l’area protetta è stata oggetto di tentativi più o meno riusciti di conversione dell’insediamento agricolo.
2. IL RAPPORTO NDUNG’U
La Commission of Inquiry into the Illegal/Irregular Allocation of Public Land venne istituita nel 2003 dal nuovo presidente Mwai Kibaki per far luce sulle attribuzioni illegali e irregolari di terra avvenute nei decenni precedenti e proporre delle soluzioni per riparare le ingiustizie commesse. Sebbene il Rapporto della Commissione chiarisca la radice coloniale dello squilibrio esistente nel sistema fondiario e non escluda episodi illeciti nei primi decenni della storia del Kenya indipendente, esso identifica negli anni Ottanta e Novanta l’apice di un sistema clientelare e corruttivo nel quale affiliazione politica, appartenenza etnica e attribuzione illecita delle terre si trovano inestricabilmente legati:
The practice of illegal and irregular allocations intensified in the late 1980s and throughout the 1990s. Land was no longer allocated for development purposes but as political reward and for speculation purposes. This practice which is usually referred to as “land grabbing” became part and parcel of official grand corruption through which land meant for public purposes (including land specifically reserved for public purposes) has been acquired by individuals and corporations. (Commission of Inquiry into the Illegal/ Irregular Allocation of Public Land 2005, 8)
Politicamente, tale periodo può essere suddiviso in due fasi: un primo decennio 1982-1992 nel quale, a partire dal tentato colpo di Stato del 1982, il governo di Daniel Arap Moi irrigidisce il controllo sulla vita politica e sociale del Kenya e quello successivo, in cui viene gradualmente introdotto il multipartitismo e si svolgono due elezioni (1992 e 1997) vinte con larga maggioranza dal presidente in carica (Hornsby 2012).
Dal punto di vista dell’attribuzione delle terre, tuttavia, non vi è una reale discontinuità, e gli episodi illeciti proseguono in tutto il periodo. Se infatti nella prima fase la terra viene utilizzata come strumento di consolidamento di un’affiliazione politica, nel periodo successivo la creazione di programmi di insediamento su terre pubbliche diventa uno strumento di costruzione di un consenso elettorale: “Kenya turned to multiparty democracy in 1991 and the creation of a settlement scheme represented nothing but the creation of a political constituency, a vote reservoir” (Di Matteo 2017, 23). Nel caso dell’area oggetto di questo studio, ad esempio, i passaggi cruciali avvengono nel periodo 1995-2001.
La sconfitta di Uhuru Kenyatta, candidato del KANU (Kenya African National Union) di Moi (nel 2002) sembra aprire, almeno in una fase iniziale, uno scenario nuovo e l’istituzione della Commissione Ndung’u è uno dei segnali più forti in questa direzione. La Commissione alla fine del 2004 consegna il suo Rapporto, composto di un testo di circa 200 pagine che analizza il fenomeno e presenta risultati e raccomandazioni e due allegati di circa 1.000 pagine l’uno con i dati dettagliati delle attribuzioni illegali o irregolari censite dalla Commissione.
Il Rapporto individua tre classi di attribuzioni illegali: la prima categoria si riferisce alle terre delle aree urbane e a quelle di proprietà delle imprese statali e dei ministeri; la seconda categoria identifica le terre attribuite nell’ambito dei piani di insediamento e le terre comunitarie; il terzo gruppo raccoglie tutte le terre oggetto di protezione (parchi, foreste, aree umide, …). Per tutti e tre i gruppi si rilevano enormi quantità di attribuzioni illegali e il caso in oggetto si colloca a cavallo tra la seconda e la terza categoria, poiché si tratta di una sottrazione irregolare di terra di foresta protetta al fine di creare piani di insediamento, a loro volta gestiti in modo non regolare.
Le conclusioni della Commissione sono piuttosto radicali e prevedono l’annullamento di tutte le transazioni illegali e il ritorno delle terre allo Stato. La Commissione sottolinea la posizione delicata delle cosiddette “terze parti”, figure che potrebbero avere acquistato in buona fede dei terreni ottenuti dal venditore in maniera illegale, ma fondamentalmente identifica come unica soluzione alternativa al ritorno delle terre allo Stato l’acquisto delle stesse a prezzo di mercato.
La Commissione pare rendersi conto dell’enormità del lavoro necessario per procedere in questa direzione e dunque raccomanda la creazione di tre istituzioni: un tribunale, una task force e una commissione nazionale. Di questi enti, solo la commissione vedrà la luce, diversi anni dopo, e il Rapporto Ndung’u verrà di fatto disatteso, anche perché le successive elezioni del 2007 si svolsero, come noto, in un clima di estrema violenza, concludendosi con una mediazione che prevedeva la spartizione delle due cariche principali, presidente e primo ministro, tra il presidente in carica Kibaki, e l’ex-alleato, Raila Odinga.
Il fallimento formale della Commissione Ndung’u, tuttavia, non significa che tale lavoro sia rimasto senza conseguenze (Africog 2009): a livello di opinione pubblica il Rapporto rimane come un punto di riferimento rispetto alla corruzione degli anni della presidenza Moi e dunque come potenziale dissuasore dal ripetersi di fenomeni di questo tipo, almeno su larga scala; a livello istituzionale, alcune delle istanze della Commissione Ndung’u vennero raccolte da altre commissioni, in particolare la Anti-Corruption Commission (KACC) e la Truth, Justice and Reconciliation Commission (TJRC) nata a seguito degli scontri del 2007; dal punto di vista politico, infine, alcune azioni promosse dal governo negli anni successivi alla pubblicazione del Rapporto, pur non implementando direttamente le proposte della Commissione, hanno trovato fondamento e supporto nelle conclusioni del Rapporto stesso. Con riferimento all’area in oggetto, in particolare, la battaglia del primo ministro Raila Odinga (2008-2013) per la tutela delle cosiddette Water Towers, tra cui la foresta Mau, ha fatto ampio riferimento alle risultanze della Commissione Ndung’u (Rugene and Wafula 2009).
3. IL RAPPORTO NDUNG’U E IL BLOCCO SUD-OCCIDENTALE DELLA FORESTA MAU
Come anticipato, la terza categoria di attribuzioni irregolari e illegali di terre individuata dalla Commissione Ndung’u, si riferisce alle aree museali e protette – parchi, riserve di caccia, aree umide, riserve litoranee, terre forestali. Tra queste, un caso particolarmente significativo, per le sue implicazioni politiche, etniche, sociali ed ambientali, è il blocco sud-ovest del complesso forestale Mau.
Il South-Western block della foresta Mau (61.214 ha) è una riserva forestale tropicale di montagna, appartenente al più ampio complesso della foresta Mau (circa 380.000 ha) che si estende nella parte sud-occidentale del Kenya. L’intero complesso costituisce una delle foreste più importanti dell’Africa orientale, per l’elevato valore naturalistico e perché cuore della rete idrografica della sezione occidentale del paese e degli stati confinanti (UNEP 2008). Lo stesso complesso rappresenta la terra ancestrale del gruppo indigeno Ogiek, una minoranza insediata nelle foreste keniane da secoli, la cui presenza (30/40.000 persone) è oggi circoscritta alle zone forestali situate a ridosso delle aree protette Mau e del Monte Elgon (African Commission on Human and Peoples’ Right 2009).
Durante l’epoca coloniale diverse porzioni della foresta Mau sono state sottratte al loro originario uso e destinate alla coltivazione e all’insediamento dei coloni bianchi (Kimaiyo Towett 2004). Tale pratica è proseguita nel periodo successivo all’indipendenza, attraverso lo strumento dei settlement schemes: ideati inizialmente nel periodo del cambiamento di regime, questi programmi di insediamento rurale rispondevano alle molteplici esigenze di insediare sfollati, persone senza terra, alleviare la pressione demografica nelle riserve indigene e allo stesso tempo aumentare la produzione agricola e promuovere lo sviluppo rurale (Lukalo and Odari 2016). Date le diverse e in parte inconciliabili necessità (Hoorweg 2000), erano previste diverse tipologie di settlement schemes, distinte per finalità, dimensioni, merci prodotte e presenza statale nella gestione. In Kenya, tra il 1962 e il 2012 ne furono creati 505, di cui più di un terzo nella Rift Valley Province (regione in cui è localizzato il complesso Mau); all’interno di questa, il distretto che si caratterizza per il maggior numero di insediati è Nakuru, che corrisponde all’area in oggetto. Più precisamente, il Rapporto Ndung’u quantifica in 24.109 gli ettari di foresta del South-Western block destinati ad insediamento nelle aree di Tinet, Ndoinet, Saino e Kiptagich, solamente nel corso degli anni Novanta.
La Commissione Ndung’u ripercorre logiche, processi amministrativi, modalità e organi competenti nell’allocazione della terra tramite settlement schemes e ...