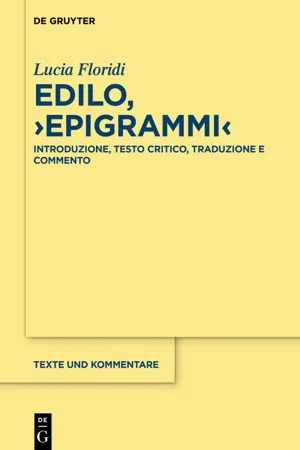Testo e commento
Αἱ μίτραι τό θ’ ἁλουργὲς ὑπένδυμα τοί τε Λάκωνες
πέπλοι καὶ ληρῶν οἱ χρύσεοι κάλαμοι,
πάνθ’ ἅμα Νικονόῃ † σὺν ἔκπιε †· ἦν γὰρ Ἐρώτων
καὶ Χαρίτων ἡ παῖς ἀμβρόσιόν τι θάλος.
[5] τοιγὰρ τῷ κρίναντι τὰ καλλιστεῖα Πριάπῳ
νεβρίδα καὶ χρυσέην τήνδ’ ἔθετο προχόην.
P, Pl : s.a.n. Suid., [Zon.] P, Pl Ia.6.68 (ff. 64r–64v), Suid. s.vv. ἁλουργά (α 1357 Adler: vv. 1–2 Αἱ μίτραι … / πέπλοι), Λακωνικαί (λ 63 Adler: vv. 1–2 τοί τε Λάκωνες / ἐΰπεπλοι), ληρεῖς ἔχων (λ 468 Adler: v. 2 καὶ ληρῶν … κάλαμοι), μίτρα (μ 1136 Adler: vv. 1–2 Αἱ μίτραι … / πέπλοι et v. 3 πάνθ’ … συνεπέκπιε), ἀμβρόσιον (α 1359 Adler: vv. 3–4 ἦν γὰρ … / … θάλος), θαλέεσσι (θ 12 Adler: vv. 3–4 ἦν γὰρ … / … θάλος), καλλιστεῖα (κ 241 Adler: vv. 5–6), προχόῳ (π 2936 Adler: vv. 5–6 Πριάπῳ / … προχόην), [Zon.] s.v. θάλλος (vv. 3–4, verborum ordine perturbato: ἦν δὲ ἡ παῖς ἐρώτων καὶ χαρίτων ἀμβρόσιόν τι θάλλος)
Ἡδύλου P, Pl : s.a.n. Suid., [Zon.]
1 Αἱ μίτραι P, Suid. : ἁ μίτρα Pl || ὑπένδυμα P, Suid. : ὑπέρδυμα Pl || τοί τε P, Pl, Suid. (s.v. μίτρα, Λακωνικαί) : οἵτε Suid. (s.v. ἁλουργά) 2 πέπλοι P, Pl, Suid. (s.vv. ἁλουργά, μίτρα) : ἐΰπεπλοι Suid. (s.v. Λακωνικαί) || ληρῶν P, Suid. (s.v. ληρεῖς ἔχων) : λήρων Pl, fortasse recte 3 Νικονόῃ Dübner : Νικονόη P, Pl, Suid. (s.v. μίτρα) || σὺν ἔκπιε P : συνεπέκπιε(ν) Pl, Suid. (s.v. μίτρα) : συνεπήϊεν vel συνεπέρρεπεν vel συμπέπτωκ’ Stadtmüller : συνεπεσπάσατ’ Hecker : συνεπεκρίθη Dübner (una cum Νικονόῃ vel -ης) : ἓν ἐπείσιον Ellis (una cum Νικονόης) 4 θάλος P, Pl, Suid. (s.v. ἀμβρόσιον), Suid.Α (s.v. θαλέεσσι) : θάλλος Suid.GIFVM (s.v. θαλέεσσι), [Zon.] 5 τοιγὰρ Pl, Suid. (s.v. καλλιστεῖα) : τοὶ γὰρ P [Q] || κρίναντι C, Pl, Suid. (s.v. καλλιστεῖα) : κρίνοντι P || Πριάπῳ P, Suid. (s.vv. καλλιστεῖα et προχόῳ) : Πριήπῳ ex Πριάπῳ Pl, sed Πριάπῳ Q 6 νεβρίδα P, Suid. (s.v. προχόῳ) : νευρίδα Pl, Suid. (s.v. καλλιστεῖα) || τήνδ’ ἔθετο P, Pl, Suid. (s.v. καλλιστεῖα) : τήνδε θέτο Suid. (s.v. προχόῳ) || προχόην Pl, Suid. (s.vv. καλλιστεῖα et προχόῳ) : προχοήν P
Le fasce per il seno e la sottoveste di porpora e i pepli
spartani e gli ornamenti d’oro delle vesti,
tutte queste cose insieme a Niconoe † … †: la ragazza era infatti
un divino virgulto di Eroti e Cariti.
Perciò a Priapo, giudice nel concorso di bellezza
[5] dedicò una pelle di cerbiatto e questa brocca d’oro.
Epigramma di incerta esegesi: una dedica a Priapo da parte di Niconoe in seguito alla vittoria riportata in un concorso di bellezza (così Gow-Page 1965, II, p. 289) o in seguito a una notte di follie etiliche, durante la quale la dedicante avrebbe rimosso le vesti offrendo ai simposiasti la vista della propria bellezza nuda (così Gutzwiller 1998, pp. 175–177. Questa lettura era in parte anticipata da Jacobs 1794–1814, I.2, pp. 332–333, secondo il quale «scriptum videtur in meretricem bibaculam, quae, cum nihil sibi relictum esset, Bacchi et Comi instrumenta Priapo dedicat. […] Verisimile est, Niconoen nostram in Veneris et Priapi orgiis saepenumero libidinis praemia tulisse. Hanc ob causam Priapo τὰ καλλιστεῖα κρίναντι qui de eiusmodi rebus verissimum iudicium habet, donaria ponit». Wilamowitz 1924, I, p. 145, n. 2 riteneva invece che Niconoe fosse rimasta priva di denaro a causa dei troppi calici di vino; si sarebbe trovata quindi costretta a dare in pegno alcuni dei suoi indumenti, ma la sua bellezza l’avrebbe salvata; avrebbe pertanto offerto doni a Priapo, dio connesso alla sfera erotica, per ringraziarlo della protezione accordatale: «Die Dame hat kein Geld mehr und gibt Stück für Stück ihrer Toilette als Pfand. Sie kann sichs leisten, denn ihre nackte Schönheit schlägt alle Konkurrenz, und der Priap, der in den Liebhabern steckt, hat ihr so viel eingebracht, daß sie dem Gotte eine reiche δεκάτη darbringen kann»).
L’interpretazione del componimento è oscurata dalla corruttela del v. 3: palesemente guasto il testo di P, Νικονόη σὺν ἔκπιε; Νικονόη συνεπέκπιε(ν) di Pl e Suid., a cui gli studiosi tendono per lo più a porre rimedio con la correzione Νικονόῃ συνεπήϊεν di Stadtmüller 1894–1906, I, p. 386 (vd. n. ad v. 3), è difeso da Gutzwiller 1998, pp. 176–177, che traduce «Niconoe drank away», sulla scorta di Jacobs 1794–1814, I.2, p. 333, intendendo che Niconoe “si è bevuta”, nell’euforia etilica, le vesti raffinate che aveva indosso, togliendosele (la situazione sarebbe a suo parere assimilabile a quella descritta in 2, dove una fanciulla dedica ad Afrodite alcuni indumenti dopo aver perduto la verginità in seguito a una notte di bagordi: Gutzwiller 1998, p. 175 parla dei due epigrammi come di companion pieces). Una simile lettura renderebbe anche ragione, secondo la studiosa, della posizione dell’epigramma in AP, dove è collocato tra adesp. AP 6.291, sulla beona Bacchilide, e Leon. AP 6.293 = HE 2301 ss., sul cinico Socare che rinuncia alla filosofia e fa una dedica a Cipride, vinto dall’amore per un bel fanciullo. «Apparently … Meleager found in his reading of Hedylus’s poem a reference to excessive drinking and to a dedication made as a memorial for an erotic encounter» (Gutzwiller 1998, p. 176).
Ma riferimenti al vino e all’eros sono presenti nell’epigramma, data la natura degli oggetti dedicati (cfr. in particolare προχόην, v. 6) e del dio a cui sono destinati, anche rifiutando, al v. 3, la lettura di Pl, che fa difficoltà per la sintassi e per il senso. Forse non intollerabile, ma comunque forte, l’anacoluto che viene a determinarsi se Niconoe è soggetto del verbo dopo i nominativi dei vv. 1–2. Jacobs 1794–1814, I.2, p. 333 proponeva di intendere συνεπεκπίνω – verbo peraltro non attestato altrove – nel senso di “dilapidare”, “sperperare”, come spesso i composti di πίνω, adducendo come confronti Plat. Com. PCG 9 οὐδ’ ὅστις αὐτῆς ἐκπίεται τὰ χρήματα e Aeschin. Tim. 96 καὶ οὐ μόνον κατέφαγεν, ἀλλ’ εἰ οἷόν τ’ ἐστὶν εἰπεῖν, καὶ κατέπιεν (vd. inoltre e.g. Luc. DMer. 7.1, dove, come in Eschine, è utilizzato in questo senso κατέπιε, e Alciphr. Ep. 4.13.2 Schepers καταπιεῖν : Cobet; i codici hanno ἐκπιεῖν; per altri paralleli, cfr. LSJ, s.v. ἐκπίνω, 3 e s.v. καταπίνω, II.C.3; sull’uso metaforico di καταπίνω e κατεσθίω, vd. anche Telò 2006, p. 65). Mi sembra però condivisibile lo scetticismo di Gow-Page 1965, II, p. 290: la metafora è inappropriata al contesto e la presenza di -επ- resta sostanzialmente inesplicata (a quanto mi consta, sarebbe peraltro questo l’unico caso, in tutta la grecità, di una formazione verbale con triplice prefisso: difficile sfuggire all’impressione che si tratti di una correzione di età bizantina, volta a sanare la metrica). Ci si attende qui piuttosto un verbo che significhi “andare in premio”, “essere attribuito in premio” (a Niconoe; il nominativo tradito sarà dunque da correggere, presumibilmente, in un dativo – il che non fa peraltro alcuna difficoltà, vista l’oscillazione dei testimoni nella registrazione dello iota sottoscritto). La precisazione successiva della eccezionale bellezza della ragazza (ἦν γὰρ Ἐρώτων / καὶ Χαρίτων ἡ παῖς ἀμβρόσιόν τι θάλος) giunge come motivazione dell’affermazione precedente: γάρ, nel verso, ha chiaro valore esplicativo-causale. Niconoe ha compiuto una certa azione/è stata oggetto di una certa azione perché è bella. È più probabile che quest’azione sia l’attribuzione di un premio piuttosto che una svestizione in una notte di bagordi; in questa direzione porta anche la menzione esplicita di un contesto agonale al v. 5 (τὰ καλλιστεῖα), da intendersi in senso reale e non metaforico (come sembrerebbero presupporre le letture di Jacobs e di Wilamowitz; per una loro confutazione, cfr. anche Galli Calderini 1984, pp. 84–87).
Concorsi di bellezza femminili sono d’altronde ben attestati nel mondo greco, sia in contesti istituzionalizzati sia privati: l’esistenza di questo tipo di competizioni si ricava già da Alc. fr. 130b.17–20 Voigt, ma vd. poi soprattutto Athen. 13.609e–610a, dove sono menzionati un concorso di bellezza che si svolgeva in Arcadia, sin dai tempi di Cipselo, durante una festività in onore di Demetra Eleusina, e gare analoghe a Tenedo e a Lesbo. Lo stesso Ateneo ricorda anche un concorso di bellezza maschile che si svolgeva in Elide, sotto l’egida di Atena. Il tema tornerà nel romanzo (cfr. la sfida tra le donne persiane e Calliroe in Charit. 5.3.6–10). Gare di bellezza incentrate su un’unica parte anatomica sono poi attestate soprattutto in relazione al mondo delle cortigiane: vd. Alciphr. Ep. 4.14.4–6 Schepers, dove è narrata la contesa ὑπὲρ τῆς πυγῆς tra due etere; al filone delle Hetärenleben sono probabilmente da ricondursi anche Rufin. AP 5.35–36 = 11–12 Page e Cerc. fr. 14, p. 213 Powell = 58 Livrea = 65 Lomiento, dove la gara disputata da due sorelle siracusane è ricordata dal testimone Athen. 12.554c–e in relazione alla dedica di un tempio ad Afrodite Καλλίπυγος, di cui avrebbe parlato Archelao nei suoi giambi (SH 131). Anche la Niconoe dell’epigramma è molto probabilmente un’etera, nonostante sia designata come παῖς (v. 4 e n.).
Il componimento presenta una struttura tripartita, condivisa anche da altri epigrammi edilei di dedica (2, 3; cfr. Introduzione IV.4): i primi due versi contengono un elenco di ornamenti femminili, preziosi e raffinati; il distico centrale ne spiega la funzione in relazione a una fanciulla di nome Niconoe, della quale è specificata, con immagine tradizionale, la straordinaria bellezza; il distico finale identifica Niconoe come dedicante e chiarisce la natura anatematica del testo. Il componimento contiene in effetti tutti gli elementi tipici dell’ἀνάθημα: la divinità alla quale è fatta l’offerta, in dativo (v. 5); un verbo di dedica, la specificazione degli oggetti e della ragione per cui essi vengono dedicati (vv. 5–6); il nome della dedicante (v. 3). Anche l’elencazione iniziale, costituita di termini rari e preziosi (non a caso, essa ha suscitato l’interesse dei lessicografi: parti del componimento sono citate in più punti da Suid. e una sorta di parafrasi del distico finale si trova in [Zon.]), è tipica degli epigrammi anatematici, dove gli autori fanno spesso sfoggio di perizia tecnica proprio tramite l’abile collocazione, all’interno del verso, di cataloghi di oggetti. Il componimento di Edilo si distingue però per l’effetto di misdirection: la lista di indumenti che occupa i vv. 1–2 non costituisce, come è tradizionale in questi contesti, l’oggetto della dedica, ma i premi ricevuti dalla dedicante; le attese innescate dall’incipit sono pertanto disilluse, con una sorta di ἀπροσδόκητον che conferisce all’epigramma originalità pur all’interno di una tipologia e di una struttura tradizionali e consolidate.
v. 1 Αἱ μίτραι: tra i molti significati del termine (per i quali cfr. Gow 19522 ad Theocr. 17.19), qui vale probabilmente “fasce per il sen...