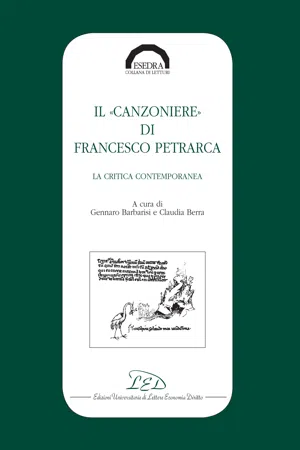![]()
Domenico De Robertis
PETRARCA PETROSO
(1983)
Il jeu de mots sotto cui s’iscrivono le presenti considerazioni (e che non è nemmeno originale, visto che è preso a titolo di un articolo d’analogo argomento – ma vertente soprattutto su raffronti tematici – di una decina d’anni fa1, ha più consistenza di quanto non sembri; e non solo perché ben s’attaglia a chi su l’«altro» nome, quello di Laura, ha fondato le più vertiginose relazioni e l’individuazione dell’intero sistema di valori proposti alla nostra mente, donna-mito-poesia, qual è compendiato nella sublime quadratura delle quartine del sonetto CXCVII dei Rerum vulgarium fragmenta:
L’AURA celeste che ’n quel verde LAURO
[............................................................]
LÀ ’UE2 il sol perde, non pur l’ambra o L’AURO3.
Le ragioni della più recente e più mediocre adnominatio sono di pertinenza e di continuità storica, non d’ordine formale. Ma se l’attributo «petroso» è, com’è noto, estrapolazione d’una categoria interpretativa moderna4, l’invito viene dal sostantivo, anzi dal nome (già potenziato di significato rispetto a quello paterno), con riflesso sulla stessa appellazione della donna, e giusto in quella canzone nella quale sulla «petra» super quam (cfr. Matth. XVI 18) «s’appoggia» la «stanca vita» del poeta5 è edificata la forse più scoperta “imitazione” di un certo Dante di tutto il Canzoniere, la canzone Ne la stagion (L), sul modello appunto di Io son venuto al punto de la rota; senza contare che «petra» prima che «selce», che è la lezione definitiva, stava nel centro stesso delle quartine sopra citate, come exemplum (Atlante convertito in sasso da Medusa) della propria condizione immutabile (e ombra e marmo, agli estremi della seconda terzina, confermano la medesima presenza dantesca). Tutto ciò per dire che la definizione proposta nemmeno dispiacerebbe all’interessato, trova anzi in lui, sotto il rispetto dei nomina come della propria identificazione, una buona autorizzazione; e corrisponde comunque a una pratica quotidiana, a un profondo e durevole riconoscimento. E semmai si tratterà di vedere come le implicazioni stilistiche di una siffatta simbologia si concilino con l’immagine ben affermata della soavità linguistica petrarchesca.
Già a una considerazione meramente statistica della presenza di Dante lirico nel Canzoniere, anche a tenerci ai risultati, ampiamente integrabili (e, si deve aggiungere, necessariamente difettivi proprio per il carattere generale della ricerca, richiedente l’utilizzazione di schemi di larga applicabilità6), degli spogli del Trovato7, emerge l’impressionante apporto delle canzoni per la donna-pietra, nettamente superiore a quello di ogni altra rima o gruppo di rime dantesche8, paragonabili a quello del restante corpus delle canzoni, specie se ci si basi sul numero dei versi (260 su 1380 anche non tenendo conto della scarsamente diffusa canzone Lo doloroso amor) anziché dei componimenti, e avvicinabile, anche qui proporzionalmente, a quello della Commedia; il cui «contare più delle Rime»9 nell’esperienza petrarchesca andrà naturalmente rapportato alla sua incommensurabile estensione testuale (ma anche alla differenza di “genere”), e sulla cui conoscenza da parte di Petrarca non ha più senso che nemmeno si cominci a interrogarsi10. Sulle petrose si stacca a sua volta la canzone Così nel mio parlar voglio esser aspro, dalla quale appunto (ossia dal v. 2, «questa bella petra») discende il citato contrassegno («questa viva petra») del congedo di Ne la stagion, giustamente privilegiata, dunque, dalla citazione, in rappresentanza di Dante (ma di un preciso Dante), nell’epigrafica rassegna della tradizione dei “padri”11 nella canzone Lasso me, ch’i’ non so in qual parte pieghi (LXX), e dalla quale evidentemente “comincia” per Petrarca (come da Nel dolce tempo de la prima etade la propria) la memoria poetica del suo grande predecessore. Da domandarsi se questa canzone, normalmente separata, nella tradizione, dalle altre per la donna-pietra, a loro volta non regolarmente raccolte in serie12, non occupi la posizione di testa, nella sequenza delle 15 che prende nome da Boccaccio, in forza della designazione petrarchesca: con rovesciamento (del resto storicamente giustificato dall’indubbia precocità dell’attenzione del Petrarca) dell’indicazione ricavabile appunto dalla tradizione Boccaccio, e consacrata dalla (tarda) confluenza di Dante e Petrarca nell’estremo rappresentante di mano di Boccaccio di tale tradizione13.
Dante petroso non vuol dire dunque, semplicemente, il tributo pagato, e ad usura, all’esperimento della sestina, che è l’altro vistoso segnale di tale presenza nel Canzoniere, con moltiplicazione dell’exploit giusto per il dantesco numero «nove» (rincalzata dal raddoppio dell’ultima sestina) e conseguente spiegamento della potenzialità novenaria dei due numeri perfetti (6 e 3) operanti all’interno (6 versi, 6 rime ossia parole-rima in 6 combinazioni ossia strofe, per 3 retrogradationes e 3 incroci, FA, EB, DC, conclusi col 3° verso della strofa precedente; e congedo su 3 versi e 3 coppie di rime, per giunta perfezionato da Petrarca a partire dalla sestina 5a, ossia centrale, RVF CXLII, con rigorosa applicazione della retrogradatio cruciata): da strappare davvero «un lampeggiar di riso» dal severo volto del maestro. Fuori della strenua disciplina metrica, la presenza di Al poco giorno non è particolarmente sensibile nelle sestine di Petrarca, ossia non lo è più di quella delle altre rime petrose e in altra sede: salvo per la nodale sestina 5a citata, A la dolce ombra de le belle frondi, del resto ampiamente implicata, come ha mostrato Gorni14, anche con le altre tre canzoni, e che appunto si modula sin dall’attacco sull’incipit dantesco Al poco giorno ed al gran cerchio d’ombra 15 e solo nella prima strofa è tutt’un riaffollarsi di suggerimenti di quella sestina, una riinterpretazione al passato della medesima situazione temporale16. Inoltre, nessuna delle sei parole-rima di quella ricorrono tra le cinquantaquattro delle sestine petrarchesche, peraltro obbedienti alla regola dell’assoluta non-ripetizione nell’intera serie (al limite delle varianti di numero bosco CCXIV – boschi CCXXXVII e notte CCXXXVII – notti CCCXXXII; mentre il richiamo lauro / l’auro XXX – l’aura / Laura CCXXXIX è, nonostante la fortissima adnominatio, d’ordine essenzialmente ideologico), evidentemente in applicazione estensiva del principio delle coblas dissolutas, una sola, tempo, discende dalla canzone-sestina Amor, tu vedi ben, di contro all’impiego di più d’una dalle due canzoni tradizionali (cielo, fronde, piaggia, pioggia da Io son venuto, e forza, fronda, onda, rima da Così nel mio parlar, salvo in qualche caso la variante di numero); laddove tutte le parole-rima e della sestina e della canzone-sestina dantesche sono attestate nel rimario del Canzoniere, e ben cinque delle sei della prima (e in combinazioni rimiche tutte attestate nelle altre due canzoni dantesche) nella sola prima canzone Nel dolce tempo (XXIII); e così buona parte di quelle delle altre due canzoni17. La maggior parte tuttavia (tranne colli e pietra) trovano accoglienza entro il verso della sestina, che riproduce la tipica proiezione all’interno, già sperimentata da Dante (e rilevata da Contini18) della forza semantica di cui è carica la rima; come conferma la ricircolazione all’interno di altre sestine di molte delle parole-rima impiegate.
L’osservanza metrica include d’altra parte le due canzoni convenzionali (con astensione cioè solo dal supremo effort della canzone-sestina), con qualche libertà tuttavia: ché di Io son venuto al punto de la rota la canzone Di pensier in pensier riproduce lo schema metrico, salvo però il settenario in luogo dell’endecasillabo in settima sede e la rinuncia a sigillare con la rima identica la combinatio finale, ossia scegliendo piuttosto l’altro esemplare dello stesso modello, La dispietata mente (per il congedo invece, salvo sempre l’esclusione della rima identica, si attiene alla petrosa, che rispetta la conformità congedo-sirima preferita da Petrarca); così come il modello di Così nel mio parlar traspare nella variante (piedi AbbC anziché ABbC) di Tre donne, finché ce ne sta, ossia per i primi 12 versi (che per Così nel mio parlar vuol dire tutti meno l’ultimo), nella strofa della ballata Di tempo in tempo (CXLIX), com’è ben apparso alla lunga vista di Gorni19. Petrarca insomma tende ad allentare, se non a declinare l’impegno, che appare particolarmente stretto solo per le ballate, tutte, tranne Donna mi vene, poi esclusa dal Canzoniere, riconducibili, dal più al meno, ad esemplari danteschi o pseudodanteschi (ossia che Petrarca potesse ritener tali)20: per una forma cioè nella quale egli appare decisamente sottomesso alla tradizione. Ma il fatto delle canzoni (e per conseguenza delle petrose) riesce per contro assai più indicativo di fronte ad un solo altro caso di conformazione al precedente dantesco, per la canzone In quella parte dove Amor mi sprona (CXXVII) che riproduce, salvo sostituzione di un settenario all’endecasillabo in terzultima sede, e l’introduzione della ben petrarchesca retrogradatio (BA anziché AB) nel 2° piede, lo schema della terza canzone della Vita Nuova, Li occhi dolenti (per il congedo, al solito, Petrarca estende il modello all’intera sirima): con contraccolpi non indifferenti, almeno in prima istanza, ossia nella prima strofa, in sede testuale, anche se con esclusione proprio della canzone servita di modello21. Per il resto la canzone petrarchesca denuncia, di dantesco (non si tien conto naturalmente della fronte su due piedi e tre rim...