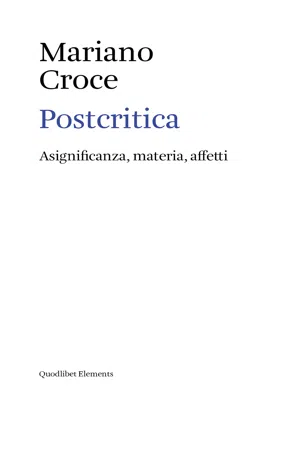
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
Informazioni su questo libro
Scrivere un libro contro la critica non avrebbe alcuna importanza, perché solo importa ciò che crea concetti capaci di tracciare nuove linee. Queste pagine segnano invece il primo gesto postcritico della postcritica, ovvero la rivendicazione del "post": essa reagisce all'inflazione di un suffisso con un esercizio deflattivo. E se la deflazione è la diminuzione del livello generale dei prezzi, la postcritica svaluta sé stessa senza clamore. Essa guarda infatti al minuto, all'interstizio, ai legami che intessono la trama della vita ordinaria, e rifiuta la "proiezione strutturale" delle teorie generali. Ma non è certo una propensione all'agone con la più blasonata delle creature filosofiche, la critica, che fa caricare la postcritica di un suffisso così compromettente. Il "post" non evoca un prima e un dopo, né calca il congedo da una genitrice indesiderata; è piuttosto un "segno", un "cenno", un "signpost", che richiama l'attenzione sul "dove si sta". Siamo in un mondo che certo non abbisogna dell'addio alla critica, ma che alla critica richiede di fermarsi un istante, di accorciare le distanze tra teoria e pratica, di collocarsi sulla superficie dove le cose accadono e si compongono. La postcritica di cui questo libro parla vuole inaugurare un maggese del pensiero filosofico, fatto di contaminazioni disciplinari con l'antropologia, la sociologia, la letteratura, la fisica, la botanica e tante altre, che possano indicare alla filosofia, plenipotenziaria della teoresi, come ascoltare, leccare, odorare e toccare.It would be pointless to write a book against critique, because the only thing that matters is creating concepts that draw new lines. This is why these pages emphasize postcritique's first postcritical gesture, that is, laying claim to the "post": it reacts to the inflation of this suffix with a deflated exercise. And while deflation is the decrease in the general level of prices, postcritique devalues itself without any clamour. For it pays heed to the minute, to the interstice, to the ties that weave the texture of ordinary life. It rejects the "structural projection" of general theories. Yet it is not the aversion to the noblestof the philosophical creatures—critique—that leads postcritique to take up such a compromising suffix. The "post" does not conjure any before and after. It does not mark any break with an unbeloved parent. Rather, it is a "sign, " a "beckon, " a "signpost" drawing attention to "where we are." Although we live in a world that certainly cannot afford to dispose of critique, the latter is called upon to stand still for a moment, to reduce the distance between theory and practice, to find position on the surface where things happen and give life to compositions. The kind of postcritique this book dwells on inaugurates a fallow period for philosophical thought with an eye to producing disciplinary contaminations with anthropology, sociology, literature, physics, botany, and many others. Only in this way can philosophy—mighty lord of theoretical thinking—become able to listen, lick, smell and touch.
Domande frequenti
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Informazioni
TOPOGRAFIA DEL NON-LINGUISTICO
1. La trappola del segno
2. «Una protesta radicale contro l’ineffabile»9
Indice dei contenuti
- Indice
- PROMESSA
- TOCCARE LA SUPERFICIE
- TOPOGRAFIA DEL NON-LINGUISTICO
- LE OPERAZIONI DELLA MATERIA
- LE COMBINAZIONI E GLI AFFETTI
- BIBLIOGRAFIA
- ABSTRACT
- NOTIZIA BIOGRAFICA