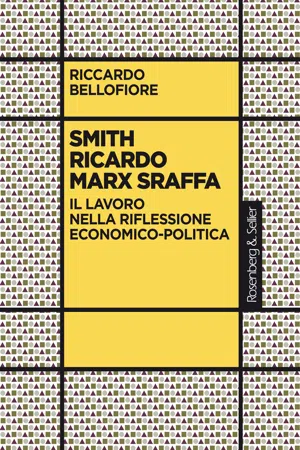
Smith Ricardo Marx Sraffa
Il lavoro nella riflessione economico-politica
- 398 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
Informazioni su questo libro
Il volume propone un percorso di lettura sull'economiapolitica classica, e su Marx, che si prolunga sino all'opera di Sraffa.
Un primo filo conduttore è dato da una visione della teoria del valore che non la riduce a determinazione individuale dei prezzi, ma ne sottolinea l'aspetto macrosociale: in Smith (lavoro comandato) come giustificazione del capitalismo, in Ricardo (lavoro contenuto) come base contraddittoria della teoria della distribuzione, in Marx (lavoro vivo in quanto lavoro astratto in movimento) come indagine sulla costituzione del capitale nel rapporto sociale di produzione.
Contrariamente alle interpretazioni più diffuse, le carte inedite di Sraffa, secondo l'autore, consentono di individuare una forte continuità dell'economista italiano con questo Marx.
Un secondo filo conduttore consiste nella riflessione circa il destino del lavoro nel capitalismo e oltre, che passa per la messa in questione dell'antropologia smithiana del lavoro sino alla liberazione dal lavoro intravista da Keynes, a cui si oppone la marxiana liberazione del lavoro. Ne emerge una visione apertamente contraria alla centralità totalitaria dell'economico, che nelle due appendici al volume si articola con la questione della natura e la questione di genere.
La trasformazione sociale è legata a doppio filo a un cambiamento strutturale della domanda come dell'offerta, e alla ripresa di un protagonismo conflittuale della classe lavoratrice a partire dai luoghi della produzione.
Domande frequenti
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Informazioni
1. A mo’ di Introduzione
Il lavoro nel capitalismo: tra teoria e storia
Il lavoro nel capitalismo: uno sguardo di lunga durata
Thompson: la distruzione di qualsiasi retroterra che nel vecchio sistema consentisse a lavoratori e lavoratrici una parziale possibilità d’indipendenza dal meccanismo capitalistico; la promulgazione delle leggi sui poveri; la violenta riduzione del mondo del lavoro a pura e semplice forza-lavoro sfruttabile a piacimento, non soltanto prolungando nella misura più estesa possibile la giornata lavorativa, ma anche immettendo nel mulinello della produzione capitalistica donne e bambini. Ogni resistenza dentro i processi di produzione poteva e doveva essere stroncata: per il bene di chi lavora, ovviamente… Qualsiasi intralcio al meccanismo economico avrebbe comunque peggiorato, non migliorato, le loro condizioni. A ben vedere, è l’idea «selvaggia» di capitalismo che si è di nuovo imposta ai nostri giorni.
dunque la definizione di quel valore della forza-lavoro – non un dato di natura ma il risultato di una lotta tra le classi –, che costringe le imprese a rispondere con un aumento della forza produttiva del lavoro: insomma, con l’introduzione del progresso tecnico che spinge verso l’alto la produttività del lavoro, e che può rendere compatibili ex post gli aumenti del reddito reale dei lavoratori e la riduzione dell’orario di lavoro. Senza che questo, almeno secondo Marx, porti a una interruzione della tendenza alla caduta del salario relativo – se si vuole, alla riduzione della quota dei salari sul reddito nazionale. Ci sono margini per una lotta «riformista» sino a che ci teniamo sul terreno della distribuzione, anche se l’antagonismo è irriducibile sul terreno della produzione di valore. La spinta al mutamento tecnico e sociale è «interna», e non deriva da una dinamica meccanica: deriva dal conflitto, dall’intervento di esseri umani irriducibili a cose, dalla presenza attiva della classe lavoratrice.
dunque anche che l’accumulazione del capitale può procedere non riunificando naturalmente il mondo del lavoro ma segmentandolo e dividendolo. Ci tornerò.
abbia la possibilità di realizzarsi dentro la relazione con l’altro. Ciò non è possibile se nell’atto stesso del lavoro l’essere umano non è riconosciuto come in rapporto essenziale con l’altro, se dunque non è in grado di intervenire sul «come» e sul «cosa» produrre. Co...
Indice dei contenuti
- Premessa
- 1. A mo’ di IntroduzioneIl lavoro nel capitalismo: tra teoria e storia
- 2. Migliorare la propria posizioneAdam Smith e la missione «civilizzatrice» del capitale1
- 3. Cambiare la natura umanaVariazioni su un tema smithiano, da John Stuart Mill a Keynes e oltre
- 4. David Ricardo oltre l’interpretazione sraffiana1
- 5. Il Capitale come Cosa, e la sua «costituzione»Sulla (dis)continuità Marx-Hegel
- 6. Karl Marx e il «rapporto di capitale»La teoria macromonetaria della produzione capitalistica
- 7. La solitudine del maratonetaSraffa, Marx, e la critica della teoria economica
- 8. Invece di una conclusioneKeynes e le ambiguità della liberazione dal lavoro
- Appendice 1L’ecomarxismo di James O’Connor: centralità del lavoro e questione della natura
- Appendice 2«Continental Divide»: centralità del lavoro e questione di genere
- FONTI