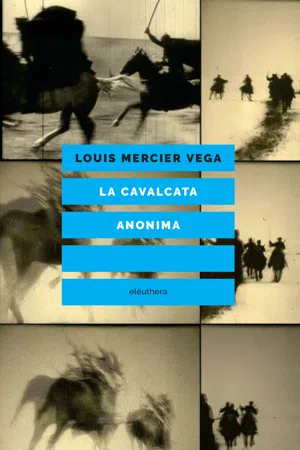
- 176 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La cavalcata anonima
Informazioni su questo libro
Tra romanzo e realtà storica, questo racconto in gran parte autobiografico parla delle migliaia di antifascisti - italiani, spagnoli e tedeschi, ma anche ucraini, cechi e ben presto francesi - che allo scoppio della seconda guerra mondiale cercano disperatamente un modo per sfuggire a quella trappola mortale che sta diventando l'Europa. Braccati dalle dittature che hanno trionfato in patria, scoprono di doversi difendere anche da quelle democrazie liberali che pur proclamandosi antifasciste a questi rifugiati senza documenti e senza diritti riservano solo il campo d'internamento o l'espulsione. Ma anche se la situazione appare disperata, questi uomini - e queste donne - che non si arrendono agli incubi del presente sanno bene che la loro cavalcata anonima, nonostante le sconfitte, non si fermerà. Queste sono le loro storie, storie di solidarietà e fratellanza, narrate da chi era con loro e ne ha condiviso le paure e le speranze, la rabbia e la determinazione.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
capitolo settimo
Buenos Aires, 1940
Il centro di accoglienza per gli ex combattenti di Spagna funziona bene. Si trova in una strada appartata ma abbastanza centrale ed è gestito da un militante di una certa età, che dall’aspetto si direbbe un pastore protestante, gentile ma senza effusioni.
È appunto il «pastore», che si chiama Pio e in realtà fa il linotipista, a fare il punto della situazione: un letto in un hotel non molto lontano, due pasti al giorno in un ristorante operaio che sta lì a due passi, e un peso per le sigarette.
«Per favore cercatevi un lavoro e trovatelo il prima possibile. Noi vi aiutiamo, ma le casse sono vuote. L’entusiasmo per la rivoluzione spagnola è calato, sapete com’è, è più facile sostenere la lotta che la sconfitta. Ormai sono quasi solo i militanti a versare regolarmente i contributi».
La sera, dopo il lavoro, l’atmosfera al centro si anima con l’arrivo di alcuni compagni: Raco, nervoso, pieno di tic, reduce dal fronte di Madrid; Ghilardi, l’organizzatore di tutte le campagne filo-repubblicane, segretario del sindacato degli imbianchini, sempre calmo e sorridente; e poi altri che portano notizie, tirano fuori lettere dalle tasche, informano e discutono. È bello ritrovarsi nel milieu, anche se le tante domande fatte dai nuovi arrivati ottengono solo risposte malinconiche. No, il movimento non è riuscito a rimettersi in piedi dopo la dittatura di Uriburu, che ha spezzato lo slancio politico del movimento di immigrazione, rispedito a casa parecchi militanti e represso duramente le attività di propaganda. No, la repressione non ha rafforzato le correnti, né tantomeno provocato un minimo di collaborazione: i «sindacalisti» e i «puri e duri» continuano a guardarsi in cagnesco, a polemizzare, a farsi la guerra. «Senza scopo» sottolinea Raco. No, lo sforzo per mantenere la lucidità di fronte agli eventi europei perde colpi. Esistono correnti favorevoli agli Alleati, che tendono a semplificare per sentimentalismo, per odio verso il nazismo.
Un certo numero di militanti è sempre in prigione. Le misure poliziesche limitano le attività. Raco, per esempio, non può lasciare la capitale federale per andare nelle periferie più lontane o in provincia per le riunioni o gli incontri.
Molti sindacati sono in crisi. Le centrali hanno perso forza e coesione. Anche le roccaforti, come i trasporti urbani, i cantieri navali, l’edilizia, attraversano periodi bui.
«Andate a vedere con i vostri occhi, fate il giro dei sindacati, parlate con i militanti. Lo slancio degli anni Venti si è estinto e il nuovo impulso si fa attendere».
I quattro compari se ne vanno a consumare il loro primo pasto. Il gestore del ristorante è un sardo massiccio, chiacchierone, che nasconde una naturale bonomia dietro una parlata alquanto rude. Serve a ognuno di loro una bistecca di manzo impressionante, più grande del piatto, accompagnata da un vino rosso denso e a forte gradazione, e poi li osserva con aria beffarda. Un’arancia per finire. Il quartetto si sente rinvigorito e cominciano a definirsi alcuni progetti, ancora senza fondamento, ma basati su una certa fiducia.
Dalla via si alza una musica che sembra un lamento interrotto da bruschi singhiozzi. Danton scosta un angolo della tenda: è un organetto. A girare la manovella un ometto con la pelle e i capelli scuri. Il sardo osserva la scena da dietro il bancone, poi fa una smorfia e si mette a parlare, senza rivolgersi a nessuno in particolare, come se parlasse a se stesso, con lo sguardo perso:
«Eccone un altro che è venuto a trovare qui l’America, povero imbecille! Ha lasciato la miseria all’aria aperta per la miseria in città. E sta qui a macinare la sua musica per dei disgraziati come lui. A mendicare. Sognava una vita facile, soldi a palate, e si ritrova a spingere un carretto a due ruote e a contare gli spiccioli!
Anche io avevo dei sogni quando sono arrivato, ormai trent’anni fa. Nei villaggi di montagna, laggiù dalle mie parti, nel Gennargentu, c’era la miseria. Niente lavoro. Nessuna speranza. Nasci povero e muori miserabile. Ma, dio boia, la polenta di castagne non costava niente e nemmeno il formaggio di capra. Non avevamo lavoro ma mangiavamo lo stesso.
Invece qui bisogna ammazzarsi di lavoro per riuscire a vivere. E senza avere più sogni. Sarebbe stato meglio lasciarla lontana l’America, e magari sognarla di tanto in tanto.
Adesso son qui senza le mie montagne, senza i miei amici, a sciacquare bicchieri e a servire minestra a gente come voi… Che vita di merda! Gli uomini sono proprio stupidi, me compreso».
Su questo assesta un gran pugno sul bancone.
«Prendetevi una grappa, offro io. Anche se non ci conosciamo, so benissimo che siamo tutti dei poveracci».
L’organetto si è allontanato; ora si sente in sordina, a due isolati di distanza, una nuova tappa della stessa illusione.
E ora in marcia, bisogna esplorare, capire. Willy parte per conto suo, con in tasca alcuni nomi tedeschi. Bianchi invece va a cercare i suoi contatti italiani. Danton e Parrain sono gli ultimi a uscire.
Allontanandosi a piedi dal centro, lo splendore della grande città diventa presto soltanto un ricordo. All’orizzonte si profila la sterminata periferia: chilometri e chilometri di isolati dall’aspetto identico. L’espressione «alzare la polvere», usata dagli sterratori parigini per indicare la ricerca di un lavoro, qui diventa immediatamente comprensibile. Ci vogliono due ore di cammino per trovare, vicino a La Boca, la sede degli addetti alle riparazioni navali. Ben che vada ce ne vuole almeno un’altra per parlare dieci minuti con un militante del settore metallurgico.
Trascorrono ogni giorno a battere isolato per isolato, cuadra per cuadra, in una ricerca che li immerge nel viavai popolare di quell’enorme porto brulicante dal quale non si vede l’oceano e sul quale non soffia mai la brezza marina. Il caldo è umido, i piedi si gonfiano, il colletto della camicia si fa appiccicoso. E tutti quei quartieri che si assomigliano finiscono per far dubitare del proprio senso dell’orientamento. Sempre e solo case basse ricopiate sullo stesso modello: la porta a due battenti, una o due finestre al piano terra, qualche volta un piano superiore o una terrazza con i panni stesi ad asciugare. Anche gli incroci, con gli stessi bar e negozi, finiscono per confondersi. Strade infinite dove cambiano solo i numeri.
Per un’intera settimana ripetono sempre le stesse azioni, che finiscono per diventare routine: si ritrovano, spesso in ritardo, a pranzo e subito dopo, nonostante le gambe stanche, si mettono di nuovo in marcia e si rivedono la sera in centro per cenare insieme e infine salire nella camera comune.
È Willy il primo ad andarsene. Ha trovato un lavoro: occuparsi di un motore diesel da qualche parte nel Sud, vicino a Comodoro Rivadavia.
«Pare che il posto in cui vado sia in mezzo al nulla. Grandi spazi, greggi a non finire e qualche mandriano».
«Andrai a cavallo!» si estasia Danton.
«Sì, forse. Anche se gli unici cavalli che conosco sono quelli della miniera. Ma laggiù dev’essere un’altra cosa».
«Se ogni tanto vai in città» gli dice Ghilardi, «lì c’è un gruppo formato dai sopravvissuti ai massacri della Patagonia e da altri compagni cileni. Non sarai solo».
«La solitudine non mi fa paura, anzi mi farà bene. E poi un diesel è un buon compagno».
Qualche tempo dopo anche Bianchi se ne va. Parte per Montevideo, ha già i documenti, là ritroverà due italiani scappati in Uruguay dall’Argentina dopo la caccia ai clandestini dell’era Justo. Sembra che se la passino piuttosto bene, visto che sono riusciti a mandargli un centinaio di pesos per il viaggio.
La sera della partenza tradiscono il sardo e vanno a mangiare una parrillada in un grande ristorante vicino all’ingresso del porto dove si balla e si canta. Bianchi ha già la testa altrove e ascolta con aria distratta le canzoni gitane, le arie italiane e i tanghi che compongono il repertorio di un indemoniato gruppo musicale che si esibisce senza dare tregua. Parla di Montevideo come se ci avesse vissuto tutta la vita.
«Hai l’aria di uno pronto prendersi la sua vendetta» gli fa notare Parrain.
«È vero, è così. Voglio vendicarmi di tutta la stronzaggine umana».
«Guarda che rischi di rimetterci le penne» dice Danton per frenarlo. «La società è un animale che sa difendersi. Lo sai che fine fanno gli espropriatori. Anche qua, pensa a Di Giovanni… I soli a sopravvivere sono stati quelli che hanno saputo ritirarsi in tempo».
«Sì, lo so, non c’è bisogno che me lo spieghi. Ma è sempre meglio che continuare a fare lo zerbino».
Cambiano discorso. Non serve a niente discutere di un argomento trito e ritrito. Ognuno prenda la strada che vuole, a condizione di rispettare la morale non scritta.
Parrain e Danton sono assunti per qualche giorno come «controllori» di una linea di mini autobus. Devono verificare gli orari di passaggio per sei ore.
Un compagno della fora li istruisce sul lavoro da fare: «Esistono diverse linee di autobus gestite in modo cooperativo, ma i mezzi sono spesso di proprietà dei loro autisti. E questi devono rispettare l’itinerario fissato. È la nostra organizzazione che controlla. Comunque, per quanto vi riguarda, è una soluzione provvisoria, perché è un lavoro che di solito diamo ai compagni che escono di galera e hanno bisogno di rimettersi in marcia».
Finalmente arriva un lavoro serio. Sono assunti come tornitori in un’officina metallurgica. Gesti semplici e veloci da imparare. Una monotonia che appare loro addirittura riposante: fissare il pezzo, far scorrere in avanti l’utensile, avviare il motore, indirizzare il getto d’acqua saponosa, spegnere il motore, far scorrere all’indietro l’utensile, estrarre il pezzo, metterne un altro. Sono al servizio della macchina per otto ore, interrotte solo da una pausa pranzo di un’ora. Sono la macchina.
Si trasferiscono in una pensione frequentata da militanti. I conti sono presto fatti: guadagnano ottantotto pesos al mese e ne spendono settanta per la pensione. Non è di certo la bella vita, ma almeno hanno la soddisfazione di non dipendere più dalle casse del centro per i rifugiati.
Alla pensione abita anche Duque. All’alba è già in piedi, nelle mani deformi ha sempre un mate, mentre la bocca sottile e maliziosa succhia dalla bombilla.
La prima domenica punta gli occhi verde pallido sui due nuovi arrivati e attacca: «Che fa il movimento in Francia? E in Inghilterra? E voi che ci fate qua?».
Danton e Parrain sono sorpresi da quell’interrogatorio. Pensano che nasconda una punta di rimprovero. Invece è solo curiosità, interesse, desiderio di non farsi sfuggire niente.
Parrain si sforza di spiegargli che non si può più parlare di movimento: «Un movimento esiste solo nei periodi di lotta, di rivendicazione, di assalto o di difesa. Oggi rimangono gli individui. E sai benissimo che quando un movimento perde lo slancio, i difetti di ognuno vengono fuori e assumono una rilevanza enorme; proprio come in un fiume in magra appaiono le carcasse e i detriti che ne ingombrano il letto. La nostra forza è stata spezzata in Spagna. Altrove non c’era niente di abbastanza solido da resistere in tempo di guerra, di fronte alla mobilitazione condotta dallo Stato».
Duque, ben piantato sulle gambe, la spalla destra più bassa della sinistra, l’espressione vagamente sarcastica, sempre un po’ proteso per afferrare meglio le parole, sorride. È abituato alle situazioni tragiche. A vent’anni, quando animava i gruppi studenteschi, è stato colpito da una pallottola nella schiena e si è ritrovato sbilenco. Non si è mai lamentato. Ha semplicemente continuato a militare, a organizzare campagne, a ricompattare clan fratricidi e a fondare giornali. Repressioni, miseria, polemiche, sconfitte, niente è riuscito a cambiarlo. Il movimento, nonostante o forse proprio a causa di quella pallottola sparata da un compagno che gli ha stroncato la giovinezza, è diventato la sua unica ragione di vita.
«Allora non c’è più niente da fare?».
«Certo che sì. Prima di tutto, non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze, né dalle propagande o dalle semplificazioni. Ci sono periodi in cui non si riesce a cambiare le cose. È meglio metterselo in testa, invece di nascondere l’impotenza dietro gesti inutili, o peggio ancora imbarcarsi su una nave che non è la nostra».
Questa volta è stato Danton a parlare.
«Ma non c’è più nessuna organizzazione?» chiede ancora Duque.
«No. Quelle che esistevano non erano evidentemente adatte ad affrontare una guerra generalizzata. Ne nasceranno altre, man mano che i problemi alimenteranno lo scontento, che l’assurdo diventerà palese. Per il momento, nella migliore delle ipotesi, rimangono solo i militanti capaci di restare lucidi e di esprimere i bisogni dei vari strati sociali quando la guerra batterà cassa».
«È una guerra antifascista…».
«È una guerra. Con le sue origini profonde, le sue ragioni storiche, le sue motivazioni. Il nazionalismo, il trattato di Versailles, le rivalità tra potenze industriali espansioniste».
«Ma Hitler è un pericolo diverso dallo sfruttamento borghese, che è pur sempre contenuto da una relativa democrazia e controbilanciato dai movimenti operai…».
«Ora non fare quello che difende la democrazia. In Spagna, con altre parole e altri mezzi, le democrazie e i fascismi hanno entrambi vietato l’esperienza operaia e contadina».
«Lasciare che la Francia venga sconfitta forse non è il modo migliore per gettare le basi di una rinascita socialista».
«La Francia sarà sconfitta proprio perché non ha voluto scegliere tra le soluzioni più realistiche: o una dittatura di destra con una classe operaia rimessa in riga, o una vera e propria democrazia industriale, operaia, come si era profilata durante gli scioperi del ‘36».
Duque non approva e non critica. Si versa ancora del mate e succhia la sua bombilla. Segue un momento di silenzio in cui tutti rimuginano i propri pensieri.
«E… i compagni inglesi?».
«Pochi ma decisi e in aumento. Hanno messo su un giornale, il ‘War Commentary’. Resisteranno».
«Grazie alla democrazia britannica?».
«In base alle circostanze in cui si trovano a vivere e a lottare».
Un nuovo silenzio. Duque continua a guardare i suoi interlocutori come un entomologo osserva uno scarabeo che cammina.
«Staremo a vedere. Se volete, cercheremo di vedere insieme».
Le camere della pensione sono spoglie. Spogli i muri, spoglie le mattonelle. Un letto basso, una o due sedie e un comò. Sembra che i suoi abitanti siano perennemente di passaggio.
Danton e Parrain salgono sulla terrazza, dalla quale si vedono solo altre terrazze. Duque è rimasto al piano terra. Aspetta due compagni dei Frigoríficos che stanno preparando le elezioni sindacali.
«Quell’uomo è il diavolo» dice Danton, senza precisare se si riferisce all’aspetto o al modo di porre domande dell’argentino.
A pranzo ci sono sempre facce nuove, soprattutto la domenica. Poche discussioni durante la masticazione. Ma subito dopo si formano crocchi, tra cui circola senza sosta il mate, e si organizzano conciliaboli.
A gestire la pensione è Camela, una bella donna di fattezze ispaniche, alta e con un’andatura da portatrice di anfore. Controlla che i bollitori d’acqua siano sempre in circolazione e, senza farsene accorgere, ha un occhio di riguardo per Duque. Sembra una simpatizzante che preferisce non ascoltare per essere sicura di non sapere e dunque di non poter riferire nulla.
Parrain e Danton si incamminano verso il centro, senza fretta. Si divertono a guardare i poliziotti impegnati a scacciare dalle strade eleganti i vagabondi che non indossano giacca e cravatta. Nonostante il caldo umido, guai a chi osa avventurarsi in maniche di camicia nel quartiere con le boutique di lusso: viene subito respinto verso la periferia. L’uomo civile indossa la giacca. Così, per aggirare l’ostacolo, ci sono quelli che, soprattutto la mattina, indossano la giacca del pigiama.
«Che ipocrisia» commenta Danton.
«Influenza della mentalità meridionale, spagnola e italiana» risponde Parrain, che cerca di capire.
In officina scoprono una forma di cultura operaia che li manda in bestia. Il loro vicino di tornio, un uomo sulla trentina di origine siciliana, ogni sera, dopo il lavoro, passa una buona mezz’ora a travestirsi da gentleman. Comincia la cerimonia stirando quello che deve essere l’unico paio di pantaloni che possiede: prima li appoggia su una panca di metallo, poi li piega e li pressa con un ferro lucidissimo. Quindi si acconcia i capelli, impomatandoseli ben bene con il grasso per i macchinari e, per finire, si strofina con un panno le scarpe, anche se la tomaia è lacera e i tacchi sono consumati per un terzo.
Con il passare dei giorni finisce per instaurarsi una certa confidenza. Scoprono che si chiama Segundo e che è fidanzato. «Da otto anni» precisa. Gli altri due restano senza parole.
«Come sarebbe a dire da otto anni? Ma perché?».
«Perché prima di sposarci dobbiamo comprare i mobili».
«Sì, va bene, ma nel frattempo…».
«Ah, no davvero! La famiglia della mia fidanzata è molto severa e lei è una brava ragazza».
Gli altri due si scambiano un’occhiata, combattuti tra la voglia di ridere e quella di piangere. Segundo guadagna esattamente quanto loro, dunque deve risparmiare sul cibo per potersi comprare una camera da letto e una sala da pranzo. Anni e anni di miseria per poter finalmente fare un matrimonio come si deve e andare a letto con la sua amata.
Nell’officina lavorano una cinquantina di operai: qualche ceco, due o tre tedeschi, due francesi e ovviamente un po’ di argentini. Fabbricano pezzi di piccola taglia, in serie limitate, con una precisione relativa. L’azienda funziona perché le importazioni sono praticamente ferme e la domanda di accessori da parte delle aziende aumenta di continuo.
Fuori dall’officina, dove si è invece stabilita un’intesa naturale, i compagni di lavoro non si frequentano quasi mai. Niente chiacchiere, nessuna bevuta. Probabilmente per molti è ancora troppo vivo il ricordo della disoccupazione dilagante tanto in Europa quanto a Buenos Aires per concedersi un po’ di svago.
Danton cerca di sondare i suoi vicini di tornio per sapere se c’è una sezione sindacale, o se è possibile discutere delle paghe. Per tutta risposta riceve solo sorrisi educati o alzate di spalle. Poi un giorno un attrezzista francese lo ammonisce: «I ragazzi sono tutti contenti di poter lavorare. Sono rimasti a bocca asciutta per mesi, alcuni per anni. Sanno benissimo che sarebbe facile sostituirli. Quindi, capisci bene che…».
«E tu?».
«Io? Io sono un attrezzista. Prendo una paga che è tre volte la tua....
Indice dei contenuti
- Frontespizio
- Colophone
- Prefazione
- Titolo
- Disegno
- Capitolo primo
- Capitolo secondo
- Capitolo terzo
- Capitolo quarto
- Capitolo quinto
- Capitolo sesto
- Capitolo settimo
- Capitolo ottavo
- Capitolo nono
- Capitolo decimo
- Capitolo finale
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a La cavalcata anonima di Louis Mercier Vega, Gaia Cangioli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Narrativa storica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.