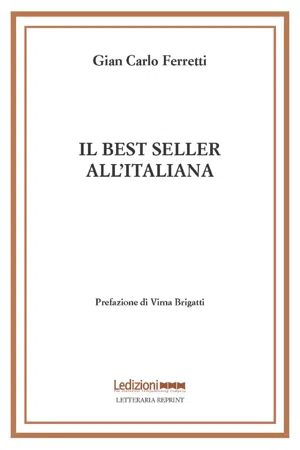![]()
A LIVELLO MEDIO
Un problema «secondario»
La repubblica (e industria) delle lettere in Italia è venuta assomigliando sempre più a certe famiglie patrizie d’altri tempi: di blasone un po’ stinto e riverniciato con qualche vantaggioso matrimonio plebeo, di molta vecchiezza e poca gioventù, e di scarsa frequentazione comunque da parte di estranei. Fuor di metafora, l’area di produzione-consumo del romanzo italiano «di qualità» appare sostanzialmente ristretta, rigida, senza un vero ricambio nei suoi lettori e nei suoi autori.
Bastano 100.000 copie vendute per far gridare al miracolo, mentre le medie restano basse e il pubblico circoscritto a un ambito piccolo-medio borghese, anagraficamente maturo. Tra gli scrittori, poi, quelli nuovi sono per lo più «stagionali», vanno difficilmente oltre il primo libro, e appartengono a un «giro» molto interno a un certo mondo giornalistico-accademico-editorial-salottiero: giornalisti celebri che piegano la loro esperienza a romanzo; madri e figlie e zie di affermati intellettuali che trasformano la loro biografia più segreta in prodotto; universitari e cineasti, editoriali e televisivi che fanno la scalata alle classifiche dei best sellers. Gli scrittori noti, per contro, o scrivono troppo con una cadenza e consonanza con il mercato tanto negata quanto sospetta, o si dedicano alla «riscrittura» dei loro libri passati (diventata ormai una definizione istituzionale, come l’opera prima o l’opera postuma).
Questi tratti, volutamente tendenziosi, non rispettosi dei criteri di valore e indifferenti alle eccezioni che pur caratterizzano il quadro, vogliono introdurre ad alcuni interrogativi: si può parlare di una crisi di vitalità del genere e del prodotto romanzo? Una crisi diversa dalle precedenti, che sembra investire al tempo stesso le tradizioni letterarie di cui esso si è nutrito, la sua capacità a crearsene di nuove, la politica dell’industria culturale in questo campo, e il pubblico dei lettori-consumatori? Le ragioni di fenomeni come questo, si sa, sono sempre generali e lontane, vaste e profonde; riguardano la storia della società e della cultura, le strategie editoriali e l’andamento del mercato. Ma sarà forse il caso, una volta tanto, di indicarne una abbastanza vicina e specifica, anche a rischio di esporsi all’accusa di parzialità.
Non pochi aspetti cioè del quadro appena descritto, sembrano riconducibili al compromesso che si è venuto realizzando tra la grande industria editoriale e la corporazione letteraria, e che contrassegna in tal modo il livello più contraddittorio e «arretrato» dell’universo tardocapitalistico della comunicazione: trovando un suo momento emblematico nell’equivoco rapporto tra ricerca del successo e mito della gloria, variamente alimentati e combinati (non senza ipocrisie) dalle due controparti.
Da un lato, dunque, un’editoria che non è più tradizionale e non è ancora moderna, che non fa più ricerca e si limita a sfruttare le vecchie risorse fino in fondo, che non rischia nelle sue scelte e si rivolge sempre allo stesso pubblico; e, dall’altro, una repubblica delle lettere più indaffarata a consolidare se stessa che a promuovere nuove forze, più preoccupata di allearsi ad altre potenti corporazioni (giornalistiche, televisive, cinematografiche) che di mantenere vivo il dibattito al suo interno, e ben attenta per lo più (anche quando afferma il contrario) a non far entrare in conflitto la vecchia scrittura con il nuovo mercato, il blasone con il fatturato, la figura privata dello scrittore con la sua figura pubblica.
Non potrà non derivarne, tra le molte altre cose, l’accentuazione della cronica carenza o assenza in Italia, rispetto ad altri paesi, di spregiudicati scrittori professionisti o di agguerrite équipes, di romanzi commerciali ben costruiti, di una moderna e dichiarata produzione di massa, e per contro la pletora di romanzi fondati su problematiche paleoelitarie e scritture neoconsumiste (e viceversa): dove la discriminante è, pur all’interno di una logica consumistica, tra la presenza o assenza di quell’equivoco di fondo.
Se poi si considera quest’area di produzione-consumo del romanzo «di qualità» sullo sfondo del faticoso e difficile processo di apprendimento e di emancipazione di massa nella società italiana, essa finisce per apparire come un terreno «secondario» di lavoro e di verifica rispetto ad altre, più vivaci e fervide e vaste aree di produzione-consumo culturale (basta pensare, per forzato contrasto, alla musica giovanile): tanto sensibili queste, quanto refrattaria quella, alle modificazioni sociali e ai sommovimenti culturali dell’ultimo quindicennio.
Blasone e fatturato
Perché occuparsene, allora? Per il piacere cattivo di una polemica facile o per una sorta di oscuro autolesionismo? Il fenomeno in realtà, proprio grazie ai suoi limiti e vizi, può dire qualcosa di non provvisorio e di utile. Vi si possono ritrovare anzitutto, allo scoperto, le linee di una politica editoriale che (anche ben oltre il romanzo italiano «di qualità») non è più di élite ma non è ancora di massa. Quel compromesso, in particolare, avviato negli anni sessanta in una situazione di relativa vivacità produttiva, consolidato nei primi anni settanta e approdato oggi a un sostanziale immobilismo, ha rappresentato un aspetto di un più generale tentativo (contraddittorio e in gran parte fallimentare) di risposta a due carenze storiche fondamentali. Da un lato la «tradizione di casta» degli intellettuali italiani, la mancanza di una «moderna» letteratura «popolare», il nesso di problemi insomma analizzato magistralmente da Gramsci (quando si sappia isolare il nucleo più attivo del suo pensiero dai residui romantici che talora lo impacciano in queste pagine). Dall’altro, la tradizionale ristrettezza in Italia dell’area della lettura (e di quella libraria in particolare), che, nonostante indubbie modificazioni al suo interno e progressivi ampliamenti nel corso del Novecento, non è mai andata oltre una certa soglia. E qui lo sviluppo editoriale tra le due guerre, coincidente in gran parte con quello mondadoriano, appare davvero emblematico e determinante.
Se è vero infatti che Mondadori, con una strategia produttiva ricca e articolata, operò una «ricomposizione unitaria del pubblico», nel segno della modernizzazione e dell’adeguamento internazionale, e all’interno di un rapporto complesso con il fascismo (tra coincidenza di interessi e spregiudicatezza di scelte, tra ricerca del profitto e del consenso), sembra altrettanto vero che la sua operazione riguardasse essenzialmente le varie componenti borghesi della società, riorganizzate dentro un mercato più ampio e moderno appunto e anche più raffinato, che nonostante le sue novità emarginava di fatto gli strati popolari subalterni. Certo, qui c’è ancora molto da indagare, ma la persistenza di un mercato «basso» e la «decisa spaccatura nel paese» tra lettori (borghesi) e non-lettori (subalterni) tendono piuttosto ad avvalorare che a contraddire questa ipotesi. Cui andrebbe aggiunto un limite, troppo spesso dimenticato, di quella operazione che si evidenzia nella prevalenza, all’interno del catalogo mondadoriano, della produzione lato sensu «letteraria» rispetto a quella tecnico-scientifica, in consonanza con la cultura egemone del tempo.
Ora, sostenere che la modernizzazione della produzione e del consumo fu compiuta sostanzialmente a spese degli strati popolari subalterni, non significa certo ignorare condizionamenti oggettivi come il fascismo o l’analfabetismo, ma indicare le linee di una politica editoriale realizzata proprio all’interno di questi condizionamenti, non senza analogie con quella più generale emarginazione di grandi masse dalla vita politica e culturale che va dall’Italia fascista all’Italia democristiana. Strategia delle «due culture» dunque (élites e «popolo», lettori e non-lettori), politica del libro «di qualità» destinato a un pubblico piccolo-medio borghese, prevalenza del «prodotto letterario», limitato allargamento dell’area sociale della lettura, eccetera: tendenze che neppure altri diversi e importanti fenomeni riescono a modificare (si pensi soltanto ai nuovi fermenti intellettuali e all’editoria «di punta» degli anni trenta e quaranta), e che nei loro ultimi aspetti arrivano talora fin quasi a oggi.
E infatti, dopo una fase di crisi del processo in coincidenza con i rivolgimenti e conflitti della Liberazione e del dopoguerra (che ne mette in discussione le stesse premesse di fondo, riassumibili appunto in una «ricomposizione borghese» condotta a spese degli strati subalterni), quegli ultimi aspetti, tra gli anni cinquanta e sessanta, nella fase di trapasso dalla strategia delle «due culture» a una più articolata e relativamente moderna strategia consumistica, trovano un significativo momento di sintesi nel primo boom del romanzo italiano «di qualità»: di un romanzo, cioè, intimamente tradizionale nonostante «restauri» e attualizzazioni, e di una politica editoriale volta a creare il «capolavoro di successo». Anche se bisogna distinguere, per la precisione, una prima fase di fortuna quasi inattesa, legata a situazioni ancora preindustriali, a curricula letterari specifici, ad alleanze intellettuali con proprie logiche interne, a una «qualità alta» del prodotto; e una seconda fase che vede l’intervento sempre più consapevole e organizzatore della grande industria culturale, una tendenziale definizione della «qualità media», e vede ancora (a partire dalla seconda metà degli anni sessanta) questa stessa industria e la corporazione letteraria cercare programmaticamente una conciliazione delle rispettive esigenze, dei privilegi dello scrittore di élite e della conquista di spazi sul mercato, nel segno della «qualità media» appunto e del best seller «d’autore».
Quanto ai titoli e ai nomi (per restare qui ai più noti), se alcuni appartengono decisamente alla prima (dal Gattopardo al Giardino dei Finzi-Contini, da Pratolini a Testori); altri attraversano l’intero processo (da Cassola a Chiara), e altri ancora tendono a qualificarne soprattutto la seconda e terza fase (da Arpino a Castellaneta, da Prisco alla Lagorio). Con riflessi anche nelle sigle editoriali, che vanno sostanzialmente da quelle di Vallecchi, Feltrinelli, Einaudi, in diverso modo e almeno in parte ancora «eccentriche» rispetto alla grande industria culturale e dell’informazione, a quelle delle concentrazioni, Mondadori ma soprattutto Rizzoli. Titoli di opere e nomi di autori indicativi, che alludono ad altri ancora, e che si anticipano qui per dar corpo a ombre troppo a lungo agitate (la critica letteraria italiana, quando parla dei rapporti più o meno oscuri tra scrittore e mercato, non nomina mai nessuno): con la consapevolezza delle specificità e differenze che caratterizzano gli stessi autori del romanzo medio, di cui soprattutto si parlerà qui (da Cassola a Chiara ad Arpino agli altri citati e a quelli che si incontreranno via via), ma con la consapevolezza altresì di una tendenziale prevalenza delle co...