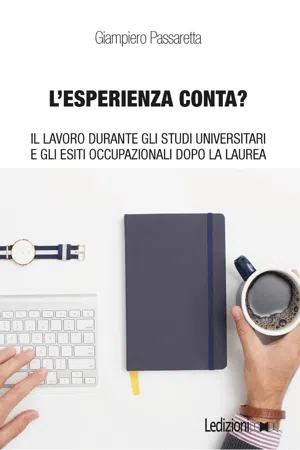![]()
1. LAVORARE DURANTE GLI STUDI: APPROCCI TRADIZIONALI E NUOVE PROSPETTIVE
1.1. L’eterogeneità delle ricerche pregresse
La questione del lavoro durante gli studi è stata argomento di fervido interesse per diverse discipline. Nel corso degli anni sia sociologi che economisti si sono appassionati ad un tema per sua stessa natura molto complesso, anche perché interconnesso con il più ampio dibattito circa i mutamenti sociali, culturali ed istituzionali delle società occidentali. Tale complessità non si riflette solamente nella molteplicità degli approcci adottati, ma anche nella diversità degli ambiti considerati: non solo i ricercatori si sono concentrati sul ruolo del lavoro da diversi punti di vista, ma lo hanno fatto anche all’interno di contesti territoriali differenti ed in relazione a diversi livelli del percorso di studi. Queste caratteristiche rendono la letteratura sul tema estremamente diversificata e difficilmente intellegibile ad un primo sguardo. Riteniamo dunque utile chiarire i fattori principali secondo cui le diverse ricerche si differenziano, allo scopo di facilitare la comprensione del tema centrale di questo libro e del contesto accademico in cui si inserisce. L’obiettivo non sarà offrire una puntuale sistematizzazione delle ricerche sul tema, ma proporre una rassegna non esaustiva, che però risulterà funzionale alla specificazione dell’approccio che adotteremo.
Sono principalmente tre fattori a costituire la griglia entro cui la varietà delle ricerche può essere ricondotta: 1) gli outcome considerati; 2) il livello educativo; 3) il/i contesti nazionali di riferimento.
Il primo fattore si riferisce alla specificità delle relazioni indagate in ogni singolo lavoro di ricerca. Il lavoro durante gli studi è stato di volta in volta considerato in rapporto a diversi outcome, relativi sia al percorso di studi che a al mercato del lavoro. Da questo punto di vista è netto lo squilibrio a favore del primo ambito. Gran parte degli accademici che si sono occupati del lavoro durante gli studi, lo hanno fatto in relazione all’effetto che questo può esercitare sul rendimento scolastico, sia termini di voto che in termini di abbandono e ritardo degli studi. Meno indagato è invece il tema del suo effetto sui risultati nel mercato una volta completati gli studi, che è invece specifico argomento di questa ricerca.
Il secondo fattore di diversificazione considera i diversi “stadi” del percorso di studi su cui si è focalizzata l’attenzione. Alcune ricerche si sono concentrate sul ruolo del lavoro nell’istruzione terziaria, altre invece si sono occupate di indagarne le implicazioni a livello d’istruzione secondaria. In questo caso si registra un leggero squilibrio a favore del secondo aspetto, dato che minore attenzione è stata dedicata al ruolo dell’occupazione durante l’istruzione superiore (Riggert et.al. 2006). Dobbiamo però riconoscere che nel corso degli ultimi decenni l’attenzione al livello universitario è stata crescente, soprattutto in ragione di alcune tendenze generali che discuteremo tra non molto.
Il terzo fattore riguarda i contesti nazionali entro cui le indagini sul tema sono state condotte. Il ruolo del lavoro durante gli studi è stato principalmente considerato all’interno di singoli contesti nazionali e meno in chiave comparativa. Inoltre, le ricerche pregresse sembrano concentrarsi in alcuni paesi. Il semplice fattore demografico sembra aver influenzare notevolmente la mole della produzione scientifica nei diversi paesi, con il risultato che gran parte dei contributi accademici su cui possiamo contare oggi si sono concentrati sui contesti dove la produzione scientifica è in generale più prolifica. Questa considerazione contribuisce parzialmente a chiarire perché buona parte delle ricerche che si occupano del lavoro durante gli studi si riferisca al contesto statunitense. Grande attenzione al tema è stata però riservata anche in ambito britannico, dove però l’aspetto demografico non offre una spiegazione soddisfacente. Infatti, in entrambi i contesti sembrano esistere condizioni che potrebbero spiegare la maggior propensione ad occuparsi della tematica. I fattori contestuali relativi alle specificità nazionali rivestono, infatti, un ruolo determinante nell’orientare l’attività accademica verso certi temi piuttosto che su altri. È dunque probabile che la specificità dei relativi assetti istituzionali abbia contribuito a determinare un ruolo particolare del lavoro durante gli studi, portando di conseguenza il fenomeno all’attenzione dei ricercatori.
Un analogo meccanismo è probabilmente alla base della diversa attenzione prestata agli altri due fattori secondo cui la letteratura sul tema si differenzia. Le scelte relative agli outcome su cui valutare il ruolo dell’esperienza lavorativa durante gli studi che ed al livello scolastico in cui farlo dipendono dagli obiettivi generali delle singole ricerche, che a loro volta sono influenzati da elementi contestuali e contingenze nazionali. Questo duplice meccanismo di selezione non solo ha determinato la concentrazione della produzione scientifica sul tema in Regno Unito e Stati Uniti, ma ha anche favorito la focalizzazione degli autori sull’effetto che il lavoro durante gli studi terziari può avere sulle performance accademiche.
Ma quali sono le condizioni del contesto anglosassone che possono aver favorito la crescente attenzione al ruolo dell’esperienza lavorativa sulle performance accademiche? Discuteremo questi aspetti nel prossimo paragrafo, focalizzandoci sugli Stati Uniti prima e sul Regno Unito poi, mostrando come in entrambi i contesti siano rinvenibili dinamiche simili. La risposta a tali domande, lo vogliamo ricordare, non sarà finalizzata all’analisi dettagliata del contesto e della letteratura anglosassone, bensì alla migliore comprensione dell’approccio che verrà introdotto nella parte finale di questo capitolo.
1.2. L’approccio anglosassone ed il contesto europeo
La precoce espansione complessiva del sistema di istruzione superiore ha posto le basi per una maggiore attenzione verso il fenomeno del lavoro durante gli studi negli Stati Uniti. In primo luogo, l’espansione ha generalmente messo in risalto le tematiche inerenti all’istruzione terziaria nel dibattito pubblico e accademico. In secondo luogo, l’espansione ha comportato una minor selettività nei confronti della popolazione studentesca, determinandone in definitiva una maggiore differenziazione (Trow, 2006; Brennan, 2004). Ciò ha inevitabilmente portato ad una crescita sostanziale sia nel numero assoluto di studenti universitari impegnati in attività lavorative, sia nella loro quota nei confronti degli studenti a tempo pieno. Parte dell’attenzione dedicata all’occupazione durante il college può quindi banalmente risalire alla crescente portata del fenomeno. Negli ultimi quarant’anni frazioni crescenti di studenti hanno conciliato studio ed occupazione, tanto da impedire alle istituzioni universitarie di considerare scontato l’impegno a tempo pieno degli studenti nelle attività accademiche (Riggert et al. 2006). Il fatto che tale crescita abbia riguardato esclusivamente gli studenti a tempo pieno (Stern e Nakata, 1991) ha contribuito ad accrescere l’interesse per il fenomeno, rendendo palese la necessità di indagarne le molteplici implicazioni. Simili tendenze sono però rinvenibili in altri contesti nazionali, dove tuttavia il fenomeno non è stato approfondito.
L’aumento degli studenti lavoratori, quindi, può essere considerato condizione necessaria ma non sufficiente alla spiegazione della quasi esclusiva produzione scientifica sull’argomento da parte degli Stati Uniti. A questo proposito possiamo individuare almeno un’altra ragione che legata al sistema di finanziamento delle istituzioni universitarie nel sistema statunitense. Negli Stati Uniti i costi sostenuti dalle famiglie per permettere ai figli di proseguire gli studi dopo la scuola secondaria sono considerevoli, soprattutto se confrontati con altri paesi. Tali costi, oltre che elevati, sono anche crescenti nel tempo. Nel decennio 1990-2000 l’aumento generale dei costi legati ai college pubblici si è aggirato attorno al 22% (Snyder e Hoffman, 2001). L’aumento è stato determinato in buona parte dalla riduzione dei finanziamenti federali, che hanno costretto le università a fronteggiare la scarsità di risorse finanziarie anche attraverso l’aumento delle rette scolastiche. Il risultato è stato l’aggravio del peso dell’istruzione post-secondaria sui bilanci familiari, che al 2000 assorbivano circa il 25% del reddito totale annuale (National Center for Public Policy and Higher Education; 2002). Se i costi dei college sono sicuramente uno dei tasti dolenti del sistema americano, siamo però costretti a riconoscere che la questione dell’accessibilità all’istruzione terziaria non riguarda esclusivamente le spese legate a tasse universitarie e mantenimento. Come osservato da Triventi (2010), per una corretta valutazione dei costi legati all’università non possiamo prescindere dalla quantità e la qualità del sostegno pubblico rivolto sia direttamente agli studenti, che alle famiglie. Da questo punto di vista, gli elevati costi per un’istruzione di qualità negli Stati Uniti sono in parte ammortizzati attraverso un sistema di sostegno pubblico generoso. Il risultato è che il livello di accessibilità complessiva statunitense, calcolato al momento degli studi, non si discosta molto da quello di paesi in cui le tasse universitarie sono molto inferiori, come ad esempio il sistema italiano. Presi singolarmente, dunque, l’aumento dei costi dell’istruzione terziaria statunitense e l’incremento nella percentuale di studenti lavoratori, non riescono a spiegare in modo soddisfacente perché l’attenzione verso il fenomeno non si sia diffusa anche in paesi che presentano condizioni tutto sommato simili. La spiegazione dell’interesse per il tema del lavoro durante gli studi negli Stati Uniti sembra infatti riconducibile all’individuazione di un nesso tra aumento dei costi ed aumento degli studenti lavoratori (Hexter, 1990; O’Brien, 1993). La crescita dell’occupazione degli studenti è stata spesso interpretata come risposta razionale all’aumento dei costi. Gli studenti, nel tentativo di sgravare la famiglia da parte delle spese di mantenimento al college, sarebbero sempre più propensi ad affiancare all’esperienza didattica periodi di occupazione. Aumento dei costi, aumento dell’attività lavorativa degli studenti e soprattutto l’identificazione di un nesso di causalità tra le due tendenze, quando considerati congiuntamente, possono forse spiegare la maggiore propensione ad indagare le possibili conseguenze del lavoro durante gli studi.
Anche in assenza di una precoce espansione complessiva del sistema di istruzione superiore, una dinamica del tutto simile è rinvenibile nel sistema britannico, soprattutto in ragione dei cambiamenti intervenuti a partire dagli anni Ottanta. L’introduzione di tasse universitarie, il congelamento dell’importo delle borse di studio rispetto all’inflazione, la progressiva sostituzione del sistema di aiuti a “fondo perduto” con il sistema dei prestiti e l’incremento degli affitti determinati dall’introduzione del canone equo hanno provocato un notevole aumento dei costi legati all’istruzione superiore (Metcalf, 2003; Ford et al. 1995). Nella pratica ciò si è tradotto in un peggioramento della situazione finanziaria degli studenti, che spesso versano in condizioni di povertà o si trovano costretti a contrarre ulteriori debiti. Basti un solo dato: la National Union Of Student’s Hardship Survey (1999) ha stimato un passivo medio annuale di circa 2mila sterline per ogni studente inglese. Tutto ciò si traduce da una parte nella necessità di ridurre le spese, o attraverso il peggioramento standard di vita oppure decidendo di continuare a vivere con i genitori, dall’altra nella necessità di ricercare ulteriori fonti di finanziamento oltre la classica occupazione estiva (Ford et al. 1995). Anche in questo caso, il sistematico trasferimento dei costi dallo Stato agli studenti è coinciso con l’incremento della porzione di giovani che hanno deciso di affiancare attività remunerative all’esperienza universitaria. Se prima degli anni Ottanta la quota di studenti lavoratori era residuale, tale percentuale sale a circa il 25% nei primi anni Novanta (Ford et al. 1995) per poi stabilizzarsi attorno al 70% verso la fine del decennio (Callender e Kemp, 2000). La presenza di un nesso di causalità tra costi e occupazione nel contesto inglese è forse ancor più evidente, anche perché documentata da una serie di studi interessati al fenomeno dal punto di vista dell’equità. Nel Regno Unito, le indagini sull’effetto dell’esperienza lavorativa sui risultati accademici spesso rivelano un particolare interesse verso il profilo degli studenti lavoratori. Tra i motivi che spingono gli studenti ad intraprendere attività lavorative, emerge con frequenza il ruolo dei costi. Curtis e Williams (2002), in un’indagine che considerava studenti del primo e secondo anno di diversi corsi di Management, rilevavano come la questione finanziaria fosse la principale ragione dell’attività lavorativa degli studenti durante l‘anno accademico. Paton-Saltzberg e Lindsay (1993) riscontrano una sostanziale coincidenza tra gli studenti che lavorano durante l’anno accademico e quelli che pensano che lavorare sia l’unico modo per non accumulare altri debiti. Metcalf (2003) sottolinea la connessione tra la pressione economica e l’occupazione, evidenziando la maggiore propensione a lavorare da parte degli studenti che non ricevono finanziamento dalle famiglie o da studenti provenienti dalle classi meno abbienti (spesso le due condizioni coincidono). Sostanzialmente agli stessi risultati giungeva anche il meno recente lavoro di Ford et al. (1995), che individuava nel basso reddito e nel debito accumulato le principali ragioni dell’occupazione studentesca. In definitiva, anche nel Regno Unito la diffusione delle indagini sul lavoro durante gli studi universitari non sembra prescindere dall’incremento dei costi e dal conseguente aumento della portata del fenomeno (Metcalf, 2003) .
Il quadro ora è leggermente più chiaro. L’attenzione riservata nel contesto anglosassone al fenomeno del lavoro durante gli studi terziari non sembra slegata da presupposto comune: gli studenti universitari lavorano per pagarsi gli studi. Tale premessa emerge chiaramente nella quasi totalità delle ricerche in questione, che si pongono sì obiettivi diversi, condividendo però il medesimo punto di partenza. Questo presupposto riveste una cruciale importanza, perché influisce notevolmente sull’approccio adottato da simili ricerche. Considerare le implicazioni della scelta forzata di lavorare per pagare gli studi, infatti, significa in primis considerare l’effetto che questo può avere sul rendimento accademico, sia in termini di abbandono, sia in termini di voti. L’approccio anglosassone si è infatti caratterizzato per la considerazione del conseguimento del titolo terziario come principale outcome nelle analisi empiriche. Se lavorare è condizione necessaria per poter proseguire gli studi, è naturale chiedersi dapprima quale influenza tale attività possa avere sulle performance accademiche e, in caso di effetto negativo, quali siano le condizioni che determinano sistematicamente lo svantaggio. Tale orientamento si è forse riflettuto nella minore attenzione dedicata all’effetto dell’esperienza lavorativa durante gli studi nel mercato, seppur questo aspetto sia riconosciuto come fondamentale da alcuni autori. Ritorneremo su questo punto più avanti.
L’individuazione di un presunto nesso di causalità tra aumento dei costi universitari e lavoro durante gli studi sembra dunque essere alla base sia della diffusione dell’interesse accademico verso il fenomeno nei paesi anglosassoni che della concentrazione sui risultati scolastici come outcome principale nelle analisi empiriche. Riteniamo però che la tendenza a lavorare per mantenersi il college, pur spiegando la proliferazione delle ricerche nel contesto anglosassone, non giustifichi la scarsa attenzione dedicata al tema in altri ambiti nazionali, soprattutto nel contesto europeo. Anche nel caso in cui la crescita degli studenti lavoratori non sia attribuibile direttamente ad un aumento dei costi, l’analisi delle conseguenze del lavoro durante gli studi è comunque rilevante. In primo luogo, riteniamo la questione importante dal punto di vista dell’equità. Anche dove i costi legati all’istruzione terziaria non sono elevati, è probabile che dinamiche simili agiscano nella porzione di studenti provenienti dalle classi sociali meno abbienti. In secondo luogo, non è detto che siano esclusivamente i costi ad influire sulla decisione di lavorare. In terzo luogo, indipendentemente dalle ragioni per cui si lavora e dalla portata del fenomeno, l’attività lavorativa può avere delle conseguenze sia sulle performance accademiche, sia sulle dinamiche di mercato una volta completati gli studi. Nonostante la generale scarsa attenzione al tema, esistono comunque delle eccezioni. Nel prossimo paragrafo discuteremo brevemente i principali risultati d’analisi in ambito extra europeo e le principali ricerche focalizzate su paesi europei.
1.3. Studio e lavoro: ricerche ed evidenze empiriche
Il paragrafo prenderà in considerazione sia le indagini focalizzate sul ruolo del lavoro durante gli studi nel rendimento accademico, che i suoi effetti nel mercato del lavoro. Discuteremo inizialmente il primo aspetto per poi focalizzarci sul secondo, più direttamente collegato all’argomento specifico di questo testo. Infine, proporremo alcuni spunti circa la necessità di un approccio integrato, segnalando il contributo che il nostro lavoro potrebbe apportare in tal senso. Per ragioni che dovrebbero essere ormai chiare, gran parte delle ricerche si riferirà al contesto anglosassone. Non mancheranno però riferimenti alle poche indagini in altri Stati europei. Nel tentativo di restringere il campo, verranno prese in considerazione esclusivamente i risultati d’indagine inerenti all’istruzione post-secondaria (ci riserviamo comunque la possibilità di introdurre, quando necessario, considerazioni che si riferiscono ai livelli educativi inferiori).
1.3.1. Lavoro e risultati accademici
Anche restringendo il campo alle sole indagini focalizzate sulle performance accademiche a livello universitario, ci scontriamo con un’ampia eterogeneità. Questa variabilità deriva in buona parte dai diversi aspetti del rendimento accademico su cui ci si è concentrati, ma anche dalle diverse caratteristiche delle attività lavorative prese in considerazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, la letteratura sul tema mostra si è principalmente focalizzata verso i risultati accademici in termini di voti da un lato e in termini di abbandono scolastico dall’altro. Vi sono poi una serie di contributi più generali, che intendono valutare l’impatto dell’occupazione sulla vita accademica dal punto di vista soggettivo. In ciascun caso, le caratteristiche delle attività lavorative degli studenti prese in varia da una ricerca all’altra. Ci si è talvolta concentrati semplicemente sull’intensità del lavoro, mentre in altre situazioni si è introdotta una maggiore articolazione in base al periodo (periodo estivo oppure periodo di lezione) e all’ambiente di svolgimento di tali attività (lavori entro oppure al di fuori del campus) (Triventi e Trivellato, 2008). Se la relazione tra lavoro durante gli studi ed abbandoni è abbastanza chiara, quella tra lavoro e rendimento accademico in termini di voti sembra esserlo motlo meno (Pascarella, 1998). Partiamo dai risultati sul primo aspetto, in qualche modo maggiormente corroborati, per poi passare alla discussione del secondo.
Negli Stati Uniti c’è sostanziale accordo nel ritenere che, a certe condizioni, il lavoro svolto durante gli studi possa danneggiare la permanenza dei giovani nel sistema educativo. Tali condizioni riguardano nella maggior parte dei casi l’intensità del lavoro (misurata in ore settimanali) e lo svolgimento entro oppure al di fuori del campus. Astin (1993) rileva come il lavoro esterno al campus influisca negativamente sulla possibilità rimanere al college e di conseguire il titolo finale, indipendentemente dall’intensità di svolgimento. Altri studi però, pongono l’accento sulla non linearità della relazione tra lavoro al di fuori del campus ed abbandoni. Lo stesso Astin (1975), qualche anno prima, aveva riscontrato un effetto negativo più accentuato nel caso il lavoro eccedesse la quota di 35-40 ore settimanali (l’equivalente di un lavoro a tempo pieno). Nella stessa direzione vanno i risultati di Ehrenberg e Sherman (1987), che oltre a rilevare un’influenza negativa del numero di ore lavorate sulle permanenze, sottolineano come un eccessivo impegno nel mercato durante gli studi, anche quando non determini l’abbandono, diminuisca la probabilità di laurearsi nei tempi previsti. Oltre ad incrementare la possibilità di abbandonare gli studi, un lavoro a tempo pieno al di fuori del campus riduce la regolarità dell’esperienza didattica, contribuendo ...