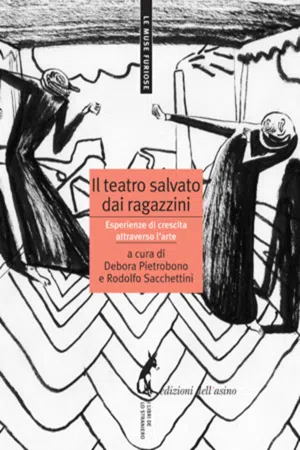![]()
Teatro, infanzia e rivoluzione: Walter Benjamin di Vittorio Giacopini
La fata presso la quale si ha diritto a un desiderio, c’è per ognuno. Solo pochi però riescono a ricordarsi il desiderio che hanno espresso: così, nel corso della loro vita, solo pochi si accorgono che si è realizzato.
Walter Benjamin
L’origine è la meta
Karl Kraus
L’esperienza rivoluzionaria della felicità
“Veramente rivoluzionaria […] non è la propaganda delle idee. Veramente rivoluzionario è il segnale segreto dell’avvenire che parla dal gesto infantile”. Per Walter Benjamin – che era un esperto di nascondigli segreti, ombre e ripostigli – la formula magica si è rintanata in un testo clandestino. Però “nascondere significa lasciar tracce […] invisibili”, ricorrere all’“arte della mano leggera” e far sparire le cose “nell’aria”, a mezza altezza. Se cerchi, trovi: l’aveva lasciato capire senza dirlo. Inutile ostinarsi a frugare dove sarebbe più logico e intuitivo (“non si deve assolutamente nascondere nulla nei cassetti degli armadi, sotto i letti o nel pianoforte”). La teoria politica – come la lettera di Poe o il coniglio di Pasqua dei bambini – è in bella vista e si “offre allo sguardo da ogni lato” ma chi non sa pazientare non la vede. Lui stesso si era rassegnato a scoprirsi – e a lasciarsi scoprire – lentamente. “Finché – aveva scritto a Sholem nel ’24 – non arriverò a testi di significato e totalità interamente diversi costruirò una mia ‘politica’ come il ragno la sua tela”. Ma quando poco prima di uccidersi con le Tesi di filosofia della storia Benjamin scrive il suo lavoro politico più noto quella tela è ancora piena di strappi e smagliature. L’immagine della storia come “catastrofe” sbriciola l’illusione del progresso senza aprire lo spazio della politica. Apparentemente è solo l’ultimo tentativo abortito di una lunga sequenza di approssimazioni imperfette, fallimenti geniali, passi falsi. Aveva provato da sempre a misurarsi con il mistero della politica e i suoi trucchi ma i suoi testi più esplicitamente politici – Per la critica della violenza, Il dramma barocco, le Tesi – sono “nascondigli” scontati, troppo ovvi. Fedele al motto dialettico che impone di risolvere le difficoltà al contrario, moltiplicandole, Benjamin diffida delle luci chiare e uniformi. Anche la politica va esplorata servendosi dei chiaroscuri dell’alba o della “luce che piove dalla luna” e rischiara “una terra rivale o secondaria”.
E proprio in una terra secondaria e rivale, spesso in ombra (e sempre dentro testi criptati, insospettabili) si aggirano i protagonisti della sua teoria politica latente. Nell’orizzonte anche troppo affollato del pensiero politico moderno Benjamin è quasi il solo a vedere nei bambini (e negli angeli: lo vedremo) le figure chiave di una politica radicalmente diversa, capace di rotture assolute, innovativa. È una strana scommessa e un’avventura mentale liberatoria. Senza mai farsi sedurre dal falso realismo o dal cinismo Benjamin chiede a questi intrusi assoluti nelle stanze ammuffite del potere il segnale di una svolta ribelle, la sfrontatezza di un altro tipo di sguardo sulla storia. Aveva aspirato a “una politica ‘giusta’, radicale, che appunto per questo non vuole essere altro che politica” ma non seguiva muse, leader o vati. Senza affidarsi al conforto dell’ideologia, Benjamin nomina il tema della rivoluzione come un’esigenza imperativa. Nei suoi scritti politici “esoterici” il massimo salto in avanti assume la forma sconcertante del più radicale passo indietro. “L’infanzia – aveva scritto – è un varco che ci apre alla speranza. In essa giace, per ogni uomo, l’esperienza rivoluzionaria della felicità”. I Passages e le Tesi riprenderanno questo tema incandescente dopo averlo completamente incurvato al contrario e ribaltato: “possiamo immaginare la felicità solo nell’aria che abbiamo respirato, tra le persone che hanno vissuto con noi. Nell’idea di felicità vibra […] l’idea della redenzione”. È uno stesso campo di tensione che produce scintille a raggiera e non si placa. Felicità, esperienza, infanzia, rivoluzione: nel Programma per un teatro proletario di bambini i cardini di un pensiero politico segreto si compongono nel caleidoscopio di questa formula magica allusiva: “Veramente rivoluzionaria […] non è la propaganda delle idee. Veramente rivoluzionario è il segnale segreto dell’avvenire che parla dal gesto infantile”.
La grazia – sovversiva – dei bambini
Il “buon scrittore” è uno che “non dice più di quanto pensi” e Benjamin sapeva essere essenziale. Quattro laconiche, scarne paginette e aveva detto quel che c’era da dire. Poche chiacchiere. E niente fronzoli, chiose, spiegazioni. In una manciata di paragrafi Il teatro proletario di bambini riassume una pedagogia in miniatura (le miniature erano una sua vecchia passione da una vita) e una filosofia politica al contrario. Già l’attacco è una dichiarazione programmatica. “Ogni movimento proletario che sia sfuggito allo schema della discussione parlamentare si vede davanti… la nuova generazione come la forza più grande ma anche la più pericolosa”. Non gira attorno al problema, non cincischia. Politica e infanzia si incontrano su un terreno minato ma non bisogna attenuare questa collisione imprevista o provare a sventarla, stupidamente. Quando i bambini entrano nel campo di tensione del pensiero politico la critica della politica esistente è già un fatto compiuto da chiarire. Gli adulti (un’intera tradizione di pensiero politico questo non l’ha mai saputo tollerare) non possono e non devono restare da soli. “La sicurezza di sé dell’ottusità parlamentare nasce proprio dal fatto che gli adulti stanno tra loro”. La politica ottusa manca deliberatamente la dimensione irrequieta del futuro per questa limitazione auto-imposta e presuntuosa. Accogliere i bambini sulla strada maestra (come raccomanda Kafka nel racconto) non è un’opzione che si può rinviare all’infinito. Chi aspira a una politica nuova deve sbarazzarsi di quella vecchia. Ogni “c’era una volta” è una menzogna. I tempi storici – e le generazioni – vanno fatti saltare e riassorbiti in una costellazione nuova e incandescente. Per Benjamin niente è più vuoto di un pensiero adulto che si erige a norma assoluta o a paradigma. Senza i bambini – e senza un ritorno all’infanzia consapevole – l’orizzonte della politica e l’esistenza sociale restano dimensioni mutilate. Quando qualche giorno prima di morire Benjamin scrive ad Adorno, insiste ancora su questo tasto e va più a fondo. Politica e infanzia si pensano nello stesso movimento. La nostra vita manca di grazia (e di rivoluzione). Ma “quanto alla grazia voglio limitarmi a parlare dei bambini […] esiste la grazia dei bambini, ed esiste soprattutto come correttivo della società; è una delle indicazioni dateci in direzione della felicità non disciplinata”.
La grazia dei bambini come correzione e critica integrale della vita associata. E la forza liberatoria di una felicità indisciplinabile, ostinatamente stramba, sovversiva. Nel Programma Benjamin pensa questo tema nel luogo tipico delle discipline obbedienti e dei comandi: l’educazione, l’addestramento alla vita, l’istruzione. Per chi vuole pensare senza parapetti il paradosso diventa una forma mentale obbligatoria e la pedagogia di Benjamin è un territorio selvaggio e sorprendente. Il teatro proletario – questo “radicale sprigionarsi del gioco” e della vita – non è arte, esercizio, cultura o intrattenimento ma educazione al contrario, vera esperienza. Il terrore borghese per teatrini e teatranti è sintomatico. “Niente sembra...