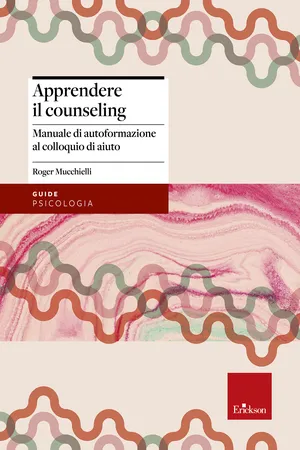
eBook - ePub
Apprendere il counseling
Manuale di autoformazione al colloquio di aiuto
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Quali competenze e abilità deve esercitare un operatore per ricreare, nella situazione di colloquio, dinamiche psicologiche favorevoli all'apertura emozionale, alla fiducia, alla chiarificazione? Come può evitare di introdurre distorsioni, blocchi o regressioni? Il presente volume, testo di riferimento a livello internazionale sul counseling, illustra e presenta in dettaglio queste abilità e consente di esercitarle in modo diretto, tramite una serie di esercizi appositamente predisposti.
Unanimemente considerato il manuale pratico più completo e approfondito per la formazione al colloquio di aiuto, offre un testo ricco di esempi di colloquio aggiornati e sempre attuali e di schede operative per esercizi individuali e di gruppo.
Questa nuova edizione fornisce un testo più chiaro, con esempi di colloquio aggiornati e sempre attuali.
Apprendere il counseling è un'opera destinata in modo particolare agli operatori delle professioni di aiuto (psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori, counselor) e agli studenti in formazione in questi specifici campi disciplinari, ma per la sua chiarezza nell'esposizione e il suo taglio operativo può costituire un valido supporto anche per molti altri professionisti (medici, insegnanti, magistrati, avvocati, sacerdoti, amministratori, operatori assistenziali, ecc.): una migliore abilità di comprensione e di relazione interpersonale può rappresentare un essenziale arricchimento del loro modo di essere e di operare.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Apprendere il counseling di Roger Mucchielli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Didattica e Didattica generale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
DidatticaCategoria
Didattica generale1
Definizione e prospettive del colloquio di aiuto
Confronto fra il colloquio di aiuto e altri generi di colloquio/comunicazione
Il colloquio non è una conversazione
In una conversazione «ci si siede e si chiacchiera». Si scambiano delle opinioni, sugli altri e su molti argomenti. Da una semplice conversazione non esce nulla di definito tranne lo scambio di alcune informazioni possedute dall’uno o dall’altro; non vi è nulla oltre l’incontro in se stesso, che crea o rinforza un senso di familiarità. Può avvenire che tutta la prima fase di un colloquio d’aiuto sia del genere «conversazione», per prendere confidenza e «fare la conoscenza» in modo graduale (il contenuto degli scambi è irrilevante). Ma il colloquio propriamente detto è tutt’altra cosa e non può limitarsi a ciò.
Il colloquio d’aiuto non è una discussione
In una discussione cerchiamo di sostenere degli argomenti, di rispondere a delle obiezioni, di parare degli attacchi o delle confutazioni che vengono dalla parte avversa. I partner sono «faccia a faccia» nel senso del confronto, della rivalità, della gara. La discussione, per ciascuno dei due interlocutori, ha delle fasi di offesa e delle fasi di difesa. Una discussione può essere più o meno appassionata; più frequentemente implica una forma di lotta o di dibattito «giuridico», con momenti di arringa, di accusa, di difesa, di argomentazione, di conclusione. I partner sono affettivamente coinvolti (pro o contro) e ciascuno osserva le reazioni dell’altro. La comprensione dell’interlocutore è «impedita» dalle posizioni personali preconcette. La relazione che si instaura è dominata dall’alternanza dominazione-sottomissione e non è una relazione di comprensione propriamente detta.
Il colloquio d’aiuto non è un’intervista nel senso giornalistico del termine
L’intervista giornalistica (per giornali e riviste, per la radio o per la televisione) è un genere di colloquio «faccia a faccia» in cui uno dei due (il giornalista) cerca effettivamente di far parlare l’altro su se stesso o su un determinato problema (tema dell’intervista). Sembrerebbe che questo tipo di colloquio sia centrato sulla persona dell’intervistato e richieda, da parte del giornalista, un tentativo per comprendere, il più possibile, le opinioni personali del suo «cliente». Evidentemente si tratta di un’illusione poiché in effetti il colloquio non è limitato al faccia a faccia. Un terzo partner, enorme e potente, è sempre presente benché non se ne parli esplicitamente: il pubblico.
L’intervistatore non cerca di comprendere il suo cliente, bensì di interessare il pubblico, vale a dire di accentuare l’aspetto spettacolare. L’intervista giornalistica è uno spettacolo, e il tema posto o proposto è scelto in funzione del pubblico. In ogni modo si cerca di favorire la curiosità del pubblico (già esistente o al contrario da risvegliare e da alimentare). L’intervista, giornalisticamente intesa, ha obiettivi estranei all’aiuto.
Il colloquio d’aiuto non è un interrogatorio
In un interrogatorio di qualunque genere (il bombardamento di domande nel corso di un’inchiesta, un’interrogazione scolastica, un interrogatorio di polizia), colui che viene interrogato è palesemente in situazione d’inferiorità e le domande sono «sondaggi» che esercitano una pressione più o meno ostile. Che si esigano risposte precise a determinate domande o che si verifichi come una persona ha passato il suo tempo per far cadere un alibi, l’interrogato è sempre in una posizione di sospetto, a volte di accusa, di fronte a un censore onnipotente che conduce il gioco in maniera autoritaria. Una simile situazione produce necessariamente nell’intervistato il panico o una reazione difensiva, e lo rende soprattutto ansioso di trovare «la risposta indovinata», quella che gli permetterà di cavarsela.
L’intervistatore si preoccupa delle domande che deve porre e della maniera in cui l’altro vi risponde; non si preoccupa delle domande che l’altro si pone né della maniera in cui se le pone. D’altra parte l’atteggiamento difensivo dell’intervistato non facilita certamente il dialogo.
Il colloquio d’aiuto non è un «discorso» dell’intervistatore
Succede spesso che il colloquio sia, da parte di colui che per definizione deve accogliere e ascoltare l’altro, un’occasione per parlare da solo. «Ha parlato soltanto lui», dirà l’altro uscendo, «non ho potuto dire neanche una parola». Il «discorso» può avere diversi obiettivi coscienti: tentativo più o meno premeditato di far ammettere qualcosa all’altro o fargli cambiare opinione, informazioni da dare a senso unico e così via. Possono esserci anche degli obiettivi inconsci: piacere narcisistico di sentirsi parlare, bisogno di manifestare una volontà di potenza, paura di ciò che l’altro potrebbe dire e così via.
Ciò che è certo è che il discorso-monologo davanti all’altro è esattamente l’opposto di ciò che occorrerebbe fare per comprenderlo.
Il colloquio d’aiuto non è una confessione
L’atteggiamento (e il ruolo) del confessore implica una valutazione morale di ciò che l’altro dice, come una serie di confessioni che lo colpevolizzano. Malgrado egli abbia intenzione di perdonare o di assolvere, il confessore si connota come detentore di una regola morale o religiosa, come «moralmente superiore» o come giudice. L’altro (l’intervistato) è quindi nella situazione di colui che ha infranto o rischia di aver infranto la legge morale.
Può capitare che il colloquio d’aiuto assuma, in certi momenti, le caratteristiche di una confessione; questo però non significa che l’atteggiamento dell’operatore debba essere quello del confessore o del direttore spirituale. Il suo obiettivo non è quello di «liberare dalla colpa» né di giudicare (punire o perdonare), ma di comprendere la situazione dell’altro.
Il colloquio d’aiuto non mira a una diagnosi
Nell’interrogatorio a scopo diagnostico, il medico, lo psicologo o il terapeuta ha in mente un insieme di «quadri clinici», di tipi di disturbo o una classificazione di casi; il suo interrogatorio ha per obiettivo sapere in quale «casella» si colloca il suo cliente. L’intervistatore è contento (potente, riconosciuto e autorassicurato) quando ha ottenuto la sua diagnosi. Lungi dall’aver compreso una singola persona, nell’unicità della sua esistenza, ha fatto rientrare il suo «caso» in un «contenitore predisposto» e si immagina con ciò di averlo compreso. In realtà egli si è fatto sfuggire l’essenziale: il vissuto del cliente.
Specificità della relazione d’aiuto e del counseling
La relazione d’aiuto è emersa nel corso della storia del servizio sociale e la conoscenza delle tappe di questa storia è utile per chiarire la sua natura.
All’origine, si trattava di istituzionalizzare qualcosa che fino a quel momento era di dominio dell’assistenza privata ai disadattati, ai diseredati o ai disabili (di qualunque tipo) e che era quindi una faccenda di carità, una specie di compensazione umanitaria a un sistema sociale rigido, impersonale e perciò profondamente ingiusto. Dopo la carità pura e semplice, di cui il primo grande nome è San Vincenzo de Paoli, l’assistenza privata fu motivata dalla filantropia, e qui bisogna ricordare La Rochefoucald-Liancourt, il noto fondatore e presidente della prima Commissione per l’Assistenza Pubblica alla Convenzione. L’assistenza pubblica si sviluppa così a partire dalla Rivoluzione Francese ed è soltanto nel XX secolo che questa produrrà il servizio sociale come istituzione e come professione. La presa di coscienza progressiva della peculiarità della relazione d’aiuto è recente: essa appare dal confronto delle definizioni ufficiali dell’azione sociale tra gli anni Trenta e Sessanta.
1930. La relazione d’aiuto è, inizialmente, valorizzata in se stessa. Essa esige simpatia, solidarietà e cooperazione.
La relazione d’aiuto è una forma di intercomunicazione in cui si crea un ponte tra chi assiste e chi è assistito, che fa sì che queste due personalità diventino un noi, ciò che produce una sensazione di solidarietà affettiva […] L’operatore sociale deve offrire un tipo di relazione priva di ogni pregiudizio e di ogni ansia. Su questa base si costruirà l’azione cooperativa per risolvere il problema.
1935. La relazione pone degli obiettivi che vanno al di là di se stessa.
L’elemento essenziale è la relazione dinamica tra l’operatore sociale e il cliente. L’interrelazione deve rappresentare, per il cliente, un’assistenza che egli riceve per una sua promozione personale […]
La relazione stessa, così come viene creata da chi assiste, rappresenta la costruzione di un nuovo ambiente per il cliente, grazie al quale egli cerca, nel modo più efficace, di valutare il proprio problema.
1950. L’aspetto psicopedagogico passa in primo piano, man mano che il metodo assume contorni più precisi.
Il colloquio è il mezzo attraverso il quale il cliente viene messo in grado di porsi il proprio problema e attraverso il quale l’operatore sociale lo porta a vederlo più chiaramente.
1960. La relazione d’aiuto arriva alla sua definizione completa.
La relazione d’aiuto è una relazione professionale nella quale una persona deve essere assistita per operare un adattamento personale a una situazione verso cui la persona non è riuscita a adattarsi normalmente. Ciò suppone che chi aiuta debba essere in grado di compiere due azioni specifiche:
1. Comprendere il problema nei termini in cui si pone per quel particolare individuo in quella particolare esistenza.
2. Aiutare il «cliente» a evolvere personalmente nel senso di un suo miglior adattamento sociale.
1. Comprendere il problema nei termini in cui si pone per quel particolare individuo in quella particolare esistenza.
2. Aiutare il «cliente» a evolvere personalmente nel senso di un suo miglior adattamento sociale.
Si può constatare perciò il progressivo passaggio dal «sentimentalismo» a una tecnica di educazione sociale e di riabilitazione psicologica attraverso la quale il cliente impara a prendersi autonomamente in carico.
La relazione d’aiuto è specifica e differisce dagli altri tipi di interrelazione umana. L’operatore che ha la responsabilità di condurre il colloquio «faccia a faccia» nella relazione d’aiuto deve essere pienamente consapevole del duplice obiettivo di questa forma di relazione, come è stato definito più sopra (ovvero comprendere l’altro e aiutarlo a prendersi in carico). La tecnica del colloquio deve essere conseguente. Deve essere non direttivo e centrato sul cliente.
Il colloquio «non direttivo» o «centrato sul cliente»
Carl Rogers
Le due espressioni «colloquio non direttivo» e «colloquio centrato sul cliente» sono state utilizzate da Carl Rogers, nato nel 1902 negli Stati Uniti. Dopo i suoi studi, a partire dal 1928 Rogers si impegnò nel lavoro di ricerca e, allo stesso tempo, fece esperienze pratiche nell’ambito del colloquio clinico. Lavorò dapprima a Rochester, nel Dipartimento di studi sull’infanzia della Society for the Prevention of Cruelty to Children e nel 1939 divenne direttore del Rochester Guidance Center. Successivamente passò all’Ohio State University, all’Università di Chicago e del Wisconsin. Dal 1962-1963 egli fu a Stanford (California) dove ricoprì a lungo l’incarico di direttore dell’Istituto di Ricerche sulle Relazioni Interpersonali e di docente al Centro di Ricerche sul Comportamento. Nel suo primo grande lavoro (Counseling and psychotherapy, 1942) egli attacca implicitamente le teorie a priori sulla personalità e, tra queste, la psicoanalisi. Rogers, in effetti, pensa che nessuno occupi una posizione migliore del soggetto stesso per sapere quali sono i suoi problemi, e che quello che importa è sapere come questi ha «integrato» la propria esperienza. Egli preconizza un abbandono di tutti i preconcetti e il ritorno ingenuo al reale umano.
Nel 1950, con il volume Client-centered therapy (la «Terapia centrata sul cliente»), egli precisa il metodo del colloquio non direttivo centrato sul cliente.
La non direttività è diventata un concetto di moda e sfortunatamente spesso fraintesa come «non-interventismo», completo laissez faire. Per evitare questo controsenso, Rogers preferisce parlare non di colloquio «non direttivo» ma di colloquio «centrato sul cliente» o «centrato sulla persona».
Il termine «cliente» è stato adottato deliberatamente da Rogers (invece di «soggetto», «paziente», «malato», «allievo»), al pari del nome di «counselor» (invece di «terapeuta», «professore», «educatore», «assistente»), per denotare l’originalità di una relazione nella quale l’assistito sceglie di farsi aiutare ma non abbandona né la sua libertà, né la sua responsabilità nella soluzione delle sue difficoltà.
Più recentemente, nel saggio pubblicato nel volume di Frick Humanistic psychology (1971), Rogers dichiara di aderire al movimento della psicologia umanistica, alla base del quale vi sono la valorizzazione e il rispetto della persona umana nella sua libertà, responsabilità, storicità.
Definizione del «colloquio di comprensione» o «colloquio centrato sul cliente»
L’approccio di «centrarsi sul cliente» per comprendere il problema come è vissuto dalla persona presuppone, logicamente, determinati principi, che possono essere formulati nel modo seguente:
- Un atteggiamento di interesse «aperto», ossia una disponibilità integrale, senza alcun pregiudizio o preconcetto di qualunque tipo, un modo di essere e di fare che sia un incoraggiamento continuo all’espressione spontanea dell’altro.
- Un atteggiamento non giudicante che permette di ricevere e di accettare tutto senza critiche, né colpevolizzazioni, né consigli.
- Un atteggiamento di non direttività, basato sul presupposto che non vi sia nulla di «nascosto» da cercare o da verificare e che il cliente abbia la completa iniziativa nella presentazione del problema e nell’«itinerario» del colloquio.
- Un’intenzione autentica di comprendere l’altro nella sua propria lingua, di pensare con le sue parole, di scoprire il suo universo soggettivo. Ossia cogliere i significati che la situazione ha per il cliente.
- Uno sforzo costante per rimanere obiettivo e per controllare tutto ciò che avviene nel corso del colloquio.
Questo richiede qualche cosa d’altro oltre la semplice buona volontà. Richiede una formazione e un metodo. In un certo senso, il problema del metodo è comune a tutte le scienze umane. La loro «oggettività» non è quella delle scienze naturali. Lo sforzo di essere oggettivi non è importante in nessun’altra cosa più che nella comprensione di una persona; questo sforzo esige, allo stesso tempo, da parte di chi assiste, una «fredda» intelligenza e l’immersione nell...
Indice dei contenuti
- L’autore
- Presentazione all’edizione italiana
- Introduzione
- 1. Definizione e prospettive del colloquio di aiuto
- 2. Saper ascoltare e saper osservare
- 3. Atteggiamenti corretti e scorretti nella conduzione del colloquio
- 4. La riformulazione: tecnica base del counseling
- 5. Altre applicazioni (oltre la relazione di aiuto) del colloquio di comprensione
- Conclusioni generali
- Esercizi pratici
- Appendici