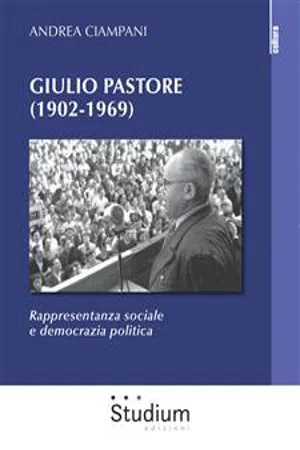Durante il 1958 parvero disegnarsi nuovi scenari per un’Italia profondamente mutata nel primo decennio d’esperienza repubblicana. Per quanto riguardava le dinamiche politiche, dopo il risultato ottenuto dalla Democrazia cristiana alle elezioni di maggio (oltre la soglia del 42% dei voti), il segretario politico della DC, Amintore Fanfani, ottenne la formazione di un governo che lo vide assumere anche la presidenza del Consiglio dei ministri, coinvolgendo il leader socialdemocratico Giuseppe Saragat come vicepresidente. Fanfani si presentò con una forte impronta di riformismo politico nel campo socio-economico e con un visibile protagonismo in politica estera. Egli propose un percorso che avrebbe dovuto condurre alla formulazione di alleanze di centro-sinistra, incalzando il partito socialista a compiere il cammino di allontanamento dai comunisti iniziato dopo l’invasione sovietica dell’Ungheria del 1956. Proprio la forza di questo attivismo politico, nel quadro delle attese per un aumento del reddito e della produzione nella crescita complessiva del Paese, suscitò insieme all’interesse sperato anche convergenti opposizioni; i partiti della destra tentarono di condizionare dall’esterno la DC sul piano delle formule governative, così come i comunisti ricercarono possibili strategie per impedire che il proprio isolamento politico si aggravasse. Del resto, mentre nuove tensioni si svilupparono con parte della Conferenza episcopale italiana sul significato delle aperture di Fanfani verso i socialisti, all’interno della DC crebbero assieme il timore di una eccessiva concentrazione di responsabilità politiche nelle mani del leader aretino e la preoccupazione del mantenimento in equilibrio del sistema politico attorno al perno democristiano [1] .
Fu in questo complesso scenario che nell’estate 1958 Pastore ritenne possibile offrire il suo personale impegno a sostegno di un quadro di stabilità governativa, ottenuto col concorso dei partiti democratici, per l’attuazione di quella «coraggiosa politica di sviluppo economico e sociale» che il Comitato esecutivo della CISL aveva auspicato ancora nel giugno 1958. Di fronte alle difficoltà che da un paio d’anni impedivano di compiere un salto di qualità al riconoscimento degli attori sociali nella politica della classe dirigente dei partiti democratici – come dimostrava anche la resistenza ad avviare le politiche di concertazione tripartite proposte dalla CISL – il leader sindacale considerò un’opportunità, così difficile quanto praticabile, l’occasione offerta dalla congiuntura politica di esercitare in prima persona un ruolo di governo.
Interessato a coinvolgere ampi ceti sociali in un disegno riformistico di maturazione politica [2] , Fanfani non poteva ignorare la proposta di Pastore, cui riconosceva capacità organizzative (fin dall’inizio della sua esperienza democristiana a Roma accanto a Dossetti nel 1945 [3] ), moderna declinazione degli ideali cattolici sul piano economico-sociale (grazie al gruppo di studiosi guidati da Romani), radicata leadership dentro e fuori l’elettorato democristiano (attraverso l’attrazione che la sua figura esercitava tra i lavoratori e i sindacalisti nelle realtà locali). La corrente democristiana di Forze sociali, del resto, all’inizio della terza legislatura repubblicana aveva ottenuto l’elezione di una trentina di parlamentari DC, come esito di un impegno riformista apertamente voluto dalla CISL [4] . Tutti questi fattori, rafforzati da uno sperimentato rapporto personale, condussero il segretario della DC a resistere a coloro che, nella fase di consultazione per la formazione del Gabinetto, chiedevano fosse attribuito a un meridionale l’innovativa responsabilità ministeriale per il Mezzogiorno e le aree depresse dell’Italia [5] ; in realtà, «l’impegno per il Mezzogiorno era solo l’esempio più rilevante di un approccio politico complessivo, tipico dell’approccio di Fanfani e della classe dirigente di cui egli era espressione» [6] .
In tale prospettiva, se Fanfani non poteva rinunciare a Pastore, questi non avrebbe potuto sottrarsi al nuovo compito coraggiosamente assunto. Pastore, infatti, ritenne di poter allora confidare sull’affermata leadership carismatica del presidente del Consiglio per congiungere nell’azione di governo impegno programmatico e centralità sociale dei partiti [7] . Se Fanfani appariva interessato ad ampliare la partecipazione politica, per Pastore si trattava di sviluppare la partecipazione «come espressione di una libertà che toccava tutte le esperienze della vita personale e sociale e che poteva essere portatrice di innovazioni istituzionali e strutturali al cui centro era posta la piena dignità di vita e di lavoro per tutti gli uomini» [8] . La tribuna e il campo di responsabilità ottenuti nel ministero – la responsabilità per il coordinamento dell’intervento straordinario dello Stato nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro e del Nord dell’Italia – potevano costituire l’occasione per alimentare un ripensamento culturale in tale direzione e sperimentare un paradigmatico metodo di governo ad esso coerente. Il profilo politico di Pastore, del resto, era ormai ben riconoscibile: mantenersi sempre nel solco di una solidale presenza pubblica dei cattolici nella società italiana senza mai inclinare al confessionalismo; sostenere il riformismo sociale senza mai rinunciare all’avversione per la politica comunista come ideologia totalitaria; rivendicare la partecipazione delle forze sociali nel partito a sostegno di una democrazia partecipata senza mai accedere al disinvolto professionismo politico presente nella sinistra DC. Contemporaneamente, Pastore lasciò la leadership della CISL, allora assunta da Bruno Storti, in continuità col disegno di crescita sociale che lo aveva spinto a fondare il «sindacato nuovo» rivendicando l’autonomia sindacale dai partiti e dai governi.
Consapevole della difficile situazione politica in cui si sarebbe trovato ad operare, Pastore ancora una volta chiamò intorno a sé noti studiosi e giovani brillanti per assisterlo in diversi campi, da Mario Romani a Vittorio Bachelet, da Giovanni Marongiu a Giuseppe De Rita, da Vincenzo Scotti a Sergio Zoppi. Sollecitò anche la nascita di una rivista politico-culturale, «Il Nuovo Osservatore», con l’intento di alimentare la formazione di una cultura politica che, ragionando sulle principali dinamiche socio-politiche del tempo, elaborasse proposte d’intervento, costituisse terreno di formazione di una giovane classe dirigente, promuovesse il dialogo tra diversi indirizzi politici [9] . Alla fine del novembre 1958 cessava nella DC l’esperienza della corrente di Forze sociali per lasciar spazio a un più ampio raggruppamento di Rinnovamento democratico, in cui accanto all’autorevole presenza di Pastore come ministro della Repubblica era crescente il ruolo rivendicato nel partito da Donat-Cattin, Storti e Livio Labor. Nell’approssimarsi del successivo congresso democristiano, peraltro, si manifestò appieno la forza degli ostacoli che avrebbe dovuto affrontare la progettualità di Pastore, modificando gli scenari politici in cui era maturato il suo impegno nel governo. Per comprendere l’evoluzione e le difficoltà del suo sforzo per il riconoscimento della crescente soggettività sociale in uno Stato democratico, dunque, èopportuno soffermarsi sulle dinamiche politiche che tra il 1959 e il 1960 lo videro attivamente partecipe.
La fronda interna che stava maturando contro Fanfani nella corrente DC di Iniziativa democratica si rifletteva sull’indebolimento del governo e del suo indirizzo politico; così già nel dicembre 1958 Pastore, contrario alle dimissioni del Gabinetto, giunse a suggerire al presidente del Consiglio di lasciare piuttosto la segreteria del partito [10] . Emerge fin da subito, dunque, il determinato prevalere dell’impegno governativo di Pastore rispetto alla lotta di corrente nel partito. Secondo una cultura maturata nella sua formazione politica, all’opera di governo Pastore attribuiva il possibile esercizio di un ruolo politico d’indirizzo che fosse immediatamente operativo sul piano delle trasformazioni sociali: le alleanze e gli equilibri di partito dovevano essere comunque finalizzati all’opera di sviluppo da compiere, nell’interesse delle classi lavoratrici, per l’edificazione di una società democratica. Alla caduta del secondo governo Fanfani, seguito dalle dimissioni da segretario della DC, dunque, Pastore nel marzo 1959 risolse di mantenere la propria responsabilità nel successivo governo Segni, monocolore democristiano che avrebbe dovuto mantenere un profilo riformatore pur ricercando sostegno da “linee convergenti” alla sinistra e alla destra del partito [11] . Contemporaneamente, Pastore lavorò per far respingere le dimissioni di Fanfani dal vertice del partito; inutilmente, tuttavia, la corrente Rinnovamento democratico sostenne un voto in tal senso nel Consiglio nazionale DC di marzo di fronte alla manovra della nuova corrente dorotea che aveva individuato in Aldo Moro il nuovo segretario democristiano [12] . Pastore si ritrovò così all’opposizione politica nel suo partito, accanto ai fanfaniani – presto riuniti nella corrente Nuove Cronache –, così come agli esponenti della sinistra democristiana della Base ed agli uomini, come Tambroni, vicini al presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.
Nel governo e nella Democrazia cristiana Pastore restò fedele all’impegno assunto pochi mesi prima in ben altro contesto. Insofferente della politica centrista di Segni [13] , continuò a ricercare un ritorno al governo di Fanfani, incoraggiandolo a distinguersi dalla sinistra della Base [14] . Sollevando una polemica sull’importanza del radicamento popolare e sul rispetto dell’indirizzo degli iscritti al partito, infine, la corrente di Rinnovamento democratico seguì Pastore a fianco di Fanfani nei congressi provinciali di preparazione al Congresso nazionale della DC che si tenne nell’ottobre 1959 a Firenze, in cui la candidatura del leader aretino si sarebbe contrapposta a quella del leader pugliese. Le due progettualità politiche, diversamente modulate sulla forza programmatica del partito e sulla verifica della effettiva disponibilità ideologica dei socialisti a possibili accordi, non dovevano apparire così distanti, se alla vigilia dell’assise congressuale Moro poteva ritenere possibile la presentazione di una sola mozione, pur restando distanti le valutazioni sulla reazione della destra italiana [15] . Il confronto congressuale restò in bilico fino all’ultimo, quando grazie all’accordo trovato con Giulio Andreotti – e al metodo elettorale maggioritario voluto nel 1956 che consentiva di votare esponenti di altre liste – Moro ottenne un Consiglio nazionale a lui favorevole [16] . In effetti, il risultato del Congresso, che pose a capo del partito di maggioranza una leadership fragile, non mutò le priorità di Pastore, deciso a puntare le sue carte sulla qualificazione democratica e sociale della sua presenza al governo, intensificando la sua pressione sulla presidenza del Consiglio, il cui indirizzo apparve sempre più distante dall’azione rifo...