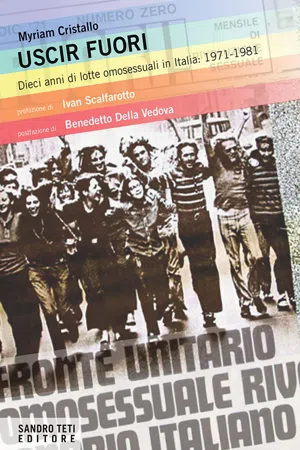![]()
IX. La perversione eterosessuale
Articoli anti-gay
Dopo la morte di Pasolini, dopo la Lettera pastorale voluta da Paolo VI, e in attesa delle elezioni di giugno, il quotidiano torinese La Stampa esegue un’operazione-sondaggio simile a quella già eseguita dal Corriere a proposito dell’aborto, per verificare l’opinione pubblica nei confronti di quegli omosessuali che si sono ormai ufficialmente schierati a livello nazionale col PR. Allo scopo vengono oculatamente scelti, non già i soliti “esperti”, alla Romero, ma due opinionisti di stretta osservanza cattolica: Carlo Arturo Jemolo e Carlo Casalegno. A Jemolo l’onore e l’onere di cominciare. E lui furbescamente parte da un concetto che ha già elaborato e che gli sembra perfetto: l’amore. Sono tutti gli amori uguali? Per il momento il tema omosessuale non compare, ma Jemolo si ricorda piuttosto di un capitolo della Teresa Desqueiroux di Mauriac, precisamente quello in cui la donna, già convinta di tentato uxoricidio, pur essendo ormai anziana attende ancora l’amore umano, e se lo aspetta da un giovane che in realtà la voleva solo convertire. Questi, per non deluderla troppo, l’avverte che «l’amore è uno solo», e per provarglielo diventa non suo amante ma suo genero. Bello scherzo. Sono questi i doni d’amore che piacciono a Jemolo, il quale come si vedrà meglio in seguito, in questo campo è un contorto. Non siamo ancora agli amori diversi, che si tiene da parte per poi descriverli al peggio, ma per costruire un suo vezzoso “crescendo” intanto chiarisce cosa pensa degli amori convenzionali, ai quali è già capacissimo di trovar pecche e peli nell’uovo. E si vede subito che ne ha anzitutto un’idea quantitativa: «Penso all’amore come un credente alla Grazia, un bene inesauribile, si dà e si riceve senza computi». Ma tutti gli amori umani hanno qualcosa di imperfetto: si comincia con quelli eterosessuali, che per lui esistono solo fra coniugi, e vengono divisi in due sottotipi: quelli che arricchiscono e quelli che impoveriscono. È una fissazione! Il vedovo/a per esempio si trova arricchito, spiritualmente s’intende, dopo la morte del coniuge. Ma vi sono anche altri amori, che impoveriscono, e sono quelli di certi figli “piissimi” che non si sposano per dedicarsi solo alla madre (e il padre?), e che quando lei muore si trovano «svuotati, incapaci di affetti, di interessamenti» (stava per scrivere di “interessenze”). Analogamente prosegue dequalificando ben altri amori con lo stile di uno che sceglie l’investimento migliore per i suoi capitali: amore verso Dio e i santi? No: spesso si soffre di periodi di aridità... Amore verso i figli? Spesso sono irriconoscenti (pochi quelli piissimi). Amore per la politica? Troppe disillusioni. Dove vorrà mai andare a parare, questo Jemolo, nel suo vano sforzo per sembrare laico? Facciamo un passo indietro. Il pregevole pezzo è uscito il 18/12/75, a poco più di un mese dalla scomparsa di Pasolini. In quell’occasione appunto – dice il nostro – aveva letto la frase che l’amore gay «è un amore come tutti gli altri», e ci aveva riflettuto sopra. Che cosa gli era venuto in mente? Le mamme. Sì, le due mamme, quella di Pasolini e quella del Pelosi. Per i due figli degeneri, che fanno piangere la mamma, l’articolista prova “un’infinita pietà”; e invece, almeno per Pasolini, si vede bene che prova un’infinita invidia. Ma ormai siamo sulla strada giusta per gli amori “diversi”. Il nostro riflette con la sua infinita pietà: chissà perché questo Pasolini, lui grande artista, amava il brutto! Aveva il triste dono (sic!) di scorgere sempre il lato brutto in ogni aspetto della vita. «Bruttezza di vecchi,... volti idioti di braccianti». (Neanche un giornalista!). E perché poi, nel Vangelo secondo Matteo non aveva saputo trovare attori più belli, per i ruoli di Gesù e della Vergine? (L’infelice non si è nemmeno accorto che non si tratta di tipi europei, ma di semiti). E perché poi va a scegliere, come angelo, un tale con un grosso neo? Ma è facile, ma è evidente! Perché era infelice. D’altra parte, come s’è già detto, per Jemolo tutti gli amori hanno qualche pecca, e dunque come alleggerire l’amore di questi suoi naturali difetti? Ricordando da vecchi persone amate in gioventù. Dev’essere di così stretta osservanza il buon Jemolo da aver paura dell’amore, di ogni amore, perché comunque vada, lì qualcosa «sa sempre di sesso». Così l’incontro fra Marcel e Gilberte ormai anziani (tratta il romanzo di Proust come fosse realtà); così il giudizio (che definisce «splendido») di Gide sulle donne del proprio passato: «L’incontro dopo molti anni con le donne che si amarono è come un incontro con delle morte». Alla buonora! Ora sì che ci possiamo rallegrare! E meno male, perché: «Che Gilberta adolescente e l’Albertina di Proust non siano fanciulle è facile scorgere». Ah, sì? E da che cosa? Gilberte poi, nella reale vita di Proust, era davvero una ragazza. Di Mauriac s’è già detto. Di Gide parla da pettegolone impenitente, ricordando «i viaggetti con bei ragazzi di famiglie amiche» (delira o ci crede tutti ignoranti come lui? Gide i ragazzi se li cercava e trovava in Tunisia, sul posto...), viaggetti «di cui l’angelica moglie non ignorava la natura» (e con ciò?). Vuoi far credere di sapere tutto al punto che – sbagliando grossolanamente – afferma senza vergogna che Sartre avrebbe intitolato un suo saggio Saint Genet perché credeva che Genet si fosse convertito! Ma ora viene il più e il meglio.
Tutti questi peccatori, tutti questi omosessuali, anche se solo descritti nella letteratura, gli fanno l’effetto di un «potente emetico», per «lo schifo che mi desta la materialità della cosa». Perfino leggendone nei libri (dove peraltro non ci sono mai descrizioni così dettagliate). Nella vita invece Jemolo è stato molto più ragionevole. Lo dice lui stesso: in certi casi è d’obbligo «porre da parte» la fede cristiana. Infatti, «se mi dicessero di provvedere»: provvedere, come chi in un lager ricevesse l’ordine di seppellire i morti. Dunque, di «provvedere per i diversi, facendone comunità di lavoro» [facendo di essi comunità...] «in isole o borghi montani» (in pianura no) «ormai disabitati, con possibilità di nuovi adepti adulti, ma assoluto divieto di attrarvi dei giovanissimi, meno che mai degli affamati, disposti a tutto per mille lire», (com’è che sa così bene il prezzo di una marchetta?) «nulla avrei da obbiettare».
Gliel’hanno poi chiesto, di farsi carico, di proseguire, di eseguire? Pare proprio di no. E meno male che l’aveva detto prima, di avere lasciato da parte la fede cristiana, nel concepire questa nazi-ghettizzazione coatta, perché il suo non sembra davvero il comandamento che sull’amore ci ha lasciato il Cristo.
A proposito del Casalegno giornalista, che doveva poi morire per mano delle Brigate Rosse, mi sono chiesta in quegli anni come mai La Stampa non temesse di essere dequalificata da certi articoli che solo lui riusciva a scrivere. A chi dunque affidare una degna risposta alla valanga di lettere di protesta che si era ben meritato Jemolo, con le sue “comunità montane”? A Casalegno il quale, lusingato dell’incarico, rispondeva da par suo, rivelando che i lettori avevano reagito – udite, udite! – qualificando Jemolo di «razzista, ignorante, nazista, provocatore». Ma vaà? Si era giudicata «un gesto di terrorismo anti-omosessuale» quella che era stata una semplice proposta. Chissà come mai i lettori sbagliano così grossolanamente! Davvero s’erano comportati male: avevano avuto «una reazione rabbiosa», perché, come tutte le minoranze [però avevano scritto anche moltissimi eterosessuali] «essi sono ipersensibili», prendono i gesti ostili come gesti di persecuzione! Uno gli dice: “mi fai venire il vomito” e loro subito si offendono. Ipersensibili! Lui, Casalegno, invece no. E nemmeno Jemolo. Gli hanno scritto che «è sceso sotto i limiti della comune decenza», e loro due non se la sono per niente presa: hanno solo dato la colpa ai lettori. Ecco come reagisce la persona civile. Ma passiamo al maggior punto dolente. Il povero Jemolo, lui che con cuore cristiano ha scritto di «aver pietà» per i diversi, non è nemmeno stato ringraziato! «La pietà appare ai diversi più intollerabile dell’ingiuria!». È evidente che ci si trova di fronte a un mondo ribaltato, rispetto all’ordine costituito e al buon senso comune. Qui non si è grati verso chi “ha pietà”, qui si agisce come Pasolini quando metteva angeli con vistosi nei a far parte dei suoi film senza nemmeno accorgersene. Qui si è perso il ben dell’intelletto. Si è accusato Jemolo di voler scatenare una caccia alle streghe! Ma Jemolo ha solo detto che «non sarebbe stato contrario» alle comunità montane di lavoro. Insomma ha parlato di monti per non parlare di campi [campi di lavoro,... campi di sterminio...]. Ora si capisce perché tanto amore per i rilievi alpini! Temeva che la sua proposta suonasse male. Ma Jemolo aveva anche detto che questa era una concessione che lui faceva, «nonostante la sua istintiva ripugnanza». Perché a dare ascolto ai suoi sentimenti cristiani li avrebbe mandati tutti al rogo. Solo Casalegno poteva avere l’impudenza di fingere di aver dimenticato l’intero periodo: «E, se mi dicessero di provvedere, nulla avrei in contrario...»: non era una pura opinione, che anche da sola sarebbe stata da Codice Penale. Chi avrebbe dovuto dirgli di provvedere? Il Parlamento, Pertini, Fanfani? O da qualche tempo anche un semplice cittadino può farsi delle leggi sue? O può bastare che qualcuno gli dica “provvedi”, e lui provvede? Non contento, Casalegno continuava: «È una prova assurda di intolleranza». Quella di Jemolo che voleva i lager come male minore? No, no, quella dei lettori inviperiti. Che diamine. Ognuno può avere una sua opinione. Jemolo, e pure lui, Casalegno, hanno diritto ad avere, sulle cose omosessuali, delle tavole di valori tutte loro. Questa gentaglia (i gay) scambiano la pornografia per rivoluzione. Ci si creda o no, siamo arrivati a un Casalegno difensore e teorico delle rivoluzioni (e noi, che pensavamo da tempo di avere toccato il limite...). «La rivoluzione – scrive il nostro – è una cosa seria, che esige un forte impegno morale e il rispetto di molti vincoli».
Lesbiche nel FUORI!
Il FUORI! ha sempre, coscienziosamente e puntigliosamente, dedicato in ogni suo numero uno o più articoli ai problemi del lesbismo, potendo contare su un nutrito gruppo di donne che avevano le idee chiare e scrivevano molto bene. Intellettuali che poi, nel corso degli anni, lasciarono il posto ad altre, ugualmente dotate e più giovani. Nei primi anni la più feconda, creativa e combattiva di loro è stata Emma Allais che sotto lo pseudonimo di Stefania Sala ha praticamente creato il pensiero rivoluzionario della donna omosessuale moderna, individuandone il nemico principale nell’oppressione della famiglia.
La figlia omosessuale prima ancora di essere sbeffeggiata in società da uomini e donne, lo è dai genitori e dai fratelli che vedono in lei un elemento capace di macchiare il loro onore e diminuire il credito della famiglia stessa nel sociale. Il vero dramma delle lesbiche, attraverso gli anni delle lotte di liberazione sessuale, s’è visto che era dovuto all’isolamento, di cui hanno continuato a soffrire, non tanto a causa del “nemico di classe”, cioè il maschio “fallocrate”, quanto a causa delle altre donne, le tradizionaliste e le femministe. Assurdamente si è dovuto capire, nel tempo, che in società tutto le danneggia e le ferisce, non soltanto chi le perseguita apertamente ma perfino chi le vorrebbe aiutare e lo fa male. L’omosessualità femminile non ha mai subito le persecuzioni, il carcere e le condanne a morte degli omosessuali maschi. Perfino le più oppressive fra le legislazioni la trascurano, non la vedono neppure. E questo ha una sua strana logica: se il massimo valore sociale è l’aggressività maschile, la lesbica, che è vista come una donna mascolina, non può ragionevolmente essere discriminata, solo perché imita il padrone. Nei suoi confronti inoltre si è sempre esercitata una curiosità vuaieristica da parte degli uomini, per i quali non esiste spettacolo più eccitante che guardare due donne assieme su un letto. Perciò nessuna legge ha mai perseguitato veramente le lesbiche, la cui repressione in compenso è strettissima nel privato.
Su questo punto occorre ricordare che, se la famiglia alleva le figlie a spose e madri plasmandole in tal senso fin da neonate, essa esercita la medesima educazione anche su quella che poi si rivelerà inadatta al matrimonio. Il figlio maschio è allevato a marito e padre con le lusinghe – lui padrone, lui virile, lui eroe –, la figlia femmina è allevata alla dolcezza e sottomissione ai “fatti della vita” (il marito) che conoscerà direttamente col tempo. Il figlio può uscire la sera, gli si dà la chiave di casa (oggetto simbolico del vero significato di questa moderna toga pretesta), la figlia femmina deve rientrare massimo alle sette e mezza precise del pomeriggio. Deve essere a casa per cena. Chissà perché le famiglie sono convinte che certe cose si facciano solo col favor della notte. Così la ragazza impara prestissimo che uscire di casa è relativamente facile, purché lo si faccia con delle amiche. Se esistono le lesbiche, va detto che nel loro caso, in esse, davvero la natura parla da sola e in presa diretta, poiché parla in un deserto. Il figlio maschio ha di certo sentito, entro le mura domestiche, esaltare la condizione virile: l’ha potuta prendere come modello del meglio che esista sulla terra, può innamorarsene. La figlia femmina è tacciata, per la stessa ragione, di “invidia del pene”, poiché nessuna famiglia le innalzerà mai al cielo le donne. Col tempo ho potuto scoprire – come oggi si sta scoprendo quanto sia diffuso nelle famiglie l’incesto e la violenza carnale (anche di tipo omosessuale) – che molte malmaritate, non volendo perdere i privilegi dello status di moglie, stringevano amicizie particolari con altre mogli insoddisfatte. Senza rischiare nulla. Anzi. Quale più degna amicizia di quella che unisce due casalinghe, due madri, che hanno tanti problemi in comune!? Sono di certo brave donne, che non corrono dietro a possibili amanti! Ma facciano attenzione i lettori a non credere che per questo il lesbismo sia una sessualità di ripiego, frutto di segregazioni e imposizioni casalinghe. Esiste, sì, un’omosessualità dovuta a stato di necessità, come quella che si crea nelle carceri, nelle caserme o nei manicomi, ma questi fenomeni provano soltanto che nel genere umano è sempre latente la bisessualità e che, laddove l’eterosessualità diventa difficile o è addirittura proibita, l’omosessualità che ne segue proviene direttamente dalla natura. Tuttavia la maggiore difficoltà per le donne che hanno comunque tendenze lesbiche consiste piuttosto nella ricerca di una partner. Nella maggior parte dei casi tutte le possibili compagne non sanno nemmeno di essere mono-sessuali, dal momento che per la donna la famiglia prevede per quanto è possibile una totale ignoranza del sesso prima del matrimonio. Tutti i genitori hanno un’idea chiarissima di quanto e fino a qual punto una fidanzata sia una merce, e che le merci si ama acquistarle nuove, mai usate. Ne consegue che in moltissimi casi la donna scopre la sua omosessualità solo dopo il matrimonio, a volte anche dopo aver avuto un paio di figli. Casi particolarmente difficili, che spesso abbiamo avuto sott’occhio: s’impone il problema del divorzio, del trovarsi un lavoro, il problema di non sapere se i figli le saranno affidati. Non di rado ciò capita a un uomo che ha sposato una donna allevata in collegio, che gli è stata consegnata brevi manu dai genitori come vergine garantita, ma che aveva già avuto esperienze omosessuali, e continuavano a piacerle più dei frettolosi amplessi maritali. In questi casi le donne devono avere il coraggio di affrontare la vita da sole, lavorando per mantenere se stesse e i figli, quando e se vorranno lasciarglieli.
Questo e altro scrivevano le collaboratrici del FUORI! nei loro articoli, ma gruppi femministi di auto-coscienza omosessuale e rivoluzionaria non ne abbiamo mai visti riunirsi. Le nostre collaboratrici erano delle intellettuali che scrivevano da sole, firmando con pseudonimi e gestivano la loro condizione come sempre, rivelandosi a poche amiche, a poche lesbiche. Nonostante tutte queste difficoltà (il motto più frequente nel loro campo fu sempre “lesbiche uniamoci!”, come in USA si potevano leggere nelle manifestazioni pubbliche numerosi cartelli di “lesbians unite!”, proprio perché mancava alla loro liberazione questo indispensabile fondamento), da molte parti veniva ormai sollecitato un Convegno di sole donne omosessuali. Che non poté essere tenuto prima del 1976. La redazione di FUORI! lo organizzò in gran fretta, da venerdì 19 marzo a domenica 21, e gli assegnò come tema: “La lesbica nella società maschile eterosessuale”. Il giovedì pomeriggio si era tenuta una conferenza stampa con gran concorso di giornalisti in cui io stessa avevo detto poche parole di presentazione del convegno, bevute dai giornalisti presenti e dai loro magnetofonini professionali come oro colato, dal momento che erano le prime mai dette in pubblico sull’argomento. Vi furono in seguito polemiche: perché un congresso di lesbiche si faceva introdurre da una eterosessuale? Nessuno voleva capire che alle lesbiche la società aveva fino a quel momento tolto anche il coraggio di pensarsi e di vedersi nel loro vero essere e nei loro problemi. «Ha parlato la Cristallo per noi – disse una di loro – perché noi non ne siamo capaci, nessuno ci ha mai “dato la parola”, questa è l’amara verità». Oggi chiunque voglia capire qualcosa di questo congresso attraverso le fonti storiche, cioè i tre articoli di giornale che uscirono, su Panorama, Stampa Sera e La Repubblica, se ne farebbe un’idea totalmente sbagliata.
Al Congresso eravamo state accettate, di “normali” (di nemiche), solo io e l’inviata di Panorama. La prima riunione si svolse in una grigia mattinata del peggior marzo torinese, nella sede del FUORI! di Via Garibaldi 13, che era un ex magazzino di mobili. Uno stanzone spoglio. Non sembrava nemmeno un Congresso. Nessuno aveva preparato nulla, nemmeno le nostre collaboratrici intellettuali, che brillavano per la loro assenza e per il terrore di essere riconosciute come lesbiche “nella loro città”. Non c’era un tavolo di presidenza con un tappeto sopra, non un poster, non dei volantini. Nello stanzone si vedevano, di inconsueto, solo molte sedie impagliate. Le congressiste arrivarono, verso le nove, sole o a gruppetti. Altro che lo stereotipo della lesbica, quello fabbricato dai disegnatori uomini! Una fanciulla dalle forme armoniose e acerbe, magari vestita da uomo, ma longilinea e raffinata. Quelle che erano lì convenute erano le lesbiche vere. Casalinghe, studentesse, borgatare romane che a forza di mangiar pastasciutta erano ormai prive di forme femminili. Tutte si sedettero e tacevano, il silenzio era totale ed era l’unica prova della gravità della situazione. Chiesi se volevano eleggere una presidentessa che dirigesse i lavori. Altro silenzio. Nel giro di un quarto d’ora si chiarì che nessuna di loro aveva la benché minima idea di cosa volesse dire “lotta di liberazione”, congresso o maschio fallocrate, o mercificazione e altri ben noti discorsi pregiatamente veri. Le convenute sapevano soltanto che si sarebbe parlato della loro condizione e dei loro problemi. Ma forse avevano creduto che ci sarebbe stato qualcuno pronto a illuminarle. Io cercai di velare la dura realtà, e cioè che nulla era stato organizzato in questo senso, dicendo che si era creduto bene di lasciare alle congressiste “totale libertà”. Si formarono gruppetti che parlavano sottovoce, e alla fine una di loro prese la parola per dire che – dal momento che loro non sapevano “fare i bei discorsi” – preferivano andare avanti lasciando che ognuna raccontasse il suo vissuto. Ok, questa era davvero l’unica cosa utile da farsi. La giornalista di Panorama spiccava nella grigia sala umida e fredda con la sua capigliatura bionda, appena uscita dalle mani di un qualche Vergottini, con un suo favoloso abito-maglione di un blu indimenticabile, e si teneva stretta a un professionale block-notes, su cui non scrisse mai nulla, piuttosto che scriverci un articolo “impubblicabile”. Di vissuti se ne ricostruirono non pochi, quella mattina. Quasi tutte storie da ...