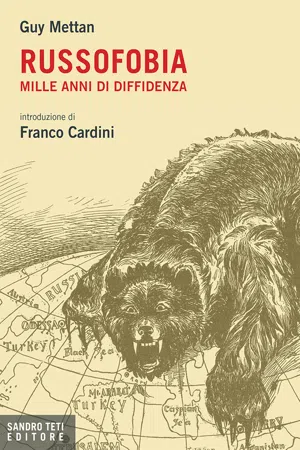![]()
PICCOLA GENEALOGIA DELLA RUSSOFOBIA
![]()
Una guerra di religione che si protrae dai tempi di Carlo Magno
In Europa siamo visti come asiatici, parassiti e schiavi mentre se andiamo in Asia saremo visti come maestri, europei. Chi sono questi russi? Degli asiatici, dei tatari? Ciò che questa unione degli slavi, secondo gli europei, preannuncia, è la conquista, la rapina, l’astuzia, la perfidia, la futura distruzione della civiltà, l’orda mongola unita, i tatari!
Fëdor Dostoevskij, Diario di uno scrittore, 1881.
Per quanto paradossale possa apparire, la russofobia è incominciata ancor prima che la Russia facesse il suo ingresso nella storia. Per comprendere l’abisso di pregiudizi che separa l’Occidente moderno dal mondo russo, si deve in effetti risalire al Grande scisma e anche più indietro, due secoli prima, all’epoca in cui Carlo Magno si fece incoronare imperatore e contese all’Impero bizantino la successione dell’Impero romano, modificando nel frattempo la liturgia cristiana con riforme invise alle Chiese d’Oriente.
Innumerevoli ragioni, religiose, politiche, economiche, culturali portarono al divorzio le due grandi realtà della cristianità medievale. Ci limiteremo a mettere in luce quelle che hanno maggiormente contribuito alla nascita dell’odio che si è poco alla volta stabilito tra l’Occidente da una parte, e l’Impero bizantino e la Chiesa greca d’Oriente dall’altra, e che coinvolse la Russia in seguito, quando quest’ultima decise di reclamare come propria l’eredità religiosa e politica bizantina dopo la caduta di Costantinopoli.
Già all’epoca, furono le rivalità politiche, al pari delle divergenze religiose, a esacerbare le controversie che venivano poco a poco allo scoperto tra Oriente e Occidente, fino a farle scoppiare in uno scisma che tuttora non si è ricomposto. Questa frattura, che da ormai 12 secoli contrappone le due componenti della cristianità, ha condizionato tutta la storia del continente e influenza ancora oggi le percezioni falsate degli uni come degli altri, anche se i motivi religiosi della querelle hanno perso la loro pertinenza e la loro virulenza nel corso dei secoli. Se nel 988, a Cherson1 – siamo già in Crimea! – il principe Vladimir avesse deciso di convertirsi al cattolicesimo romano invece che all’ortodossia, l’intera storia europea sarebbe di conseguenza cambiata perché nessuno, né a Ovest né a Est, avrebbe mai messo in dubbio l’appartenenza della Russia all’Europa. Corteggiato allo stesso tempo da Roma – che aveva appena convertito polacchi e ungheresi – e da Bisanzio, il primo sovrano storico della Russia non ebbe tuttavia alcuna esitazione nello scegliere l’ortodossia.
Bisanzio Ville Lumière, batte Roma in rovina
Per i primi sovrani del regno russo che si era formato attorno a Kiev, Bisanzio costituiva in effetti di gran lunga il miglior partito, e la scelta del rito greco fu estremamente sensata, tanto più che l’imperatore bizantino aveva offerto la propria sorella in matrimonio a Vladimir in cambio del suo appoggio militare. Bisanzio era più affine dal punto di vista culturale, più seducente a causa del suo prestigio ancora molto grande all’epoca, più promettente sul piano commerciale a causa degli sbocchi sul Mar Nero e sul Mar Mediterraneo forniti dal porto di Costantinopoli attraverso gli stretti, e con il suo milione di abitanti batteva nettamente la lontanissima Roma con le sue poche decine di migliaia di residenti ammassati tra le rovine.
La Ville Lumière, la capitale della civiltà nel IX secolo, era Bisanzio e non Roma. La millenaria presenza greca in Crimea e nel Sud dell’attuale Ucraina, unita alla costante predicazione di missionari bizantini, finirono per far pendere la bilancia in favore dell’ortodossia e del basileus bizantino. Inoltre Bisanzio era anche apportatrice di una scrittura, il cirillico, di una lingua liturgica, lo slavonico, e di nuove forme d’arte, come la pittura su icona, che si sarebbero rivelate straordinariamente utili per la giovane nazione russa.
Prima dello scisma, la scelta dell’una o dell’altra tradizione non poneva problemi d’ordine religioso. La scelta di Vladimir parve per giunta così naturale da venire ampiamente apprezzata dal re di Francia qualche decennio dopo. Alla fine degli anni Quaranta del IX secolo infatti, il re capetingio Enrico I si ritrova vedovo e senza erede. Nel cercare una nuova regina, volge allora lo sguardo al prestigioso regno di Kiev, dove la nipote di Vladimir, figlia del re Jaroslav il Saggio, la principessa Anna, non è ancora sposata. Il re dei franchi invia il suo vescovo più importante, Ruggero II di Châlons, a chiedere la mano di Anna.
Anna, appartenente per confessione alla Chiesa dei sette concili, sposa a Reims in prime nozze, il 19 maggio 1051, il re Enrico I di Francia, appartenente alla Chiesa romana cattolica; le due Chiese facevano ancora parte della Chiesa indivisa, poiché il matrimonio ebbe luogo prima dello scisma del 1054. In occasione del matrimonio a Reims si organizzarono grandi festeggiamenti. Dopo la morte di Enrico I, Anna regnerà fino al 1061, assicurando la reggenza. Introduce il prenome Filippo alla corte di Francia battezzando con questo nome il suo primogenito, che salirà al trono con il nome di Filippo I. Rimasta vedova, Anna sposa in seconde nozze il conte di Valois, Raoul de Crépy, uno dei più importanti principi del regno. Morì alla fine degli anni Settanta. Colta, raffinata, Anna trova la corte dei franchi «barbara», «rozza»2. Il suo secondo matrimonio è considerato come una delle prime manifestazioni di “amor cortese”. La storia di Anna di Kiev è fortemente rivelatrice dell’assenza di pregiudizi e di giudizi di valore in Europa prima che lo scisma lasciasse il segno sulla stragrande maggioranza dei racconti di viaggio degli europei che si recarono in Russia successivamente. Questa storia mostra che prima del 1054 i sovrani europei non avevano opinioni negative sulla Russia e che anzi, al contrario, ne avevano un’immagine così positiva da essere pronti a far percorrere ai propri vescovi 2.000 chilometri di strade dissestate per andare a procurar loro una sposa. Essa mostra inoltre che all’epoca la civiltà fioriva a Est, e non a Ovest, come la storiografia successiva cercherà di far credere; e rimarca che i racconti negativi scritti dei viaggiatori europei sono cominciati dopo lo scisma e sono il portato dei pregiudizi religiosi. Sono una conseguenza della propaganda cattolica anti ortodossa che fece seguito alla consumazione dello scisma. Di questo avremo modo di occuparci più avanti.
Ma torniamo allo scisma. Ieri come oggi, è difficile stabilire la parte di responsabilità che ricade sulla religione e quella che spetta alla politica per quanto riguarda l’origine del conflitto. Fu il risultato di semplici divergenze religiose? O ci furono delle ambizioni politiche e delle rivalità imperiali che approfittarono delle differenze religiose per affermarsi più agevolmente?
La religione come soft power dell’VIII secolo
Vale dunque la pena tornare sul percorso religioso e politico che portò allo scisma con tutto ciò che ne conseguì per la storia dell’Occidente della Russia. Viste dal XXI secolo, le ragioni dello scisma possono sembrare futili e vacue. Decenni di razionalismo, scetticismo e agnosticismo, nonché la separazione della Chiesa dallo Stato con l’accettazione della laicità nella gestione della cosa pubblica e dell’educazione hanno reso del tutto obsolete le controversie sulla concezione della Trinità e sugli azzimi della comunione.
Tuttavia, se si ammette che la religione giocava un ruolo di prim’ordine nel soft power medievale, si comprenderanno meglio le dimensioni del conflitto che contrappose le Chiese cristiane d’Oriente a quelle di Occidente, e l’Impero bizantino al Sacro romano impero.
Il problema di sapere se si dovesse aggiungere o meno la menzione del Filioque nel Credo cristiano dell’VIII secolo oggi fa sorridere, ma aveva al tempo la stessa importanza per il dominio del mondo mediterraneo ed europeo che la rituale invocazione dei diritti dell’uomo e delle elezioni democratiche nel discorso dell’Unione europea e della Nato nei confronti della Russia del presidente Putin. Non è perciò inutile ricordare quali furono le divergenze teologiche e liturgiche – ideologiche, si direbbe oggi – scatenanti, e il modo in cui la brama di potere di Carlo Magno e poi degli imperatori del Sacro romano impero, l’avidità dei commercianti veneziani – lo spirito di intraprendenza, secondo la formula moderna – e il desiderio dei papi di imporre il loro potere assoluto sulla Chiesa condussero allo scisma della Chiesa d’Oriente e alla rovina definitiva della potenza politica che a essa era connessa, vale a dire l’Impero bizantino. Bisogna dunque ricordare che, dopo la caduta di Roma nel 476, il testimone dell’Impero romano fu raccolto da Bisanzio, che divenne la capitale unica del nuovo Impero romano d’Oriente e reclamò come propria l’eredità culturale, giuridica e, per buona parte, religiosa di Roma. Mentre l’ex capitale imperiale e le province europee scivolavano nel caos e nell’anarchia, mentre Roma stessa perdeva i nove decimi dei propri abitanti e cadeva in rovina, Costantinopoli continuava a guadagnare prestigio. Essa divenne in breve tempo la città più popolosa e più prospera del mondo civile (Cina esclusa), la capitale della cultura e delle arti e il centro religioso più importante della cristianità. Roma, Antiochia e Alessandria furono declassate al secondo posto malgrado la presenza del papa nella prima, e di patriarchi di diritto uguale o superiore a quello della Chiesa bizantina nelle altre due.
Era a Bisanzio, non a Roma, che accadeva tutto
La conquista araba e l’avanzata dell’islam a partire dal VII secolo privarono l’Impero bizantino dei suoi territori egiziani e nordafricani e lo indebolirono in maniera considerevole, ma senza realmente compromettere la sua supremazia culturale e politica. Sarà necessario attendere le crociate e la conquista della città da parte dei latini nel 1204 perché un colpo fatale venga inferto al suo prestigio. A dispetto delle minacce incessanti di invasione, Bisanzio tenne in vita per altri mille anni l’Impero romano e rimase incontestabilmente per almeno sette secoli la Ville Lumière del bacino mediterraneo, racchiudendo all’interno delle sue mura il cuore pulsante della vita intellettuale del tempo.
Tra gli anni 500 e 1200, era a Bisanzio che accadeva tutto, i dibattiti intellettuali che vi si svolgevano erano più vivaci che in qualsiasi altro posto, era lì che i dotti e i teologi svolgevano la loro attività, era lì che fiorivano le arti. Al confronto, Roma, Aix-la-Chapelle, Parigi, Londra facevano una magra figura o non erano ancora che villaggi di capanne dalle strade fangose. Sul pi...