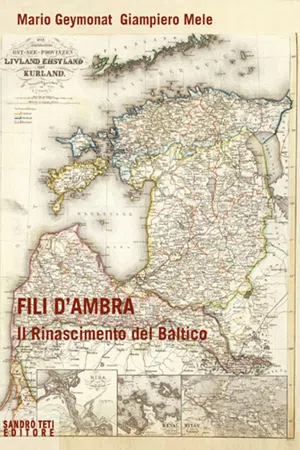
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Fili d'ambra. Il Rinascimento del Baltico
Informazioni su questo libro
Esiste un filo che lega Tacito, Casanova, Marguerite Yourcenar e Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Passa per le vicende dei cavalieri teutonici, scorre tra le righe di epistole vaticane e tocca la tragedia dell'Olocausto. È un filo d'ambra, la preziosa resina fossile proveniente dalle coste del Baltico. Ripercorrendo idealmente la "via dell'ambra", che un tempo univa il golfo di Finlandia alla capitale dell'Impero romano, questa appassionante antologia rivela i sorprendenti legami storici e culturali dell'Italia con Estonia, Lettonia e Lituania, attraverso i brani di celebri scrittori, storici, religiosi e uomini di Stato.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Fili d'ambra. Il Rinascimento del Baltico di AA.VV.,AA.VV., Mario Geymonat,Giampiero Mele in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia dei paesi baltici. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia dei paesi balticiSTORIA DEI PAESI BALTICI *
di Ralph Tuchtenhagen
«Un libro grosso è un grosso male» ebbe a scrivere Lessing. Ma una “storia dei paesi baltici” che ne volesse esporre in maniera pienamente comprensibile e adeguata le complesse vicende territoriali ed etniche dovrebbe abbracciare un considerevole numero di ponderosi volumi. A ben vedere, poi, non si tratterebbe nemmeno di una storia sola, ma di più d’una, giacché nella prospettiva dello storico i “paesi baltici” non costituiscono una struttura unitaria, né per quanto riguarda il passato, né oggigiorno, non in chiave politica e neppure in quella economica, ben poco dal punto di vista culturale e per nulla affatto nella coscienza delle popolazioni locali. Pur prescindendo da ciò, un’esposizione comune della storia dei “paesi baltici” risulta problematica anche in altra prospettiva. Il fatto che oggigiorno l’Estonia, la Lettonia e la Lituania siano sempre nominate tutte insieme deriva essenzialmente dal loro comune destino quali stati indipendenti, dal tentativo (fallito) di collaborare fra loro negli anni tra le due guerre mondiali e, infine, dall’essere state riunite in compagini amministrative e militari più vaste, dapprima sotto il dominio tedesco, poi sotto quello sovietico.
Scavando più in profondità lungo le direttrici del tempo e dello spazio, ci si imbatterà tutt’al più nella constatazione che tra l’Estonia e la Lettonia i confini territoriali, etnici e sociali si sovrapposero in vario modo fino alla Prima guerra mondiale, laddove la Lituania ha invece alle spalle una storia affatto peculiare, ben più intrecciata con quella della Polonia, della Russia Bianca e dell’Ucraina, che non con quella dell’Estonia e della Lettonia. La storia dei singoli paesi baltici, inoltre, si frammenta in ragione delle vicende di regioni e territori particolari, giacché, soprattutto prima della Grande guerra, essi costituivano piuttosto conglomerati territoriali, anziché vere e proprie unità politiche, economiche, sociali o culturali. Qui lo Stato nazionale moderno, largamente unificato, si è affermato tardi, costituendo sulla scala temporale documentabile, dal XIII al XX secolo, a malapena il dieci per cento dell’intera storia dei paesi baltici.
Lo scollamento tra la “Storia” e “le storie” rappresenta però soltanto una delle questioni aperte. Almeno altrettanto problematica è infatti l’attribuzione dell’aggettivo “baltico” alle vicende dei tre paesi. Il termine costituisce certo una denominazione politico-geografica consueta, ma rinvia a significati fra loro diversi e, in parte, persino contraddittori. Infatti, se l’aggettivo “baltico” può essere impiegato per designare la classe dirigente tedesca (i “balti”) nelle province sul Mar Baltico dell’impero russo, cioè l’Estonia, la Livonia e la Curlandia, dal punto di vista della classificazione linguistica esso indica una particolare famiglia linguistica cui appartengono – per menzionarne alcune – anche il lituano, il lettone, il curoniano e il prussiano antico, che proprio in quanto lingue della popolazione non tedesca rivestono grande importanza per la storia dei paesi baltici. Nel contempo però, l’estone – che non è lingua baltica, ma fa parte della famiglia ugro-finnica – resta escluso da questa nozione, benché fosse parlato assieme al lettone in Livonia e poi nella provincia di Estonia, appartenuta dapprima alla Svezia e, in seguito, all’impero russo. Il termine baltico può inoltre designare, in senso generico, tutto ciò che attiene al Mar Baltico (lat. Mare Balticum; ingl. Baltic Sea; franc. Mer Baltique; russo Baltijskoe more); in questo caso, però, non è chiaro perché soltanto l’Estonia, la Lettonia e la Lituania siano riunite sotto questo concetto, e non anche la Prussia, la Pomerania, il Mecklemburgo, lo Schleswig, lo Holstein, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia, la Russia, ecc.
Si potrebbe infine supporre che l’aggettivo baltico si riferisca a determinati popoli, gruppi etnici o etnie. Ciò sarebbe corretto, però, soltanto qualora la lingua o il territorio fossero riconosciuti come criteri validi per la definizione di un “popolo”: i “popoli baltici” sarebbero allora quelli che parlano una lingua baltica o che vivono nel territorio baltico. In tal caso, però, se il criterio linguistico si presenta – come si è visto testé – solo apparentemente univoco, in relazione al concetto territoriale anche tedeschi, ebrei, polacchi, casciubi, russi, danesi, svedesi, finnici, setukesi ecc. dovrebbero essere considerati “popoli baltici” tanto quanto i lettoni, i lituani, i curoni (curi) o i prussi. Tuttavia il tentativo di attribuirsi, attraverso il concetto territoriale “baltico”, un’identità comune subnazionale e nel contempo transnazionale è stato intrapreso in un primo tempo solo dai tedeschi in Estonia, Livonia e Curlandia, mentre i lituani e i lettoni non sono andati oltre un’identificazione nazionale basata sulla lingua, e solo oggi cominciano a familiarizzarsi con il concetto collettivo di “popoli baltici”.
Quale definizione si prospetta dunque per il concetto di “paesi baltici”? A questa domanda occorre rispondere in maniera specifica per ogni singolo periodo storico. Per l’epoca che va dall’espansione tedesca e danese, a cavallo tra il XII e il XIII secolo, fino alla dissoluzione della confederazione di Livonia attorno alla metà del XVI secolo, il territorio compreso attualmente dalla repubblica estone e lettone è indicato per convenzione storiografica con il nome di (antica) Livonia. Dalla metà del Cinquecento sino alla Rivoluzione d’ottobre del 1917 esistettero – dapprima sotto la sovranità svedese e polacco-lituana, poi sotto quella russa – le province di Livonia, Estonia e Curlandia, comprendenti gran parte dei territori della dissolta confederazione. La Lituania sorse a propria volta nel XIII secolo, assumendo dapprima la forma di un principato indipendente; unita più volte al regno di Polonia tra il XIV e il XVIII secolo, tra il Settecento e l’Ottocento passò sotto la sovranità russa per ottenere infine, conclusasi la Prima guerra mondiale, l’indipendenza nazionale contemporaneamente ai territori dell’antica confederazione di Livonia.
Tanto basti per la periodizzazione di una “storia dei paesi baltici”, che già nella sua grossolanità rende manifesta la fragilità della pretesa di uno sguardo storiografico d’insieme. D’altra parte non è facile, per lo storiografo, ignorare le nozioni storico-geografiche divenute popolari, sicché, se nelle pagine seguenti si tenterà comunque di illustrare in maniera unitaria la storia dei paesi baltici, occorrerà partire dai concetti già consolidati per poi articolarli in una visione differenziata della storia dei singoli paesi.
*Prefazione a Storia dei paesi baltici, di Ralph Tuchtenhagen, Il mulino, Bologna 2008, pp. 7-10
OMERO NEL BALTICO*
di Felice Vinci
Sin dai tempi antichi la geografia omerica ha dato adito a problemi e perplessità: la coincidenza tra le città, le regioni, le isole descritte, spesso con dovizia di dettagli, nell’Iliade e nell’Odissea e i luoghi reali del mondo mediterraneo, con cui una tradizione millenaria le ha sempre identificate, è spesso parziale, approssimativa e problematica, quando non dà luogo a evidenti contraddizioni: ne troviamo vari esempi in Strabone, il quale tra l’altro si domanda perché mai l’isola di Fårö, ubicata proprio davanti al porto di Alessandria, da Omero venga invece inspiegabilmente collocata a una giornata di navigazione dall’Egitto. Così l’ubicazione di Itaca, data dall’Odissea in termini molto puntuali – secondo Omero è la più occidentale di un arcipelago che comprende tre isole maggiori: Dulichio, Same e Zacinto – non trova alcuna corrispondenza nella realtà geografica dell’omonima isola nel MarIonio, ubicata a nord di Zacinto, ad est di Cefalonia e a sud di Leucade. E che dire del Peloponneso, descritto come una pianura in entrambi i poemi?
Una possibile chiave per penetrare finalmente in questa singolare realtà geografica ce la fornisce Plutarco, il quale in una sua opera, il De facie quae in orbe lunae apparet, fa un’affermazione sorprendente: l’isola Ogigia, dove la dea Calipso trattenne a lungo Ulisse prima di consentirgli il ritorno a Itaca, è situata nell’Atlantico del nord, «a cinque giorni di navigazione dalla Britannia». Partendo da tale indicazione e seguendo la rotta verso est, indicata nel V libro dell’Odissea, percorsa da Ulisse dopo la sua partenza dall’isola (identificabile con una delle Fær Øer, tra le quali si riscontra un nome curiosamente “grecheggiante”: Mykines), si riesce subito a localizzare la terra dei Feaci, la Scheria, sulla costa meridionale della Norvegia, in un’area in cui abbondano i reperti dell’età del bronzo (e anche graffiti rupestri raffiguranti navi: in effetti Omero chiama i Feaci «famosi navigatori», ma di essi non è stata mai trovata nessuna traccia nel Mediterraneo). Qui, al momento dell’approdo di Ulisse, si verifica un fatto apparentemente incomprensibile: il fiume (dove il giorno successivo il nostro eroe incontrerà Nausicaa) a un certo punto inverte il senso della corrente e accoglie il naufrago all’interno della sua foce. Tale fenomeno, rarissimo nel Mediterraneo, è invece comune nel mondo atlantico, dove l’alta marea produce la periodica inversione del flusso negli estuari. Riguardo poi al nome stesso della Scheria, osserviamo che nell’antica lingua nordica “skerja” significava “scoglio”.
Da qui, con un viaggio relativamente breve il nostro eroe fu poi accompagnato a Itaca, situata, secondo Omero, all’estremità occidentale di un arcipelago su cui il poeta ci fornisce molti particolari, estremamente coerenti fra loro ma totalmente incongruenti con le isole ionie: ora, una serie di precisi riscontri consente di individuare nel Baltico meridionale un gruppo di isole danesi, l’arcipelago del sud Fionia, che vi corrisponde in ogni dettaglio. Le principali infatti sono proprio tre: Langeland (l’“Isola Lunga”: ecco svelato l’enigma della misteriosa Dulichio), Ærø (la Same omerica, anch’essa collocata esattamente secondo le indicazioni dell’Odissea) e Tåsinge (l’antica Zacinto). L’ultima isola dell’arcipelago verso occidente, «là, verso la notte», ora chiamata Lyø, è proprio l’Itaca di Ulisse: essa coincide in modo stupefacente con le indicazioni del poeta, non solo per la posizione, ma anche per le caratteristiche topografiche e morfologiche (invece l’Itaca greca non ha nulla a che vedere con le indicazioni dell’Odissea). E nel gruppo si ritrova persino l’isoletta, «nello stretto fra Itaca e Same», dove i pretendenti si appostarono per tendere l’agguato a Telemaco.
Inoltre, a oriente di Itaca e davanti a Dulichio giaceva una delle regioni del Peloponneso, che a questo punto si identifica facilmente con la grande isola danese di Sjælland (dove adesso sorge Copenhagen): ecco la vera “Isola di Pelope”, nell’autentico significato del termine. Il Peloponneso greco invece, situato in posizione corrispondente nell’Egeo, malgrado la sua denominazione non è un’isola: questa contraddizione, inspiegabile se non si ammette una trasposizione di nomi, è molto significativa. Ma c’è di più: sia i particolari, riportati dall’Odissea, del rapido viaggio in cocchio di Telemaco da Pilo a Lacedemone lungo una «pianura ferace di grano», sia gli sviluppi della guerricciola tra Pili ed Epei raccontata da Nestore nell’XI libro dell’Iliade, da sempre considerati incongruenti con la tormentata orografia della Grecia, si inseriscono perfettamente nella realtà della pianeggiante isola danese.
Va notato che in tutto il mondo non esiste un gruppo di isole che corrisponda alle indicazioni omeriche altrettanto bene quanto queste isole della Danimarca (e men che meno nel Mediterraneo).
Cerchiamo ora la regione di Troia. L’Iliade la situa lungo l’Ellesponto, sistematicamente descritto come un mare «largo» o addirittura «sconfinato»; è pertanto da escludere che possa trattarsi dello stretto dei Dardanelli, davanti a cui si trova la collina di Hissarlik con la città trovata nell’Ottocento da Schliemann, la cui identificazione con la Troia omerica continua a suscitare fortissime perplessità (pensiamo alla critica che ne ha fatto Moses Finley nel suo Il mondo di Odisseo). Inoltre, una serie di indagini geologiche recentemente condotte nella pianura ai piedi della collina ha mostrato che nel II millennio a.C. essa era ricoperta da un vasto braccio di mare, del tutto inconciliabile con le descrizioni omeriche.
Ora, lo storico medievale danese Saxo Grammaticus nelle sue Gesta Danorum menziona in più occasioni un singolare popolo di “Ellespontini”, nemici dei Danesi, e un “Ellesponto” curiosamente situato nell’area del Baltico orientale: che si tratti dell’Ellesponto omerico? Esso potrebbe identificarsi con il golfo di Finlandia, il corrispondente geografico dei Dardanelli; poiché d’altra parte Troia, secondo l’Iliade, era ubicata a nord-est del mare (altro punto a sfavore del sito di Schliemann), per la nostra ricerca è ragionevole orientarci verso un’area della Finlandia meridionale, là dove il golfo di Finlandia sbocca nel Baltico. E proprio qui, in una zona circoscritta a occidente di Helsinki, s’incontrano numerosissime località i cui nomi ricordano in modo impressionante quelli dell’Iliade, ed in particolare gli alleati dei Troiani: Askainen (Ascanio), Reso (Reso), Karjaa (Carii), Nästi (Naste, capo dei Carii), Lyökki (Lici), Tenala (Tenedo), Kiila (Cilla), Kiikoinen (Ciconi) e tanti altri. Vi è anche una Padva, che richiama la nostra Padova, la quale secondo la tradizione venne fondata dal troiano Antenore (i Veneti, chiamati “Enetoi” nell’Iliade ed enumerati fra gli alleati dei Troiani, nella Germania di Tacito sono menzionati accanto ai Finni); inoltre, nella stessa area della Finlandia meridionale, i toponimi Tanttala e Sipilä – sul monte Sipilo fu sepolto il mitico Tantalo, famoso per il celebre supplizio nonché re della Lidia, una regione confinante con la Troade – indicano che il discorso non è circoscritto alla sola geografia omerica, ma sembra estendersi all’intero mondo della mitologia greca.
E Troia? Proprio al centro della zona così individuata, in una località, a mezza strada fra Helsinki e Turku, le cui caratteristiche corrispondono esattamente a quelle tramandateci da Omero – l’area collinosa che domina la vallata con i due fiumi, la pianura che scende verso la costa, le alture alle spalle – scopriamo che la città di Priamo è sopravvissuta al saccheggio e all’incendio da parte degli Achei e ha conservato il proprio nome quasi invariato sino ai nostri giorni: Toija, così si chiama attualmente, è ora un pacifico villaggio finlandese, rimasto per millenni ignaro del proprio glorioso e tragico passato. Varie visite in loco, a partire dall’11 luglio 1992, hanno confermato le straordinarie corrispondenze delle descrizioni dell’Iliade con il territorio attorno a Toija, dove per di più si riscontrano molti tumuli preistorici e altre notevoli tracce dell’età del bronzo. È poi stupefacente che, in direzione del mare, il nome della località di Aijala ricordi tuttora la «spiaggia» (“aigialòs”) dove gli Achei avevano tratto in secca le loro navi (Il. XIV, 34). Non solo: nell’area collinare, a circa 1 km a est di Toija, che sin dall’inizio è apparsa come il sito più probabile della Troia omerica, si trova un toponimo, Kavasto, che in lingua finnica non ha senso, mentre nel greco di Omero significa “la città incendiata”.
Le corrispondenze geografiche si estendono anche alle aree adiacenti: sulla costa svedese antistante, 70 km a nord di Stoccolma, si affaccia la baia di Norrtälje, lunga e relativamente stretta, le cui caratteristiche rimandano alla Aulide omerica, da dove mosse la flotta achea diretta a Troia; attualmente dalla sua estremità partono i traghetti per la Finlandia, ricalcando la stessa rotta: essi transitano davanti all’isola Lemland, il cui nome ricorda l’antica Lemno, dove gli Achei fecero tappa e abbandonarono l’eroe Filottete; a ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Introduzione
- 1.Storia dei paesi baltici
- 2.Omero nel Baltico
- 3.Germania
- 4.La Crociata sul ghiaccio
- 5.I cavalieri teutonici
- 6.Storia della mia vita
- 7.Marguerite Yourcenar e il Baltico
- 8.Il colpo di grazia
- 9.L'Olocausto nascosto
- 10.La lista di Carbone
- 11.La cometa rossa
- 12.L'ambra del Baltico
- Indice dei nomi e dei luoghi
- Altre pubblicazioni