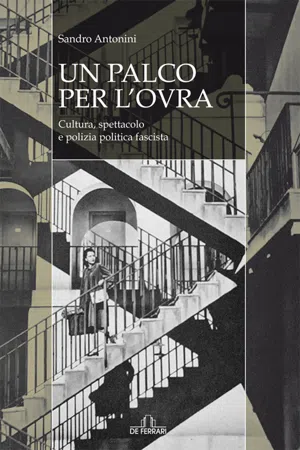![]()
4. Certezze e sospetti: i casi politici di Altiero Spinelli e Mario Soldati
La sostanziale differenza tra un oppositore politico nel senso più autentico del termine e uno soltanto presunto forma l’oggetto del presente capitolo, ma è riconducibile a molte delle pagine di questo libro, dove ai continui sospetti non corrispose quasi mai nulla degno di nota. Anche la polizia politica non fu esente da abbagli e false piste. Non così per Altiero Spinelli1, di cui si può innanzi tutto affermare che rappresenta, a buon diritto, l’opposizione intransigente al fascismo, dalla fondazione alla fine. I suoi ideali e la sua coerenza non vennero mai meno, neppure nei momenti in cui, come si verificò all’indomani della vittoriosa guerra d’Etiopia, il consenso parve soverchiare i pochi antifascisti militanti. Non rimase però un caso isolato; con lui altri personaggi, ormai entrati nella storia del Novecento: Gramsci, Lussu, Ernesto Rossi, i fratelli Carlo e Nello Rosselli, Nello Tarquandi, Giancarlo Pajetta, Sandro Pertini, Giorgio Amendola solo per citare qualche nome; oppositori fierissimi, che non vollero piegarsi alle dure regole del regime mussoliniano e non accettarono alcun compromesso.
Spinelli, nato a Roma il 31 agosto 1907, subì gli influssi del padre socialista almeno fino al 1921 quando, da studente, assisté a una manifestazione fascista, contestata da un giornale comunista. Probabilmente, nacque da qui la determinazione di cambiare e di mettersi al servizio dei comunisti, perché ritenne che essi fossero più combattivi rispetto agli altri e più disposti al sacrificio, compresi i socialisti. In linea generale le sue intuizioni si rivelarono fondate; aderì al partito nel 1924 (ma la polizia politica indicò sempre, nei verbali, il 1921), con il fascismo da due anni al potere e in clandestinità, ma non tardò a far parlare di sé e a entrare nelle mire della polizia in veste di «pericoloso sovversivo». Dopo il liceo, durante il quale approfondì molti argomenti dottrinari e sviluppò notevoli doti intellettuali, frequentò l’università rafforzando la propria militanza. Poi il cerchio si strinse e il 3 dicembre 1926, per «costituzione di associazione sovversiva», dalla Commissione provinciale di Roma venne condannato a cinque anni di confino. Si rese latitante; fu però arrestato a Milano il 3 giugno del 1927. Con lui, rimasero nella trappola altri compagni di fede: Giovanni Parodi, «denunciato per aver tentato con tutti i mezzi di ricostituire il disciolto Partito Comunista»; Arturo Vignotti «per complicità nel reato del Parodi». Vennero condotti al carcere di san Vittore in attesa di essere processati. A proposito di Spinelli si legge: «L’incaricato del movimento giovanile comunista era il noto Spinelli Altiero, che milita nel partito fin dal 1921, che abitò effettivamente in questo Corso Buenos Ayres sotto il falso nome di Giorgio Massari»2. Al tempo stesso, nella città di Ancona la polizia riuscì a catturare Battistina Pizzardo, appartenente all’organizzazione giovanile comunista, denunciata per «delitti contro la sicurezza dello Stato» e definita nei verbali «l’amante dello Spinelli»: subì la condanna a un anno. In effetti avevano da poco iniziato una relazione sentimentale, che si concluse durante la permanenza in carcere di Altiero. E se si riconobbe che i due processi – celebratisi a Roma – non avevano «alcuna connessione tra loro»3, si ritenne doverli unificare. Il 6 aprile 1928 il Tribunale speciale per la difesa dello Sato condannò Altiero Spinelli a 18 anni e otto mesi di reclusione «per delitti contro i poteri dello Stato»4, con pene minori per gli altri imputati. Si aprirono così per il ventenne «sovversivo» le porte del carcere, Regina Coeli, dove peraltro rimase pochissimo, per essere poi trasferito a Lucca fino al gennaio del 1931. E dal momento ancora non esisteva una sua scheda biografica, su ordine del capo della polizia Bocchini nel luglio 1928 gliel’approntarono. Si può leggere:
Riscuote nell’opinione pubblica buona fama. È di carattere serio; di buona educazione; intelligente e colto. È studente universitario e vive a carico della famiglia. Frequenta i compagni di fede. Non è in buoni rapporti con il padre. È iscritto al Partito Comunista; tenace organizzatore di giovani comunisti tra i quali ha ascendente. Si è sempre mantenuto in corrispondenza con i compagni di fede della Capitale. Non ha dimorato mai all’estero. Non risulta che abbia appartenuto ad associazioni di Mutuo Soccorso, né che abbia collaborato alla redazione di giornali. Ha sempre ricevuto e spedito giornali e stampe sovversive, facendo attiva propaganda tra studenti e operai. È capace di tenere conferenze, ma non ne ha mai tenute. Verso le autorità tiene un contegno indifferente. Ha sempre preso parte a tutte le manifestazioni di partito. A soddisfatta giustizia verrà tradotto in colonia5.
Nella prigione romana Spinelli secondo il punto di vista fascista non mostrò alcun segno di ravvedimento e la pena gli venne confermata in sedici anni e undici mesi, più tre anni di vigilanza speciale. E ancora da Regina Coeli, il 29 agosto 1928 dall’Ufficio politico investigativo della Milizia, diretta al ministero dell’Interno, partì un’allarmata lettera avente per oggetto il «comunista Spinelli», in cui si sostenne che lo stesso – adibito in carcere a mansioni di scopino – serviva «da collegamento con i detenuti di passaggio, affidando a essi la posta che poi è spedita clandestinamente»6. Ma la fonte fu ritenuta inattendibile. I detenuti a «disposizione del Tribunale Speciale, per ovvie ragioni, non sono ammessi per alcun motivo al lavoro», si legge nella risposta. Per sovrappiù, è scritto nella seconda parte, durante la sua permanenza «non dette luogo a rimarchi e non risulta affatto che egli abbia potuto servire da collegamento con i detenuti in transito»7. Invece, nel gennaio 1929, scontata la pena tornò a farsi udire Battistina Pizzardo, desiderosa di «ottenere un colloquio con il fidanzato in espiazione a Lucca, per risolvere de visu la situazione in cui ella è venuta a trovarsi»8. La pratica seguì un lungo iter – perché oltretutto con la condanna era giunta anche l’ammonizione e agli ammoniti detenuti non si concedevano colloqui – e Spinelli, nel frattempo, il 9 gennaio 1931 venne trasferito per la terza volta, che non fu neppure l’ultima: dopo Regina Coeli e Lucca conobbe il carcere di Viterbo9. Da qui presentò lui istanza «per avere corrispondenza e permesso di colloquio» con Battistina, spostatasi a Forlì in qualità di direttrice della Colonia permanente milanese, un’istituzione non fascista seppure gravitante nell’orbita del regime. Aveva dimostrato di non interessarsi più di politica e Spinelli dichiarò di volerla sposare, appena le circostanze lo avessero concesso. Il direttore del carcere non si oppose agli scambi epistolari e tuttavia, prima di autorizzarli, chiese parere alla polizia politica10. Che giunse favorevole il 30 aprile 1931, ma ebbe breve durata11: Spinelli fu sempre considerato, sul piano politico, «pericolosissimo» e irrecuperabile, capace di qualsiasi gesto. A complicare una situazione già compromessa arrivarono al direttore del carcere informazioni sulla famiglia del detenuto: risultò che il fratello Veniero professava idee comuniste e il padre Carlo era socialista schedato. Non trascorse molto tempo, neppure due mesi; Veniero fu arrestato il 28 giugno 1931 a Torino insieme a una decina di compagni, processato da Tribunale speciale, condannato a sei anni di reclusione proprio nel momento in cui venne concessa l’amnistia per il «Decennale della rivoluzione fascista»12. Ne usufruì; quanto al fratello occorreva raddoppiare la vigilanza e impedire, intanto, che potesse corrispondere con i congiunti, come aveva chiesto13. Non era tutto, perché nell’aprile del 1932 la questura di Forlì aveva «revisionato» una lettera spedita a Battistina da Veniero. Descriveva un colloquio avuto con Altiero, adesso nel carcere di Civitavecchia, sua ultima meta prima del confino: mostrava «di essere ancora di accesi sentimenti comunisti e di interessarsi delle questioni del partito». Dunque, un irriducibile da guardare a vista. E a giugno una seconda lettera, «scritta con inchiostro simpatico», era uscita da Civitavecchia diretta a «un noto centro comunista di Basilea: si chiedeva di far espatriare la Pizzardo e di affidarle mansioni politiche». Fu deciso di «sottoporla ai vincoli dell’ammonizione» e di vietare a Spinelli scambi epistolari con chicchessia14.
Le speranze degli oppositori – in carcere o a piede libero – per un cambiamento della situazione politica nel paese si ridussero fino a scomparire. Non è un caso che nelle relazioni mensili dei prefetti, che attingevano notizie dalle questure, dai carabinieri e da altri organismi, come gli uffici politici della Milizia nelle loro diramazioni (si erano costituite varie sedi, sparse per l’Italia, che raccoglievano schedari paralleli), alla voce «Ordine pubblico» comparisse sempre o quasi la seguente dicitura: «Nulla di importante da segnalare» e alla voce «Attività degli elementi contrari al regime» spesso si dichiarasse: «Nessun fatto di particolare rilievo riguardante l’attività di elementi sovversivi o comunque contrari al Regime si è verificato»15. È vero che la polizia politica non agiva alla luce del sole e poco trapelava; ma non c’è dubbio che proprio in quegli anni colse importanti risultati e in seguito, pur continuando l’attività, gli smantellamenti delle «centrai sovversive» diradarono. I detenuti per questo tipo di reato, che mirava a destabilizzare il potere costituito, avevano vita dura. Un’ora d’aria al giorno e nella migliore delle ipotesi, ventitré ore in cella senza parlare con alcuno, percosse e torture nei casi più «ostinati», colloqui con i parenti spiati e trascritti, corrispondenza scandagliata con meticolosità da burocrati speranzosi di scorgervi chissà quali macchinazioni, lunghe attese per conoscere l’esito di qualche domanda, sempre rigorosamente firmata, riguardante questioni familiari. Se, come nel caso di Spinelli, si scopriva che la condotta politica dei congiunti non era proprio irreprensibile e originava «rilievi» o semplici sospetti, non si derogava.
Anche dalla prefettura di Torino, città di cui Battistina Pizzardo era originaria, giunse alla polizia politica parere circa scambi di lettere tra la donna e Spinelli. Scrisse il prefetto di non ritenere «opportuno che il condannato in oggetto sia autorizzato a scambiare corrispondenza con la nota comunista prof. Pizzardo Battistina, in quanto costei risulta animata da accesi sentimenti so...